L’antico dialetto bolognese
Bacajèr a Bulåggna (parlare a Bologna).
Se il nonno e la nonna vogliono parlarsi in confidenza di cose delicate e personali, senza che i nipoti capiscano, debbono esprimersi in bolognese.
Qualche parola la sanno anche i figli più grandi. Se maschi, si tratta per lo più di espressioni irripetibili, se femmine si limitano a sottolinare i momenti di meraviglia, con un forte “sorbole”. I nipoti, quando parlano non hanno nemmeno più la “essce”.
E’ un patrimonio che è andato perso. Per questo mi piace ricordare, finchè ne ho memoria, alcuni detti ed alcune espressioni dialettali che ho sentito dire dai nonni e dai bisnonni, per un ricordo oltre che personale, anche di vita.
Ormai nella mia città, Bologna, tutti parlano italiano. Questa raccolta può sembrare un piccolo museo di “cose antiche”, ma cose che, comunque, conservano un loro fascino, un sentore di vita intima, talvolta anche di segreto che tiene legati tutti noi della famiglia.
Noi, nati qui, crediamo magari di non saperlo, pur applicandoci non riusciamo a mettere insieme decentemente un discorso, eppure lo abbiamo dentro, nel profondo dell’anima.
La sparizione del dialetto è avvenuta a poco a poco, senza che ce ne rendessimo conto.
Però nei dialoghi dei giocatori di carte dei circoli ARCI, dove trascorrono ore gli anziani, alcuni battibecchi ai mercatini, frasi raccolte per strada, il muratore che parla dall’impalcatura, i tifosi che discutono di calcio, a volte rivelano antiche bellissime espressioni dialettali, fiorite e scolpite come nel marmo.
Direi che il dialetto bolognese è uno stato d’animo ed è per questo che, sentito parlare, mi sorprende.
La battuta, una frase scherzosa, talora una parola soltanto sorge spontanea anche in me, come un ricordo dei nonni e dell’infanzia, delle persone care che non ho più.
Prima di cominciare a scrivere dell’antico dialetto bolognese, trascrivo alcune parole e modi di dire che, ancora oggi, si conservano e spesso fanno da intercalare, nel parlare “italiano”, del vero bolognese di oggi:
A Bologna…… così si dice anche oggi.
A Bologna, qualsiasi oggetto di cui non si trova il nome momentaneamente è un “bagaglio” o un “coso”
A Bologna non abbiamo i pantaloni, abbiamo le “braghe“
A Bologna,”Lu-lé e Li-là”, sembrano due personaggi dei cartoni animati, ma vuol solo dire “quello e quella”
A Bologna, quando non ci sta simpatica una persona pensiamo che è “proprio simpatico come un gatto attaccato ai maroni” : “L é prôpi sinpâtic cómm un gât tachè i marón”
A Bologna diciamo sempre no, con:”brîṡa”
E diciamo sempre, ” te lo dico io”: “A t al dégg”
Se c’è vento, “sóccia che buriana“
Se una persona mi piace, la “intorto“
A Bologna, un giovanotto ben vestito, ma un po’ irrigidito dall’abbigliamento, è un “milordino“
Dire della disperazione: “Se mi va bene questa volta, vado a San Luca a piedi”
L’indeterminatezza di un numero si indica con “ e ṡbliṡga”.
A Bologna, vedere le vecchiette che alla domanda del salumiere: “altro?” rispondono con: ” altro” .
A Bologna, non si gioca a nascondino, si gioca “a cucco“
A Bologna, non si lecca, ” si pilucca“
A Bologna non si spinge, si “cuccia“
A Bologna un grosso rospo è una “butarazza”
A Bologna non si dà uno schiaffo, si dà “una ṡbèrla“
A Bologna un cigolio è un “gnicco“
A Bologna uno scontro fra veicoli è fare un “ciocco” o una “inzuccata”
A Bologna, nel letto facciamo, “i covini“
A Bologna, non si è matti, si è “fuori dai coppi”
A Bologna, cosa facciamo? Andiamo o stiamo?. “csa faggna ? andaggna o staggna ? “
A Bologna, gli anziani non girano col bastone, girano con la “zanetta“
E non si inciampa…si “scapuzza“
A Bologna se uno è ricco non ha molti soldi, ma ha della “pilla“
A Bologna non ci si scontra, ci si “inzucca“.
A Bologna se sei pallido, sei “ṡbiavdo“
Se gli ormoni vanno a mille, abbiamo una gran “ṡverżura“
A Bologna, non si fa sesso, si “guzza”
Se ci metti molto ad esprimere un concetto, “sei lungo come la messa cantata“
Se mangiamo qualcosa difficile da inghiottire, “impaluga“!
A Bologna, non ci sporchiamo, ci “impadelliamo“
Se sei creativo, hai dello “sbuzzo“
Non sei rimbambito, sei un “ismito“
La “regina della casa” è solo lei, la “arzdåura“
A Bologna, non si inzuppa, si “toccia“
A Bologna, non c’è la polvere sotto i letti, ci sono i “gatti”
Se qualcosa è scarso o non di nostro gradimento, è “tristo”
Non si dice ‘cosa stai toccando’ ma … “cosa stai cipollando”
Se uno fa lo stupido, “ma non far l’asino”: “mo brîṡa fèr l’èsen“
A Bologna, le cose non ci piacciono “molto”, ma “dimondi“
A Bologna, non togliamo le cose, le “caviamo”
A Bologna, se uno ha un naso pronunciato, “sóccia che canâpia che ha lui-lì”
Se una cosa è difficile da realizzarsi, è più facile che Galvani volti pagina: “mo l é pió fâzil che Galvani al vôlta pagina“
A Bologna una persona non è antipatica, è “ṡgodevole”
A Bologna non si picchiano le persone, si “bussano”
A Bologna non abbiamo gli scarafaggi, abbiamo i “burdigoni“
Se un bambino ha fatto qualcosa che non va, gli si dà una gran “cioccata”
Se uno non vuole manifestare il suo pensiero e non dire direttamente ciò che pensa, “sta in camuffa“
A Bologna non si bara, si fanno i “ballottini“
A Bologna la malinconia derivata dall’inerzia è una “lórgna della Madonna“
A Bologna se uno non ha soldi ha una gran “plumma“
A Bologna non abbiamo il lievito, abbiamo la “dose”.
Se una cosa è difficile da digerire è “tamugna“
Se non si pagano gli acquisti, si piantano dei “puffi“
A Bologna una cosa che costa poco è una “bazza“
A Bologna i bambini che piagnucolano: “gnolano“
A Bologna non abbiamo il portafoglio, abbiamo il “catuvino“
A Bologna quando uno sternutisce gli si dice “bandéssa“
A Bologna, non si fanno i piccoli lavori di casa, si fanno i “ciappini“
Se non troviamo qualcosa, non cerchiamo, “ravaniamo“
A Bologna, quando uno vince una gara, gli ha “dato la paga“
A Bologna, ogni motivo è buono, per “far balotta“
A Bologna, i piatti si asciugano con il “burazzo”
A Bologna un forte acquazzone è uno “squasso“
A Bologna non abbiamo le coperte da letto, abbiamo “i panni“
A Bologna una persona non si ubriaca, ma “prende la balla“
A Bologna non siamo generosi, siamo “spanizzi“
A Bologna un frutto acerbo é “brusco“
A Bologna se una cosa o una persona hanno scarso valore, sono degli “ṡdòzzi“
A Bologna non si prende il raffreddore, lo si “busca“
A Bologna non si sfrega via una cosa rimasta attaccata, ma si “razza via”
Non diciamo mai “basta”, ma “bôna lé“
Quando fa freddo,”mo soc’mél che żâgno“! E se il freddo è tanto, uno “żâgno del 32”
A Bologna non abbiamo i capelli, abbiamo un gran “bulbo”
Non si disturba la gente, semplicemente, “si stracciano i maroni“
Non si ride, si “ghigna“
Quando indossiamo un abito nuovo, lo “spianiamo”
A Bologna un utensile da lavoro o attrezzo è un “osviglio”
A Bologna non abbiamo la brina, abbiamo la “guazza“
A Bologna non schiacciamo una zanzara o una cimice, la “squizziamo“.
A Bologna non stringiamo le cose, per esempio le mani per salutare, ma le “stricchiamo“.
Non diamo pugni in testa. diamo le “noci“
A Bologna, non ci demoralizziamo, “ci si scende la catena”
A Bologna, non si dice OK, si dice “A i ó capé”
A Bologna se una trottola gira si dice che “prilla“.
Quando una cosa non ci piace, diciamo: “moché, moché, moché“
Da ragazzini ci sentivamo dire dagli adulti/anziani: “io alla tua età saltavo i fossi per la lunga“: mé, a la tô etè, a saltèva i fôs par la lónga”
A Bologna, non abbiamo il pattume, abbiamo il “rusco“
Non andiamo forte, andiamo “a busso”
A Bologna non si mastica, ma si “biasica“
Non ci riposiamo davanti alla tele, ci “polleggiamo”
I bambini, i “cinni” li mandiamo all’”esilo”
A Bologna non diciamo “aprimi la porta”, ma “dammi il tiro”
Quando uno/a ti attacca un bottone infinito, ti pianta una gran “tomella”
A Bologna, non ci sono belle ragazze, ci sono solo “ delle gran belle gnocche“.
E adesso provo col dialetto antico.
(Nota importante: La scrittura del dialetto bolognese di questi brevi capitoli è stata corretta e supervisionata dal Signor Luigi Lepri e dal Signor Amos Lelli (purtroppo di recente scomparso). Ringrazio di cuore. Grazie davvero).
Ogni capitoletto spiega i modi di dire in dialetto bolognese, con metafore ed espressioni tipiche del bolognese vero, d’un tempo.
♣ ♥
PANZA
(Tradotto, significa pancia)
Due comari stanno litigando. Il dialogare è fitto e a voce alta, ed è tutto da godere. Liti così hanno ispirato i dialoghi di Testoni. D’improvviso, una delle due, alzando – se possibile – ancora più la voce, sbotta in una sequela di offese atroci, coinvolgendo nella filippica i parenti vicini e lontani dell’altra. Poi, mentre la rivale sta ancora cercando il fiato per replicare, conclude sollevata: «Oh, adès ch’ai ò arṡintè la bughê a stâg méi» (che significa: ora che ho sciacquato il bucato sto meglio. Lavare i panni, significa dire quello che si pensa, mettere bene in chiaro le cose). Oppure aggiungeva: «A stèr zétta a m srêv nèd un âlber int la panza» (a stare zitta mi sarebbe nato un albero nella pancia).
Un proverbio molto ripetuto, anche attualmente: «Pânza péṅna la n sà ed cla vûda» (la pancia piena non sa di quella vuota, chi è ricco non conosce la situazione del povero, chi ha tanto non vede chi non ha niente e così via).
♣ ♥
MLÅN
(Melone)
Per dire che le cose non si debbono giudicare con faciloneria in bolognese; «A n s nèṡa brîṡa i mlón da stèr int l’èra» (non si annusano i meloni stando nell’aia, lontano). Il detto è efficace, ma ancor più lo è «a òc’ as chèga» (a occhio, cioè a caso, si va al gabinetto).
♣ ♥
PATAJÔLA
(Camiciola)
Sui vecchi album di fotografie si vedono i bambini ritratti con una camiciola lunga che arriva fino ai piedi. Quella è «la patajôla» (la camiciola, oppure la parte terminale della camicia da uomo).
«Purtèr la patajôla fòra däl brèg» (portare la camicia fuori dai pantaloni) significa essere ancora bambini.
Di solito la frase è usata in tono polemico. Diceva l’esperto artigiano «quand mé a lavurèva in ufizéṅna, te t purtèv anc la patajôla fòra dal brèg» (quando io lavoravo in officina, tu portavi ancora la camiciola). Vuol dire che lui era già un operaio provetto, quando l’altro era ancora un bambino.
♣ ♥
CHE SPETÂCUEL
(Che spettacolo)
Per indicare un subisso di cose si diceva «spetâcuel d côs». Per indicare qualunque cosa che colpisca particolarmente, per esempio Sophia Loren (con entusiasmo) è uno «spetâcuel ed dòna» (uno spettacolo di donna). Per indicare un bravo giocatore di pallone «spetâcuel ed żugadåur da balån». Un bravo cantante, soprattutto lirico: «al canta ch l é un spetâcuel» (canta che è uno spettacolo). Di un bravo cuoco che sa fare dei buoni tortellini si dice che quei tortellini sono uno spettacolo «ch’i én un spetâcuel».
Una parola quindi che viene usata per manifestare ammirazione, compiacimento, entusiasmo,
E’ sufficiente però aggiungere “bello” che il significato cambia completamente. Il bolognese dice con tono un po’ schifato «l é pròpi un bêl spetâcuel», per esempio, una strada poco pulita, o una ragazza truccata pesantemente.
♣ ♥
TÅSS E AMÅUR
(Tosse e amore)
La tosse e l’amore sono due cose che non si possono nascondere. I segni dell’amore sono inequivocabili; sguardo sperduto nel vuoto, il desiderio di isolarsi per pensare liberamente alla persona amata, la mancanza d’appetito. Anche se lo sguardo, oggi, si può nascondere dietro una bella banda di capelli o la mancanza di appetito può passare per una dieta, i segni d’amore sono come la tosse, non si possono nascondere: «l amåur e la tåss prèst s acgnóss» (l’amore e la tosse si conoscono subito).
♣ ♥
NÊS
(Naso)
«Avair sèt bûs int al nêṡ»: avere sette buchi nel naso, significa essere prudenti e accorti.
Nel dopoguerra un settimanale satirico milanese inventò un omino con tre buchi nel naso. Al settimanale sembrò una trovata magnifica, ma per coloro che non erano della stessa idea politica, l’omino con tre buchi nel naso delle vignette assunse un chiaro significato offensivo.
Ma se tre buchi nel naso costituiscono un’offesa, sette buchi, almeno a Bologna, sono un elogio.
«Avair sèt bûs int al nêṡ» (avere sette buchi nel naso) significa avere intuito, intelligenza e capire bene come stanno le cose.
Per circolare in auto, con tanto traffico come oggi, ci vogliono sette buchi nel naso. Forse, adesso più che mai, per capire cosa si nasconde dietro certa politica, è necessario «avair sèt bûs int al nêṡ».
♣ ♥
BIAVATI
Si chiamava Biavati, un signore che al tempo del fascismo viveva vendendo lamette in piazzola a Bologna. Era un fine satirico e a suo modo, da bravo bolognese, diceva la sua ai capi di allora. E non era facile a quei tempi!
In occasione di manifestazioni del fascio o della visita di personalità del PNF (partito nazionale fascista) «I al tulêven só», cioè lo arrestavano per il tempo necessario per impedirgli di fare “i suoi numeri”.
C’era una storiella che soleva raccontare:
«I an dezîṡ ed canbièr nómm a via Rizòli. E cum la ciâmni? Via Musolîni.
I an dezîṡ ed canbièr nómm a via Żambôni. E cum la ciâmni? Via Hitler.
I an dezîṡ ed canbièr nómm a via Indipendänza. E cum la ciâmni? Vîa tótt e dû !!!»
(Hanno deciso di cambiare nome a via Rizzoli. E come la chiamano? Via Mussolini.
Hanno deciso di cambiare nome a via Zamboni. E come la chiamano? Via Hitler.
Hanno deciso di cambiare nome a via Indipendenza. E come la chiamano? Via tutti e due!!!)
Famosa è rimasta una sua frase sulle sanzioni inflitte all’Italia al tempo del fascismo: “Se gli Inglesi hanno le bistecche, noi abbiamo i limoni. Siamo pari: «Se i ing-lîṡ i an äl bistàcc, nuèter avän i limón. A sän pèra!» Oppure: «Låur i an sé äl bistàcc, mó nuèter avän i limón, e äl bistàcc sänza limón el n én brîṡa bôni» (Loro hanno sì le bistecche, ma noi abbiamo i limoni, e le bistecche senza limone non sono buone). La battuta corse per la città e la gente diceva: «Lâsa pûr ch’la dégga Radio Londra, mó nuèter avän i limón» (Lascia pure che dica Radio Londra, ma noi abbiamo i limoni).
(Grazie ad Amos Lelli)
♣ ♥
BRÔD D ÔCA
(Brodo d’oca)
In italiano si dice darla a bere; in bolognese «fèr bàvver al brôd d ôca» (fare bere il brodo d’oca). Il brodo d’oca è grasso e poco gustoso e berlo è sinonimo di chi crede alle frottole dei furbi o dà credito alle chiacchiere.
Un tempo era in voga una burla piuttosto sciocca a Bologna. Alcuni buontemponi si piantavano in mezzo alla strada a guardare intensamente la cima della torre degli Asinelli. Immancabilmente quel gesto faceva alzare la testa a tantissima gente che si radunava e cercava di capire. Tutta gente che si lasciava indurre con facilità «a bàvver al brôd d ôca», appunto.
♣ ♥
PIGHÈR I USVÉI
(Tradotto significa: deporre gli utensili)
I nonni parlavano spesso della morte, senza mai nominarla. Sedevano su una panchina con altri anziani, mentre noi bambini giocavamo. Per prender fiato, dopo tanto correre, finivamo col riposarci vicino a loro ed ascoltavamo i loro discorsi.
Pur parlando di morti, non nominavano mai la morte, usavano perifrasi particolari, come un linguaggio fra iniziati.
Quando uno moriva dicevano: «L à pighè i uṡvei” oppure «L à pighè i tvajû» (Ha piegato i tovaglioli).
Quel modo particolare di dire che uno era morto, racchiudeva in sé un significato etico, dava il senso di chi lascia il mondo in pace con se stesso e con gli altri, dopo aver compiuto onestamente il cammino terreno. Come se, mettere in ordine gli arnesi, o piegare i tovaglioli, volesse dire lasciare il mondo ordinato, come così come l’avevano trovato e ricevuto dagli altri.
L’artigiano, finito il lavoro della giornata, deponeva con ordine gli arnesi e se ne andava a casa: «Ai ò pighè i uṡvéi e adès a vâg a cà» (ho riposto gli arnesi, ora vado a casa).
Non ci si ribellava alla morte, era un fatto naturale, come mangiare, amare, dormire, certo, meglio il più tardi possibile, ma ognuno la metteva in conto, forse per questo se ne parlava alla buona, familiarmente, perfino con una certa irriverenza.
Nello spettacolo dei burattini, Fagiolino, nel sotterraneo del castello incantato, l’affrontava senza timore e la rasava con cura. «Come – diceva la morte – non hai paura di me?» Rispondeva Fagiolino: «Mé nå, quand ai ò bvó dal bån vén a n ò pôra gnanc dal dièvel» (Io no, quando ho bevuto del buon vino non ho paura neppure del diavolo). E aggiungeva: «Chèra Chichéṅna, fâm pûr al piaṡirén ed stèrum luntàn, con totti chegli òs» (Cara Checchina, fammi il piacere di starmi lontano con tutte quelle ossa).
Oggi si usa solo la parola “morire” e così sono spariti a poco a poco tutti i vecchi detti.
In bolognese morire si dice «Murîr» oppure «Carpèr» (crepare) o «Stiupèr» (scoppiare)
Ma un tempo si usava «Andèr da Brèṡa». Raffaele Brasa fu per molti anni fu il custode del cimitero. Si racconta che, durante un’epidemia di colera, nel 1885, stanco per il gran lavoro, una notte si addormentò, disteso per terra, con la testa piegata sul petto. I becchini, nella confusione lo afferrarono per le gambe e le braccia. Ma Brasa li fermò prima che lo deponessero nella grande fossa. «Pian, pian, ragâz – disse – par mé l é anc prèst» (Piano, piano, ragazzi, per me è ancora presto).
Questo verbo «Murîr» (morire) possiede nel dialetto bolognese un vasto numero di sinonimi : «Andèr al gabariòt» (andare al gabriotto). Il gabriotto era un’antica cella dove i carcerati morivano facilmente, oppure secondo altri autori, il “gabariotto” era il diminutivo di gabarra, nave a vela adibita al trasporto di prigionieri.
«Vultèr la panza in só» (voltare la pancia in su); «Andèr par d là» (andare di là); «Andèr da Brèṡa» (andare da Brasa, il custode del cimitero); «Ciapèr la caròza ed Gulfîr» (prendere la carrozza delle pompe funebri Golfieri, molto note a Bologna); «Andèr con äl ganb pr âria» (andare a gambe all’aria); «Parżèr i pî» (pareggiare i piedi): «Andèr fòra dal óss coi pî al inànz» (andare fuori dalla porta con i piedi in avanti); «Andèr a fèrs bandîr» (andare a farsi benedire); «Andèr ala bûṡa» (andare alla buca); «Ṡbâter egli èli» (battere le ali, come il pollo quando gli si tira il collo); «Dṡmétter ed tirèr al fiè”» (smettere di respirare); «Avanzèr dûr» (rimanere duro); «Vulèr in zîl» (volare in cielo); «Andèr al creatåur» (andare al creatore); «Tirèr i ûltum» (esalare gli ultimi respiri); «Fèr fagôt» (fare fagotto); «Andèr a guardèr l’êrba dala pèrt del radîṡ» (andare a guardare l’erba dalla parte delle radici).
Alcune frasi e proverbi sono molto originali: per esempio, di uno che era in punto di morte si diceva: «L à un pà int la bûsa» (ormai ha un piede nella fossa).
Altre espressioni come: «Lasères murîr l ànżel in man» (lasciarsi morire con l’angelo in mano – dal gioco dei tarocchi – significa lasciarsi sfuggire un’ottima occasione); «Murîr con al mazôl dla bått in man» (Morire con il mazzuolo della botte in mano), significa “morire vergine” e paragona la perdita della verginità femminile al momento nel quale, con un colpo di mazzuolo, si infila la spina nella botte per spillare il vino nuovo.
Un proverbio suggestivo su questo tema: «Méi murîr un brótt vèc’ che un bèl żåuven» (meglio morire da brutto vecchio che da bel giovane).
♣ ♥
STÈR INT L’ASÀ
«Stèr int l’aṡà» (stare nell’aceto)
E’ un modo di dire di qualcuno che sta con l’animo sospeso in attesa di qualche cosa che non arriva o che, per ripicca, non viene concessa.
Il ragazzo che attende l’esito degli esami, oppure il giovane innamorato che attende un sì dalla ragazza, o chi aspetta una notizia che non arriva: «Al sta int l’aṡà» (è immerso nell’aceto dell’attesa).
L’esclamazione «Al stà int l’aṡà, ló (o la stà int l’aṡà, lî)» ( è immerso nell’aceto, lui o lei, è un’esclamazione carica di malignità di chi, per ripicca, lascia insoddisfatta, pur senza dire esplicitamente no, la richiesta di una persona che non gli è simpatica o con la quale è arrabbiato,
♣ ♥
L É LÉ, LÓ
«L é lé, ló» ( Lui è lì, o lui sta lì)
E’ uno dei tanti scioglilingua del dialetto bolognese, difficili da pronunciare.
Ci si divertiva a ripeterli finché la lingua non ci si inceppava e il tutto finiva in una risata.
E’ impossibile pronunciare questo scioglilingua in dialetto senza incepparsi; quell’uscio ha le assi lisce. «Cl óss l à eli âs léssi». Ed è uno dei più semplici.
Si può provare a pronunciare, in fretta magari: «Sei tu che eri lì?, io batto e tu non tiri»: «Ît té ch’ t er lé? Me a bât e té t an tîr». Oppure dove c’è lui, c’è anche lei: «Ló l é lé; lî l é lé», o ancora: lui ha lei e lei ha lui: «Ló l à lî e lî l à ló». Difficilissimo non impappinarsi nel dire:«Dì loro se sanno che sono Cassiano» «Dîi s’i san ch’a sån Casiàn».
Tra i più belli: tirati in qua che non t’inciampi nel filo di tela, tirati in là che non t’inciampi nel telaio «Tîrt in zà ch’t an t intrîg int al téi, tîrt in là ch’ t an t inzànpl int al tlèr». Oppure: che bei capelli che avete, voglio che ve li leviate «Che bî cavî ch’avî, a vói ch’a v i cavèdi vî». Sono frasi senza senso, si tratta solo di giochi di parole.
♣ ♥
ATACHÈR BUTÂZ
(E’ intraducibile, significa “spettegolare”)
«Al butâz dal òli» era un piccolo vaso di terracotta verniciata o di metallo, con un becchetto, nel quale si teneva l’olio per le lucerne.
Si crede che l’origine di questo modo di dire, come dice Giuseppe Maria Buini nel settecentesco Bertuldin Dalla Zena, derivi dall’abitudine delle domestiche, che andando a comprare l’olio in un vaso che noi chiamiamo “bottazzo” (italianizzando la parola) e trovando nella bottega altre domestiche, cominciavano a spettegolare, prima a proposito dell’olio e del bottazzo e poi mettendovi dentro tutti i fatti, tutti i segreti dei loro padroni. Ovviamente con grande piacere per chi stava ad ascoltare.
Per questo la padrona di casa, quando mandava la domestica a fare delle commissione, le porgeva la lista e si raccomandava di non cominciare a spettegolare: «brîṡa atachèr butâz».
Ora, signore anziane che mandano a fare la spesa la propria domestica, forse non ce ne sono più, ma quand’anche ce ne fossero e la signora dicesse «brîṡa atachèr butâz», la domestica o la colf (peggio ancora) non capirebbe.
♣ ♥
STÓPPID E PÒ STÉMMET
(Stupido e poi datti delle arie)
Un esempio del modo sorridente, quasi cordiale di offendere atrocemente il prossimo. Di un uomo non molto sveglio in italiano si dice che è sciocco o che è scemo.
Ma la parola scemo può sembrare intraducibile in dialetto, tanto che si usa generalmente la parola in italiano: «L é un pôver sêmo», mentre «siòc» ha in genere soltanto un significato di affettuoso rimbrotto. La ragazza dice «siòc» al giovane che la corteggia un po’ audacemente.
Ma al petroniano non mancano certamente le parole per esprimere un adeguato apprezzamento. Si può scegliere fra i vari: «bazurlån», «baciócc», «barbażâgn», «bagianâz», «banbòz», «patalócc», «minciån», «inṡmé», «ucaròt», «zucån», «mamalócc».
Ma l’ingiuria più geniale e proprio: «stóppid e pò stémmet», come dire: datti delle arie se ti tratto solo da stupido, frase che solitamente viene pronunciata in tono di benevolo compiacimento. Il che la rende, per quanto possibile, ancora più feroce.
♣ ♥
PACIÛG
(Fanghiglia, fango, mota)
«Cèr cómm al paciûg», ossia “chiaro come la fanghiglia”. Succede quando si discute di cose un po’ noiose come la politica e magari si parla in politichese.
«Perché, vede» dice uno «la ragione vera …» e giù un lunghissimo sproloquio che si conclude con una solenne : «Chiaro?»
«Sé» risponde l’altro imperturbato «cèr cómm al paciûg» chiaro come il fango.
Con questa battuta e con un tono un po’ sdegnato: «Ma con lei non è possibile parlare seriamente», si concludono spesso le discussioni fra bolognesi.
A volte dicono anche che una cosa è chiara «cme l’âcua di macarón”», come l’acqua di cottura dei maccheroni.
♣ ♥
TENTINBRÎGA
(Intraducibile in italiano, significa scansafatiche, pigro, indolente, voglia di non far niente, fannullone)
Un tempo la vita del «cinno» (ragazzo) di bottega era piuttosto dura: si doveva imparare il mestiere anche a suon di scapaccioni. Il burbero principale non ne perdonava una. Era un continuo gridare, un continuo imprecare: «Mo dâi, sumâr!» (Su via somaro!). «Fôrza, ignurànt con l’arvajja!» (Forza, ignorante coi piselli!). «Só, môvet, inṡmé!» (Su muoviti, tonto!). «Avérra i ûc’, patalócc!» (Apri gli occhi rimbambito!).
Il principale era un barbiere che si chiamava Leonida, aveva un ragazzo di bottega non molto sveglio che, come molti fattorini di barbiere, studiava mandolino. Strimpellava nel retrobottega e, quando Leonida, che aveva una vocina tutta «leccata» come la testa dei suoi clienti dopo alcuni energici massaggi con la spazzola a rullo, lo chiamava, fingeva di non sentire. Allora il barbiere faceva due urli tenorili e quando il ragazzo spuntava da dietro la tenda, esclamava: «Dí só, tentinbrÎga, t vût môver?» (Dimmi, scansafatiche, ti vuoi muovere?).
Si diceva spesso per rendere l’idea:
«Tentinbrîga, vût dal brôd?» (Vuoi del brodo?)
«Sé, mâma» (sì, mamma)
«Alåura venl a tôr» (allora vienilo a prendere)
«A n al vói pió» (non lo voglio più).
A chi non lavora, si dice anche: «cus’èt pòra d infièret äl man?» (hai paura che ti si gonfino le mani?).
♣ ♥
AVAIR DLA RÈNA
(Tradotto: Avere della rana)
In italiano significa essere al verde o in bolletta, non avere il becco di un quattrino.
Sull’origine del detto anche i linguisti più esperti offrono solo congetture, ragion per cui si preferisce, in qualche modo, non entrare nel merito. Però la rana non bisogna prenderla nel senso di miseria assoluta, ma per indicare coloro che si vogliono dare del tono, senza averne i mezzi, i «sòlit milurdén in bulatta» (i soliti piccoli milord in bolletta).
E’ stato detto che forse il vocabolo derivava dal rumore che fanno due baiocchi (allora c’erano ancora i baiocchi) quando venivano sfregati l’uno con l’altro, il suono assomiglia al gracidare di un ranocchio, e così ne derivò che “hai la rana”, significa che uno possiede solo due baiocchi.
Ma l’ipotesi migliore da cui deriva il detto «Avair la rèna» deriva dal fatto che, mangiando questi anfibi, si trova poca polpa, sono bestiole elettronervose che non saziamo molto. E così, dicendo rana, si dice che: «a n i é gnínt da magnèr» (non c’è nulla da magiare). Un’altra versione si riferisce al colore della rana per sinonimo di “essere al verde”.
Chi ha della rana dice anche: «a n in ò ón ch’al s inzócca in cl èter» (non ne ho uno che si scontri con l’altro); oppure: «a n in ò né d pésst né da pistèr» (non ne ho né di pesto né da pestare).
♣ ♥
CLA DÒNA
(Quella donna)
Lui è un bel tipo di contadino: baffi folti, un cappellaccio a tesa larga, la capparella(*) sulle spalle. Si alza dal tavolo dell’osteria, saluta gli amici e dice: «A se vdrän, a vâg da cla dôna ch’ai ó a cà» (Arrivederci, vado da quella donna che ho a casa). Quella donna che ha a casa è sua moglie.
Usava dir così «cla dòna». Qualcuno diceva: «Cla bîstia» (quella bestia). Altri, scherzosamente, dicevano: «Al sacramänt» (il sacramento). Forse era un assurdo senso di superiorità nei riguardi delle donne. Ma, in modo più veritiero, era solo timidezza e pudore: nessuno, in campagna e fra il popolino, si azzardava a dire: mia moglie in pubblico. Anzi, accennando a «cla dòna», abbassavano la voce, quasi pronunciassero una parola “sconveniente”.
(*) La capparella era un mantello, tipo tabarro, senza maniche, che gli uomini hanno indossato fino negli anni 50-60, nei paesi più poveri. Gli uomini non usavano il cappotto, che era riservato ai ricchi.
♣ ♥
SCÛSUM
(Scusami)
«L é l istàss che dîr scûṡum» (è lo stesso che dire scusami). Due stanno contrattando al mercato, ma non si trovano d’accordo. Uno chiede troppo, l’altro offre poco. Discutono da mezz’ora quando quello che deve vendere, seccato per un’offerta a suo parere ancora troppo esigua, salta su a dire inviperito: «Oh, mo alåura l é l istàss che dîr scûṡum» (Allora è lo stesso che dire scusami).
Lui intende dire che quella offerta così bassa ha lo scopo di interrompere le trattative: è come se l’altro avesse detto: “scusami, ma non se ne fa niente”.
♣ ♥
ÈSEN
(Asino)
«Fèr l èṡen pr an paghèr al dâzi» Fare l’asino per non pagare il dazio.
Un tempo i dazieri erano sentinelle implacabili, piazzati alle porte della città, sorvegliavano tutto e tutti, e ogni gonfiore sospetto sotto la veste, sotto una giacca o sotto la capparella, ogni valigia, o sporta, o borsa, ogni carico di biroccino li faceva scattare implacabili:«Qualcosa da dichiarare?»
Un giorno dermarono un tale che aveva la capparella stranamente rigonfia.
Disse il daziere: «Che cos’ha lì sotto?»
«Lì sotto?» domandò l’uomo con aria leggermente tonta.
«Sì, lì sotto, sotto la capparella».
«Sotto la capparella? Cosa c’è sotto la capparella?».
Il daziere continuò per un poco a fare domande, poi si seccò: «Åu» disse «ch’al sénta bän al mî umarèl: al l à da piantèr ed fèr l èṡen pr an paghèr al dâzi». (Oh, ascolti bene ometto mio, la deve smettere di fare l’asino per non pagare il dazio).
Da allora, sempre che la storiella risponda a verità, di un finto tonto si disse che faceva l’asino per non pagare il dazio. Certo è che il tributo era dovuto per le carni macellate e non per quelle vive. Per cui “fare l’asino vivo” significava metaforicamente voler evadere il dazio.
♣ ♥
RUSÈRI
(Rosario)
La moglie fa molti complimenti al marito, ma gli fa trovare spesso il desinare piuttosto modesto. Allora lui, seccato, esclama :«Óh, sént, còca: manc ruṡèri e pió macarón!» (Ascoltami cara, meno rosari e più maccheroni).
Il detto trae origini da una vecchia storiella. Due imbianchini stanno lavorando in un convento e sono seccati perché, all’ora di pranzo, abbondano le preghiere e scarseggia il cibo. Un giorno il padre guardiano chiede se sono soddisfatti del trattamento.
«Ói!» rispondono «l’andrêv méi se ai fóss mänc ruṡèri e pió macarón» (Be!, andrebbe meglio se ci fossero meno rosari e più maccheroni).
♣ ♥
DÍ BÄN SÓ, FANTÈSMA
(Dimmi dunque, fantasma)
È il detto bolognese più noto fuori dalla mura cittadine. Siamo alla fine dell’Ottocento. Al teatro del Corso il famoso illusionista Pickmann – altri cronisti dicono si chiamasse Vatry – sta conducendo uno dei suoi esperimenti. «Adesso» dice l’interprete «il professore evocherà l’anima di un trapassato e i signori del pubblico potranno rivolgergli qualunque domanda».
Un attimo di profondo silenzio, poi una voce dal loggione grida: «Dí bän só, fantèṡma, l èt mâi ciapè int al cûl?» (Racconta, fantasma, l’hai mai preso nel culo?)
Il professor Pickmann, o comunque si chiamasse, non è mai più venuto a Bologna.
♣ ♥
SPIANÈR
(Spianare, si dice ancora oggi per significare che si mette un abito per la prima volta)
«Spianèr un vstièri» (Spianare un vestito)
L’espressione sfida il tempo, seppure italianizzata: ancora oggi si dice a Bologna spianare un vestito, spianare le scarpe: persino spianare l’automobile. Spianare significa mettere un indumento per la prima volta o per la prima volta servirsi di un oggetto.
Da cosa derivi non si sa. Tuttavia un avvertimento è d’obbligo. Se un bolognese vi dicesse che vuole spianarvi «äl cuṡdûr», (le cuciture), diffidate perché in dialetto ciò non significa inaugurare le cuciture, ma prendervi a bastonate.
♣ ♥
FÂM
(Fame)
«Èser pén ed vudâm» (essere pieno di vuoto)
Forse questa frase l’ha inventata Fagiolino, che sulla fame e sulla languidezza di stomaco, sull’acquolina in bocca, ne aveva sempre delle nuove da tirar fuori,
Dice: «Èt magnè incû?» Hai mangiato oggi?
E l’altro:« Eh, altroché: a sän pén ed vudäm».
Detta così può anche passare per una battuta divertente. Ma chi ha provato la fame vera (non la languidezza degli pseudonimi per conservare la linea), conosce certamente la sensazione dolorosa che attanaglia lo stomaco: una vera e propria materializzazione del vuoto.
Chi ha «Al ståmmg pén ed vudâm», adora, come si conviene, quello che un tempo veniva chiamato «Al dio pagnòta» (il dio pagnotta).
“Chi an n avéva ón ch’s inzuchéss in cl èter» (Chi non ne aveva uno – un soldo – che si inzuccasse nell’altro) trovava ogni sera «Al gât int al fûg» (il gatto nel fuoco), che era segno di miseria: se il gatto vi poteva sonnecchiare sopra significava che il focolare era spento.
Si diceva: «In cà nòstra, la zanna la litîga con al dṡnèr» (In casa nostra la cena litiga col il pranzo) (che è anche un detto italiano), oppure «A magnän al pan con al brîṡsel» (mangiamo il pane con le briciole come companatico). Perciò erano molti coloro che sospiravano: «A m câsca äl budèl dala fâm» (mi cadono le budella dalla fame), o «A n i vàdd lómm dala fâm» (non ci vedo dalla fame), o «Ai ó la budèla dàl låuv che a magnarêv i sâs» (ho le budella del lupo (una gran fame), che mangerei i sassi), o addirittura «A bujarêv al dièvel par båvver al brôd» (bollirei il diavolo per berne il brodo), o anche «A magnarêv i purtón dl infêren» (mangerei i portoni dell’inferno).
Non occorreva, insomma, alla maggior parte dei bolognesi, l’aperitivo per «métter in ṡvarżûra al stâmmg» (per mettere in eccitazione lo stomaco).
E pensare che c’era gente «Ch’la lighèva i can con la susézza» (che legava i cani con la salciccia). Che aveva cibi «Par castîg» (per castigo), che mangiava «A strazabisâca» (a stracciatasca, a crepapelle). Gente «Ch’l’avèva al ståmmg sänza memòria» (aveva lo stomaco senza memoria, cioè mangiava continuamente).
«Mah!» sospiravano i poveri andando a letto «Ai è chi mâgna da stróppi» (c’è chi mangia da storpio) e chi come me che «al s acuntänta dl’âria dla fnèstra» (si accontenta dell’aria della finestra).
La polenta, questa sera, «La n m à gnanc tuchè un dänt» (non mi ha neppure toccato un dente).
♣ ♥
ZIVÅLLA
(Cipolla)
«Dâi, dâi, la zivålla dvänta âi» (dai, dai, la cipolla diventa aglio)
Il significato è controverso.
Quando si andava a scuola e qualche materia non voleva entrarci in testa, la nonna interveniva incoraggiandoci. «Insisti» diceva perché «dâi, dâi, la zivålla dvänta âi».Intendeva dire che con la costanza qualunque cosa riesce.
Ma forse interpretò meglio il significato dell’espressione, una donnetta del popolo che se ne servì nel corso di una lite originata probabilmente da futili motivi. Riteneva di essere stata ingiustamente accusata da un coinquilina di qualche scorrettezza.
L’altra si difendeva sostenendo che le sue parole erano state male interpretate.
«Bän, insomma, interpretata bene o male lei la deve smettere di parlare di me perché anche se sono a posto con la coscienza e non ho paura delle maldicenze, dâi, dâi, la zivålla dvänta âi» . Voleva dire, cioè, che a forza di ripeterle anche le cose inventate possono alla fine essere credute vere.
♣ ♥
GIÓGGLIA
(Giulia)
«T î dî Giógglia, té» (Lo chiami Giulia, tu?). Uno si accorge che una cosa è diversa da come gli è stata presentata, allora esclama: «T î dî Giógglia, té?». Cioè: «Ti pare poco?».
Le origini del detto, come spesso accade, sono incerte. Riportiamo qui una poesiola pubblicata in “Ehi! Ch’al scusa” nel 1884 (mantenendo l’antica e superata grafia originale):
«Un dé Pirula al déss a la Ruséina: – A vag stasira vî col sgnèr Aldvich, in campagna da ló, mó saul dmatéina a taurn a cà, vgnand a Bulägna sigh – Sé, va pur là, Pirén, va pur dòv t’vû – la Ruséina l’arspaus a so maré – e sicóm an sän brisa in cà tót dú, a tói la Giôlia a lèt stanót con mé. – Mó anzi, tu pur tigh la ragazóla, acsé la pól fèr bóna cumpagnî – Pó, dap chl’avé basè muièr e fióla, cuntänt e chiét Pirén al s’n’andó vî. Pr’una causa ch’an só brisa prézis, al sté a Bulägna; e ‘l s’pers fòra un puchtén, mó quand fó mezanót, al s’n’in désiz d’andèr a lèt a fèr un quèlch pislén. Cantand e stufland l’andé a cà drétt e con la cièv l’avérs la pórta e l’óss, mai cardand che a rubèrî i su dirét in tla só stanzia qualch d’ón ètr ai fóss. Ma la muièr truvò tóta confusa e un òmn al vést ch’a i era al póst sô d’ló. Arabé alaura al s’rivulzé a la spausa: – Ah, ti dî Giôlia té a lu lé? – disó!»
( Un giorno Pietro disse alla Rosina: – Questa sera andrò via con il signor Ludovico, in campagna da lui, e solo domattina torno a casa, venendo a Bologna con lui. – Sì va pure Pierino, va dove vuoi – rispose la Rosina a suo marito – e siccome non siamo a casa tutti e due prendo la Giulia a letto stanotte con me. – Certo, anzi, prendi pure con te la bambina, così ti può fare buona compagnia. – Poi, dopo aver baciato la moglie e la figlia, contento e tranquillo Pierino se ne andò via. Per una causa che non so bene di preciso, stette a Bologna, e si perse un po’ fuori, ma quando fu mezzanotte si decise di andare a letto a fare un qualche pisolino. Cantando e fischiando andò a casa direttamente e con la chiave aprì la porta e l’uscio, mai credendo che a rubare il suo diritto nella sua stanza ci fosse qualcun altro. Trovò la moglie tutta confusa e vide un uomo al posto suo. Arrabbiato allora si rivolse alla sua sposa : “Ah, lo chiami Giulia, tu, questo qui”? Parla!»
♣ ♥
MÔRT INBARIÈGA
(Morte ubriaca)
I bolognesi sono bonari, paciocconi, inclini alla facezia più che alla satira. Però bisogna andarci piano, altrimenti si corre il rischio di qualche sorpresa. Ci si aspetta di essere vellicati piacevolmente da una battutina e invece ci si può sentire trafitti.
Come deve sentirsi trafitto l’uomo che appena uscito dall’ospedale o da una malattia si sente paragonato alla morte ubriaca: «T um pèr la môrt inbarièga» (sembri la morte ubriaca).
L’immensa cattiveria che i bolognesi mascherano sotto il sorriso è rivelata dalle cento e cento geniali, ma crudeli, definizioni dei difetti fisici del prossimo.
Un uomo molto piccolo «al pèr un bufarlòt» (sembra un pappatacio) o «un schinchiôl» cioè una zampa di vitello, o addirittura «un scramlézz», cioè un brivido (ma «scramlézz» significa anche ribrezzo, raccapriccio).
L’esiguità delle membra è però spesso accompagnata da un carattere particolarmente aggressivo. Si dice allora che il tale è «un umarén dal pàvver» (un omarino del pepe) o «ch’l é cén mó calcadén» (che è piccolo ma consistente).
Un uomo in cattiva salute viene paragonato non solo a «la môrt inbarièga», ma anche «ala môrt inramè» (dipinta di rame). Se è torturato dall’artrite si dice che sembra «al ritrât di granf» (il ritratto dei crampi).
Può avere anche l’aspetto di una «sarâca andè da mèl» (un’aringa marcia) o di «un cadâver ch’al caméṅna» (cadavere che cammina). Viene persino paragonato al «tragg’ ed tariänf» , al tredici dei trionfi nella carte dei tarocchi, che raffigura uno scheletro.
Di uno pallido si dice «ch’l é culåur d un tâi ed navån» (ha colore di una fetta di rapa), «ed pâpa fradda» (di minestra fredda), «ed telegrâma ed pan còt» (di un telegramma di pancotto).
Veramente stupenda è la definizione «culåur d óss avêrt» (colore di uscio aperto). Ma c’è anche chi è «ṡmôrt cómm un creditåur» (pallido come un creditore).
Il volto di un ammalato può essere anche «culåur ed tèra da pgnât» (colore di terra da pignatte), mentre quella di un sudicione è talvolta «culåur ed sumiclézzia» (colore di liquerizia) o «d scuràżż» (di scoregge). A uno molto pallido si dice: «avîv fât bughè?» (avete fatto il bucato?).
Un uomo molto magro (o affamato) ha «la panza scâgna ch’la pèr un tanbûr scurdè» (ha la pancia vuota che sembra un tamburo scordato), oppure ha il ventre «ch’i tâcca la schéṅna» (che gli tocca la schiena)
C’è chi è secco e giallo «cómm al sûg ed bacàtt» (come il sugo di bacchetto): i bacchetti erano le radici di liquerizia che i ragazzini masticavano. Ora non si trovano quasi più se non in certe fiere paesane.
Si può essere magro «cómm un spurâc’ da pasarén» (come uno spaventapasseri), «cómm un arcàtt da viulén» (come un archetto da violino), «cómm una braggla» (come una scheggia di legno), «cómm un óss» (come un uscio), «cómm un bacalà», o semplicemente «sacc arabé» (secco arrabbiato).
C’è chi assomiglia a un «arciâm da giarón» (richiamo di allodole), o a un «spurâc» (spauracchio). C’è chi è tanto patito da «parair una lôṡna» (da sembrare un lampo) o una «luṡêrta» (una lucertola). C’è chi è tanto magro che «as i dîs al paternòster int al filån dla vétta», che gli si può dire il Padrenostro usando la spina dorsale come un rosario. Ai magrissimi gli spiritosi dicevano: «stécc…qué stasîra?», giocando sulla parola «stécc» (stecchi) e «stèt» (stai).
E ve lo immaginate uno «brótt pió dal biṡåggn?» (brutto più del bisogno?). Oppure «brótt cómm i dèbit, o cómm al mèl ed ståmmg?» (brutto come i debiti o il male di stomaco?).
«Avair la båcca dal fåuren» (avere la bocca del forno) significa avere la bocca larga. «Avair al nèṡ ch’guèrda ala glòria» (avere il naso che guarda alla gloria), vuol dire avere il naso rincagnato. Chi ha le narici in avanti a causa della forma del naso voltato all’insù, «as i vadd la gåula pr i bûṡ dal nèṡ» (gli si vede la gola attraverso i buchi del naso).
Un miglior trattamento hanno naturalmente i belli e i robusti: «un pèz ed fant» (un pezzo di fante), «un pèz ed marcantòni» (un pezzo di Marcantonio), «un bèl sturnèl» (un bello storno).
Un tempo «sturnèl» veniva usato per indicare un uomo bizzarro, ma oggi ha mutato significato: James Bond è un «bèl sturnèl». Ma se uno si dà delle arie da fusto e non lo è, viene con ironia definito «un bèl casp» (un bel caspo d’insalata). Di uno alto ma molto magro si dice che è «una canarèla, o ch’al pèr un anghirån da vâl» (sembra una canna o un airone della valle), oppure «una cruṡîra vsté» (un appendiabiti vestito) e magari i ragazzi gli gridano – o meglio gli gridavano – dietro: «t î un sparlungån» (sei uno “spilungone”).
♣ ♥
CADRANÈL
«Al pèr Cadranèl», sembra Cadranel. Nel 1938, i giornali annunciarono l’arrivo a Bologna di un personaggio del quale da tempo in Italia si parlava: il famoso fachiro indo brasiliano: Cadranel.
Cadranel digiunava. Si sistemò in un locale sotterraneo di Via Ugo Bassi. Lo rinchiusero, alla presenza di un notaio, in una specie di bara di cristallo. Ci sarebbe rimasto, dicevano i manifesti, un incredibile numero di giorni senza bere e senza toccare una briciola di pane. Vederlo, costava due lire.
Lui sorrideva, immobile nella cassa di cristallo. C’era il trucco? La gente lo sospettava.
Ci si mise un giornalista. Uno della troupe tradì e la verità venne clamorosamente a galla: Cadranel teneva celato, nella parte meno nobile del corpo, un piccolo cacciavite. Nei momenti in cui la sala era vuota, cioè verso l’alba, estraeva il cacciavite, svitava un’assicella e dal pertugio entrava il cibo necessario per tirare avanti un altro giorno.
Il detto «Al pèr Cadranèl», non tenne evidentemente conto del trucco, perché per qualche anno, servì a indicare una persona molto magra e denutrita.
♣ ♥
SBÊRLA
(Sberla)
Due, allo stadio, stanno discutendo sulla partita. Il diverbio si fa piuttosto acceso e uno dei contendenti guarda l’altro con aria feroce ed esclama: «Åu, ch’al bèda bän che s’l insésst al pôl anc scapuzèr in una sbêrla» (Guardi, se insiste, può anche inciampare in una sberla).
Un tempo gli schiaffi venivano chiamati «Garòfel a zénc dîda» (garofani a cinque dita) per via dell’impronta che lasciavano sulla guancia colpita.
♣ ♥
PATERNÒSTER
(Padrenostro)
Il cliente è di quelli incontentabili. Il cameriere è seccato, ma sopporta, sa che, chi paga, entro certi limiti, ha sempre ragione. Finalmente il pranzo è finito.
Il cliente – che ha trovato salata la minestra, insipida la pietanza, poco dolce la torta e troppo dolce il vino – mugugna un po’ sul conto, controlla la somma e se ne va.
«Arrivederla, signore» dice correttissimo il cameriere, accompagnandolo fino alla porta, poi, quando l’altro è uscito, borbotta: «Mé a cradd che lu-là al truvarêv da dîr anc int al Paternòter».
♣ ♥
ÅURA
(L’ora dell’orologio)
Un tempo la gente rideva con poco. Uno chiedeva: «Che ora è?» E l’altro: «L’é l’åura ch’l’êra ajîr da st’åura» (è l’ora che era ieri a quest’ora).
Si viveva più semplicemente. E si rideva anche più semplicemente. Ci si incontrava per la strada, una stretta di mano, poi «cusa i é d nôv?» (cosa c’è di nuovo?), (nôv significa sia nuovo che nove). «D nôv?» era la riposta, «I pirû d San Ptròni». (Di nuovo? I gradini di San Petronio). La scalinata che porta sul sagrato di San Petronio ha infatti nove gradini.
Chi si accingeva a rincasare diceva invariabilmente: «L’é åura d andèr vêrs casa…làcc» (è ora di andare verso Casa…lecchio). Il gioco di parole era basato sul troncamento del nome di una località alle porte di Bologna: Casalecchio.
Un falegname si dava una martellata su un dito? C’era subito lo spiritoso che diceva: «Mé a n ò sintó gniént» (io non ho sentito nessun dolore).
Chi la sera non usciva di casa affermava: «A vâg al teâter Bianchétti», cioè vado al teatro Bianchetti, indicando per bianchetti il letto con le lenzuola bianche e giocando sul fatto che a Bologna esisteva un teatro Brunetti, l’attuale Duse.
Al passaggio di un gobbo c’era sempre qualche bello spirito che mormorava: «Lu-là al s ciâma Melôni» (quello si chiama Melloni, giocando sulla parola “melone” sulle spalle del gobbo). E non mancava chi, scorgendo uno zoppo, affermasse: «Quall-lé a n la trôva mâi pèra» (quello non la trova mai pari).
«Tant cunplimént e un bès ala cagnéṅna» (tanti complimenti e un bacio alla cagnetta), era uno dei modi di accomiatarsi da una conoscente.
Se pioveva, allora, il buontempone osservava: «Ai vén zå dl’ âcua môjja» (cade acqua bagnata). Se lo invitavano a bere esclamava: «Mó sicûra, mé a sån dla Bevrèra» (certamente, io sono della Beverara) che è una frazione di Bologna. Se gli domandavano il suo nome, rispondeva: «Chi a sån mé? A sån al fiôl ed mî pèder» Chi sono io? Sono il figlio di mio padre.
«S’la s’n à parmèl» si diceva scherzando a una donna falsamente scandalizzata per una battuta un po’ audace «ch’la s vôlta al grinbèl» ( se si è offesa, si volti il grembiule).
D’inverno la gente di spirito interveniva nelle conversazioni sul tempo con battute come questa: «Altroché s’l é fradd. I an truvè żlè una sentinèla a San Lócca» ( altroché se è freddo, hanno trovato gelata una sentinella a San Luca). Al santuario di San Luca esisteva una polveriera.
Di un progetto che non veniva mai attuato si osservava: «Ai ò pòra ch’i al fâghen l’ân dal mâi» (ho paura che lo facciano l’anno del mai).
Nel lasciare un conoscente si esclamava: «Stricäns la zavâta» (stringiamoci la ciabatta), o, se non trovava più il cappello: «In duv òja méss la tèsta?» (dove ho messo la testa?). O ancora: «Se dman al n um vadd, ch’al dégga pûr ch’a n sån brîṡa vgnó» (se domani non mi vede, dica pure – ne deduca – che non sono venuto).
Ma il massimo exploit dello spirito del buon bolognese vecchio stampo era questo: «S’l à biṡågn ed quèl ch’as al cånpra» (se ha bisogno di qualcosa, se lo compri).
Ancora oggi c’è qualcuno che, in prossimità del Natale, incontrando un conoscente dice: «Ôv dûri» (uova sode), invece di Auguri, giocando sul suono delle parole.
♣ ♥
LA CANPÈNA D SAN SIMÅN
(La campana di San Simone: una ninna nanna)
Din, dan, din, dan
La canpèna d San Simån
Tótt al dé i la sunèven
Pan e vén i guadagnèven
Guadagnèvn un pèr d capón
Da purtèr ai sû padrón
I sû padrón i n êren a cà
I êren invêzi dåpp al óss
A tajèr gli uràcc’ al cócc
Cócc, cócc, malandrén
Dà la vôlta al tô mulén
Dà la vôlta al tô canèl
Ch’ai ó trai fiôli da maridèr
Ónna cûs e pó la tâja
Ónna fà i caplén ed pâja
Ónna fà i caplén ed spén
Fa la nâna al mî fangén.
(Din, don, din , don / la campana di San Simone / tutto il giorno la suonavano / pane e vino guadagnavano / guadagnavano un paio di capponi / da portare ai loro padroni / i loro padroni non erano a casa / erano invece dietro l’uscio / a tagliare le orecchie al cuculo / cuculo, cuculo malandrino / metti in moto il tuo mulino / metti in moto il tuo canale / che ho tre figlie da maritare / una cuce e poi taglia / una fa i cappellini di paglia / una fa i cappellini di spino / fa la nanna mio bambino )
♣ ♥
ŻÛRA ŻÛRA, PANZA DÛRA
(Giura, giura, pancia dura)
Era il giuramento più solenne e vincolante dei ragazzi di un tempo. Solitamente ci si accontentava di un non troppo impegnativo: « Sant’Anna scopre l’inganno» che faceva sentire i ragazzi a posto con la coscienza, anche se non avevano detto proprio tutta la verità.
Ma quando si trattava di garantire in modo assoluto la buona fede allora ecco la formula solenne, davanti alla quale nessuno aveva più il coraggio di mentire: «Żûra Żûra, panza dûra, panza infiè ch’a môra in sta bulè» (Giuro, giuro, pancia dura, pancia gonfia, che io muoia in questo posto (se non dovessi mantenere la promessa).
È una formula evidentemente molto antica; dei tempi nei quali il colera era, fra tutte le malattie, una delle più temute. La pancia dura e gonfia era uno dei primi sintomi dellla terribile e implacabile infezione.
♣ ♥
SORBOLE
C’è un’esclamazione, piuttosto volgare, che distingue i bolognesi come il leone della Metro o il cane a sei zampe dell’Eni. «Sócc’mél» letteralmente “succhiamelo”.
In una rivista goliardica del 1940, la scena rappresentava il ponte di una nave. Arriva un messaggio radio, il capitano lo decifra lentamente: S,O… «C’è gente in pericolo» mormora, poi continua a decifrare: «S,O, C,M, E, L…Macché» esclama allora «è il solito scherzo di una nave di bolognesi».
«Sorbole, sorbolina, sóccia, sórbla, soccialôv», sono pudiche mascherture, surrogati della più petroniana delle esclamazioni. Dice «Mo sòrbole» soltanto qualche signora piccolo borghese di una certa età, in momenti di particolare sbalordimento e sorpresa. Le giovani piccolo-borghesi dicono «sorbolina» con molta grazia e con una «esse» appena marcata. «Soccialôv», invece, gode ancora qualche fortuna tra le donne del popolo: e non è neppure volgare se chi si lascia sfuggire l’esclamazione, parla un dialetto aperto e genuino. «Sóccia» , infine, è un’esclamazione tipicamente infantile. «Sóccia che gol», (che gol!), «Sôccia che ṡbêrla» (che botta!), sostanzialmente «sóccia» equivale a un’eslamazione, a un intercalare tipico di Bologna, che ha perduto l’originale caratteristica scurrile.
♣ ♥
AMAZÈR
(Uccidere)
Francesco Ferrucci gridò drammaticamente a Maramaldo: «Vile, tu uccidi un uomo morto.» I bolognesi, meno epici, dicono: «Bèla fôrza, amazèr ón ch’chèga», (bella forza, ammazzare uno che caga) e quindi è nelle condizioni peggiori per potersi difendere.
♣ ♥
SDUZÈR LA CHITÂRA
(Strimpellare una chitarra)
Peccato che l’espressione sia passata di moda. Con il proliferare dei complessi musicali moderni, più o meno intonati, avrebbe trovato larghissimo impiego. «Ṡduzèr la chitâra» significa, infatti, strimpellare la chitarra (verbo valido per qualsiasi altro strumento musicale, ma la chitarra si presta più di tutti).
«Ṡdòz» vuol dire coccio. In linguaggio figurato significa una persona di poca salute. Oggi di dice «ṡdòz», per esempio, ad un mediocre giocatore di calcio.
«Fèr di ṡdûz» significa rompere in pezzi una pignatta. Ma se a «Fèr di ṡdûz» è una donna incinta, vuol dire cha ha abortito. C’è anche un terzo significato: chi è in procinto di perdere la pazienza e sta per menar le mani dice, con aria torva, che farà «di ṡdûz» dei cocci.
Se il marito sente venire dalla cucina una fragore di terraglie infrante, ancora oggi, se è un vero bolognese esclama «Sdozzi!!!».
♣ ♥
PRÎT
(Prete)
«Al n é un mèl che al prît in gôda» (non è un male che il prete ne goda).
Il medico di famiglia, di un tempo, era un vecchio signore baffuto e gioviale. Parlava in dialetto, scaricava gran pacche sulla schiena del nonno, dava del tu al babbo.
Se era l’ultima visita della giornata, talvolta si fermava a bere un bicchiere di vino seduto sul letto. Discorreva di politica e del mal di gola del paziente. Prima di uscire rassicurava tutti: «State tranquilli, «quasst al n é un mèl che al prît in gôda» Questo non è un male che il prete ne goda. Voleva dire che non si trattava di una cosa grave e che non ci sarebbe stato bisogno di scomodare il prete per l’estrema unzione.
Salvo che il medico non fosse come quello ricordato da una vecchia filastrocca:
«Al dutåur Leonbrón
Ch’al n à mai guaré inción.
Ai fó ón ch’al guaré,
Mo al dé dåpp al muré»
(Il dottor Leonbruno / che non ha mai guarito nessuno / Ci fu uno che guarì / ma il giorno dopo morì).
♣ ♥
LASEMSTÈR
(Lasciamistare, non mi toccare)
«L é péṅna ed lasemstèr» (E’ piena di lasciamistare).
A volte ci sono ragazze, molto belle, ma talmente consapevoli della loro avvenenza, da rendersi antipatiche. A Bologna di un tipo del genere si dice che: «l é péṅna ed lasemstèr» è piena di “lasciamistare”. Una felicissima definizione.
Un tempo, essere pieni di «lasemstèr» significava anche essere noiosissimi.
♣ ♥
FRÈ
(Frate)
«Ai nâs un frè» Nasce un frate.
Certi silenzi oggi sono impossibili, ma un tempo accadeva quasi ogni sera. A tavola il babbo aveva finito di mangiare, accendeva una sigaretta, la mamma non trovava la voglia, o la forza, dopo una giornata senza un momento di respiro, d’alzarsi per lavare i piatti, i figli sfogliavano qualche giornaletto.
D’improvviso ci si accorgeva che il silenzio era assoluto, totale, che nulla in casa e fuori, lo turbava, né un alito di vento, né una voce, né uno scricchiolio.
Allora il nonno diceva: «Ai nâs un frè» (Nasce un frate) e ogni volta si rideva della battuta come fosse nuova.
♣ ♥
NÀIGHER
(Nero)
«Se ló l é nàigher mé a ténnż» (Se lei è nero, io tingo).
Pirûla (Pietro), facchino e Jusfén (Giuseppe), mugnaio, hanno trovato da discutere sul prezzo per lo scarico di un carro di grano. Pirûla ha i bicipiti poderosi, ma anche Jusfén non scherza, da giovane ha fatto ginnastica come quelli della Virtus.
Il facchino insiste, ma l’altro non cede. Allora Pirûla, facendo gli occhi feroci, esclama: «Óu, badè bän che incû mé a sån nàigher dimónndi» (Oh! Guardate bene che oggi sono molto nero).
E l’altro: «Ah, sé? Bän, se vó a sî nàighér, mé a ténnż!» Se voi siete nero, io tingo.
La battuta è divertente, ma pare che, in altri tempi, sia costata a molti il passaggio dal nero metaforico al nero concreto: il nero che circonda gli occhi di chi è stato preso a pugni.
♣ ♥
TÔC E TÂC
(Tacchino e tacco)
«Méi un tôc che un tâc» (Meglio un tacchino che un tacco). Non si sa chi sia stato a scoprire il fatto che è meglio un tacchino che un tacco, ma le cose sembrano andate così:
«Un zavatén diṡocupè al vésst un tôc par strè,ṡbandè; ṡvêlt e prudänt ló al l aguanté e, par cal dé, pió a n lavuré. Pò al déss trancuéll, dåpp ch’l avé fât: l é méi dimónndi un un tôc che un tâc».
(Un ciabattino disoccupato vide un tacchino per la strada, sbandato. Svelto e prudente lo agguantò e per quel giorno non lavorò più. Poi disse tranquillo, dopo che l’ebbe fatto: è molto meglio un tacchino che un tacco).
♣ ♥
CAVÂL D SCÂJA
(Cavallo di Scaglia)
«Al cavâl d Scâja» (Il cavallo di Scaglia). Cavâl vuol dire cavallo, Scâja è difficile da definire. Si può pensare che scâja faccia riferimento ad un tipo di roccia calcarea poco compatta, con tendenza a suddividersi in scaglie. Con la scaglia, che è molto fragile, pare che un tempo si fabbricassero cavallucci per bambini, di qui il detto «cavâl d scâja» per indicare una persona fragile ed afflitta da molti mali.
Ma forse non è così, perché generalmente la terra malleabile per fare figurette era la creta. E la maggior parte delle versioni date dai parlanti dialettali, indicano in Scâja un cognome.
Probabilmente però il detto bolognese ha maggiore attinenza con un detto popolare italiano: “E’ come l’asino di Buridano che ha cento piaghe sotto la coda”. «L é cme al cavâl ed Scâja ch’l avèva trantasî mèl såtta ala cô» (E’ come il cavallo di Scaglia [riferendosi a una persona, forse proprietaria di un cavallo pieno di acciacchi] che aveva trentasei mali sotto la coda).
A un «Cavâl d Scâja – secondo i bolognesi – as i vadd i dént in båcca pr al bûṡ dal cûl» (Al cavallo di Scaglia gli si vedono i denti in bocca attraverso il buco del culo).
♣ ♥
PICÂJ – PICÂJA
(Gambo, fermaglio)
«Picâj» significa gambo, fermaglio. Al femminile, è di «picaglia» tenera chi si innamora o si commuove facilmente. L’espressione è usata con particolare tenerezza dalle madri.
«L é d picâja tanndra» dicono del figlioletto, «bâsta guardèrel parché al s métta a zighèr» (E’ di «picaglia» tenera (come dire ha un fermaglio che non tiene), basta guardarlo perché si metta a piangere).
♣ ♥
TAFIÈR
(Abbuffarsi, mangiare voracemente)
Mangiare, in bolognese, si dice «Magnèr»
«Al mâgna» (mangia) il signore che si siede a tavola, mette il tovagliolo sulle ginocchia e, masticando lentamente come suggerisce il medico, si fa fuori dignitosamente minestra, pietanza e frutta.
Ma se al posto del signore distinto si mette un bel piantato rappresentante di una «balla» (gruppo) di facchini allora è meglio sostituire il verbo «magnèr» con un altro, più volgare ma anche più significativo, «tafièr» (abbuffarsi) che è voce del gergo popolare di chi come i facchini o i muratori lavorano forte e di braccia.
Se nel dialetto bolognese abbondano i riferimenti alla fame, come, per esempio, «avair al ståmmg int i garétt» (Avere lo stomaco nei garretti), numerose sono le espressioni ispirate al «tafièr», per esempio «ṡludrèr», «spanzèr» (riempirsi la pancia) «magnèr da stróppi» (mangiare fino a scoppiare), oppure «magnèr a stragualzón» (mangiare così in fretta da strozzarsi).
I vecchi muratori dicevano anche «ṡganapèr», con riferimento al nome di un burattino bolognese “Sganapino”, il sempre affamato compagno di casotto di Fagiolino (altro burattino bolognese).
Fino a pochi anni fa ai Giardini Margherita di Bologna o alle fiere dei paesi nei dintorni della città, venivano allestiti teatrini di burattini, in cui i due personaggi Sganapino e Fagiolino, facevano divertire centinaia di bambini, affascinati dalle proverbiali bastonate che si davano a vicenda e dai loro litigi per futili motivi. Tutti i dialoghi erano in dialetto.
Un tempo, quando un viso d’uomo non era virile se non ornato da folti baffoni, chi stava per sedersi a tavola dichiarava, sicuramente con aria compiaciuta,: «A vâg a ónnżrum i bâfi» (vado ad ungermi i baffi). Un po’ volgare ma significativo. Meno volgare è l’espressione «ṡbatér l òs barbén», (Chi mangia, infatti, batte le ossa della barba: mascella e mandibola).
♣ ♥
BRÔDA ED FASÛ
(Brodo di fagioli)
«Andèr in brôda ed faṡû» (Andare in brodo di fagioli).
A un poeta dialettale bolognese fu rimproverato di non scrivere versi d’amore, ma solo versi divertenti. Forse i bolognesi non sanno amare? Non hanno momenti di malinconia?
Il poeta si difese affermando che il dialetto bolognese non va d’accordo con il sentimento.
La dolce parola “amare” non ha un corrispettivo in dialetto.
Non si dice mai ad una donna: «Mé a l âm» perché «al lâm», in bolognese, è l’amo e serve per pigliare i pesci.
Né si può dire «Amèr», per amare, perché «amèr» significa amaro.
Per dire che si ama una donna (o un uomo ovviamente) è necessario ricorrere a un giro di parole: dire, per esempio, «Mé a t vói bän» (Io ti voglio bene).
Non si può negare che il dialetto petroniano si presti più alla frase gioconda, beffeggiatrice, grassa che ai dialoghi degli innamorati.
Se si prende ad esempio l’italianissimo «andare in brodo di giuggiole», c’è molta gentilezza in quel brodo di giuggiole. Ebbene, i bolognesi vanno invece in «brôda ed faṡû» in brodo di fagioli, che è indubbiamente un modo assai più prosaico di definire la gioia.
♣ ♥
CÛG
(Cuoco)
«Al cûg l é môrt dala pózza ed carbån» (Il cuoco è morto per la puzza del carbone).
«Prego, si accomodi» dice la padrona di casa all’ospite «ma non si aspetti mica un pranzo eccezionale perché «da nuèter al cûg l é môrt dala pózza ed carbån». (Da noi il cuoco è morto per la puzza del carbone).
Quando in una casa il cuoco è morto per la puzza del carbone, significa che non vi regna l’abbondanza e che, come direbbe Fagiolino, (burattino bolognese), vi si mangiano «ciûd a claziån e bulàtt da dṡnèr»: chiodi a colazione e bullette (o bulloni) a desinare.
♣ ♥
DUNÉN É MÔRT, DUNÈ STÀ MÈL
(Donnino è morto e Donato sta male)
Miniracconto.
La Venusta, moglie di Callisto, domiciliato in via Miramonte, si reca dalla vicina di casa l’Argia, moglie di Archimede, conosciuto come «al drétt» (il dritto).
«Ch’la m scûṡa, Argia», dice,«m’inprastaréssi un franc?» (Mi scusi, Argia, mi presterebbe una lira?).
«No», dice l’Argia, «An n ò ón ch’al s inzócca in cl’èter. Intinimôd, anc s al avéss, a lî an i al darêv brîṡa. La m à bèle da dèr dîs sôld». (No, dice l’Argia, non ne ho uno che s’inzucchi nell’altro. Ad ogni modo, anche se l’avessi, a lei non glielo darei. Mi deve già dieci soldi).
Breve e concitato e coloratissimo dialogo, nel corso del quale la Venusta esprime il suo pensiero sull’Argia e l’Argia replica con alcuni concisi ma efficacissimi concetti sulla Venusta.
A conclusione dello scambio d’idee l’Argia grida: «E pò sèla cus ai dégg? Che chi à la råggna s la grâta» (E poi sa che cosa le dico? Che chi ha la rogna se la gratti).
Mah! Sospira la Venusta andandosene: «Che tempi!», «L é pròpi vaira che Dunén é môrt e Dunè stà mèl» (E’ proprio vero che Donnino è morto e Donato sta male)
Un gioco di parole non proprio irresistibile per significare che non si trova più chi doni qualcosa.
♣ ♥
CÛG LANDRÉN
(Cuoco Landrino)
«Al cûg Landrén ch’al mazèva i bdûc’ col misclén» (il cuoco Landrino che ammazzava i pidocchi col mestolo). Lo si usava per indicare chi manipola le vivande con poca pulizia.
In Borgo Casse, oggi Via Marconi, c’era una «Ustarî d Capóccia» (Un’osteria di Capoccia) dove veniva servito un «Umidâci» (Umidone o Umidaccio), nel quale, con una certa frequenza, venivano trovate le cose più strane e incredibili. Si dice che una volta un cliente vi abbia trovato una scarpina da poppante, forse caduta nella enorme pentola mentre la cuoca stava rimestando l’intingolo tenendo in braccio un bimbo.
♣ ♥
SAN GRUGNÅN
(San Grugnone)
Capita anche nelle migliori famiglie. Il padre torna dal lavoro e trova la moglie e i figli seri, accigliati. Azzarda una domanda e gli viene risposto a monosillabi.
Allora esclama: «Bän mo cuṡ êl, incû, al dé d San Grugnån?» (ma che giorno è oggi, il giorno di San Grugnone?).
«Avair al gróggn» in bolognese, significa avere il muso, essere di cattivo umore.
Da «gróggn» è derivato «Al dé d San Grugnån», il giorno di San Grugnone, cioè, del muso lungo.
♣ ♥
MAITINÈ
La «Maitinè» è una burla di altri tempi.
Fra gli scherzi di poco buon gusto sopravvissuti fino a qualche anno dopo l’ultima guerra, vi era la «Maitinè», consistente in riunioni di persone del popolo che, sotto le finestre dei novelli coniugi, che si erano sposati in età non giovanissima, eseguivano stonati concerti, battendo su padelle, caldaie, coperchi e altri recipienti, con un gran baccano, comunicando a tutto il circondario il matrimonio fra “anziani”. Per evitare che questo succedesse alcune coppie si sposavano tardissimo la sera o prestissimo la mattina.
Oggi la «Maitinè» non usa più, non solo perché la gente ha cambiato e si è evoluta. Non è certamente raro che ci si sposi in età rispettabile, ma anche perché il concerto potrebbe essere scambiato per un moderno complesso rock che si esibisce a mo’ di serenata.
♣ ♥
LÓ E VÓ
( Lei e Voi)
Durante il ventennio fascista i giornali tuonavano: “Usate il voi”. I manifesti ammonivano: “Abolite il lei”.
Per i giovani era insieme una fatica ed un divertimento: frequente l’errore voluto: “Scusate, signorina, lei venite al cinema con noi?”
Fra la gente del popolo, gli anziani, invece, nemmeno se ne accorgevano perché avevano sempre usato il voi. Il nonno dava del voi alla nonna e i figli del voi alla mamma.
Si usava il lei parlando con persone di un ceto ritenuto superiore. Il contadino dava del lei al padrone, mentre il padrone lo trattava col voi. Il lei era, insomma, riservato alla gente importante per autorità e ricchezza.
Uno che si facesse «Dèr dal ló» (dare del lei) era dunque uomo di tutto rispetto.
«L é ón» diceva la gente del popolo del facchino pronto a menar le mani «ch’al s fà dèr dal ló». (E’ uno che si fa dare del lei, si fa rispettare).
Ma anche un buon piatto di tortellini o di lasagne si fa dare del lei. «Òrpo» esclama il buongustaio con la bocca piena «quissti sé ch’ i én turtlén ch’i s fan dèr dal ló». (Orpo – abbreviazione di “corpo di Bacco” -, questi sì, sono tortellini che si fanno dare del lei).
Ed anche oggi, non è raro sentire : “Mi dia del lei”, quando qualcuno che si ritiene di “rango” superiore, si sente invece trattato con il tu.
♣ ♥
PINSÎR
(Pensieri)
«Métter i pinsîr såtta al cavzèl» (mettere i pensieri sotto il capezzale).
Un tempo non esistevano i tranquillanti. Nei casi più gravi, quando l’ansia e la depressione dicevano proprio sul serio, si ricorreva a una tazza di camomilla raccolta in fiore, d’estate, nei prati della periferia.
Se la camomilla si fosse rivelata insufficiente, ecco il consiglio un po’ triviale: «Dî só, s t è al narvåus métt al cûl a mój». (Ehi tu, se hai il nervoso, metti il sedere a mollo).
Ma la maggioranza dei bolognesi, dopo una giornata di durissimo lavoro, non avevano bisogno di camomilla per dormire.
In quanto alle preoccupazioni, seguiva il suggerimento di un vecchio adagio: «Métt tótt i pinsîr såtta al cavzèl».(metti tutti i pensieri sotto il capezzale). Come dire: dormi tranquillo senza pensare a quello che ti aspetta domani.
♣ ♥
GALANTÒMEN DALA TÒCA
(Galantuomo del tacchino)
Il detto popolare deriva da un racconto con almeno due versioni.
Un tale, molto anni fa, di passaggio per una strada di compagna, non seppe resistere alla tentazione di afferrare un grosso tacchino per il collo e di nasconderlo sotto la capparella(*). Per sua sfortuna l’«arżdåura» (la padrona di casa), lo sorprese e lo affrontò piuttosto arrabbiata.
«Gîv con mé?» (dite a me?) domandò l’uomo facendo lo gnorri.
«Pròpi a vó, al mî umarèl, a m pèr ch’a v aréssi da vargugnèr!» (Proprio a voi, il mio ometto, mi sembra che dovreste vergognarvi!).
«Vargugnèrum ed côsa?» replicò l’altro «mé a sån un galantòmen» (Vergognarmi di che cosa? Io sono un galantuomo).
«Sé» sbottò allora la donna «un galantòmen dala tôca» (sì, un galantuomo col tacchino).
L’altra versione non si discosta molto. Racconta che un contadino, per frodare il dazio, avrebbe nascosto un tacchino sotto la capparella. Ma, al momento di entrare in città, il gonfiore non sfuggì agli occhi esperti del daziere, che volle vederci chiaro:
«Che cosa avete lì sotto?»
E il contadino facendo l’ingenuo: «Niente»
«Siete sicuro’»
«Altro ché. «Mé a dégg sänper la veritè. A sån un galantòmen» (Io dico sempre la verità, sono un galantuomo).
«Sé» disse il daziere aprendogli la capparella, «un galantòmen dala tôca» (Sì, un galantuomo col tacchino).
La due versioni non si discostano molto, il significato non cambia: «Galantòmen dala tôca», viene chiamato chi si rivela un imbroglione.
(*) La capparella era un mantello, tipo tabarro, senza maniche, che gli uomini hanno indossato fino negli anni 50-60, nei paesi più poveri. Gli uomini del popolino non usavano il cappotto, che era riservato ai ricchi. Durante la prima guerra mondiale i soldati semplici, i fanti, usavano la capparella, gli ufficiali indossavano il cappotto.
♣ ♥
BAJÒC ED GRÂS
(Baiocco o soldo di grasso)
«Dscårrer cómm un bajòc ed grâs int la padèla» (Parlare come un soldo di grasso nella padella).
L’immagine è felicissima. Parla come un soldo di grasso nella padella chi dice cose inutili e sciocche. Infatti è un parlare che non lascerà tracce. Proprio come l’effimero borbottio di una pallina di grasso che si strugge al calore.
♣ ♥
SPUDASENTÄNZ
(Sputasentenze)
«Al i aciâpa quand al i acój» (Ci prende quando coglie nel segno). In altre parole dice giusto quando non sbaglia.
Non c’è forse individuo più insopportabile dello «spudasentänz» lo sputasentenze. Di chi pretende di sapere tutto e dice soltanto stupidaggini, di chi sostiene di conoscere il rimedio per ogni malattia e la strada per ottenere qualunque tipo di favore.
I bolognesi liquidano con una frase lapidaria queste enciclopedie umane. Questi geni che non farebbero fortuna nemmeno nel più squalificato dei telequiz.
«Lu-lé – dicono – al i aciâpa quand al i acój» che è un modo elegante per dire che uno parla a vanvera. (Ci prende quando coglie nel segno).
A chi si dà delle arie e cerca di passare per importante, un tempo si diceva: «Mo chi êl? Quall ch’al métt al sûg int al muscatèl?» Ma chi è? Quello che mette il sugo nell’uva moscatella?
Oppure «Mo chi êl? Quall ch’al dà la pîga ai chîfel?» (Ma chi è? Quello che dà la piega ai chifel?) I Chifel sono pezzi di pane a forma di mezza luna.
E ancora: «Mo chi êl? Al padrån däli òs dla pulänt?» (Ma chi è? Il padrone delle ossa della polenta?).
♣ ♥
ŻANIBÔNI
A chi ripete sempre le stesse cose, ancora oggi, si dice: «Mûdla,Żanibôni» (Cambiala. Zaniboni).
Zaniboni era il direttore della piccola orchestra che avrebbe dovuto rallegrare gli spettatori dell’Arena del Sole negli intervalli fra un atto e l’altro. Senonché ripeteva sempre le stesse musiche fra le grida di disapprovazione del popolino che gremiva il teatro. Finalmente un popolano della gradinata, ai limiti della sopportazione, urlò: «Mûdla, Żaniboni» (Cambiala, Zaniboni).
La battuta, destinata a diventare celebre, fu accolta da frenetici applausi.
♣ ♥
I MÎS DÄL ZIVÅLL
(I mesi delle cipolle)
Il tema della fame ricorre con frequenza nella letteratura dialettale del secolo scorso. Il teatro dei burattini, specchio deformante ma attendibilissimo della vita del popolo bolognese, è addirittura dominato dalla fame: Fagiolino, sia pur giocosamente senza farne un dramma, per che cosa lotta e bastona se non per procacciarsi un «stracantån ed gnûc apastizè?» (un’angoliera – grande quantità – di gnocchi al pasticcio?).
Gli ideali suoi, di Sganapino, di Brisighella e degli altri compagni di casotto, sono tutti di ordine materiale: ideali piccolissimi, giacché si esauriscono nell’aspirazione di mettersi a tavola o sistemarsi in una cantina ben fornita.
Dove si va? Domanda Fagiolino
«Bâsta ch’andaggna dóvv ai é del tajadèl sótti» (Basta che andiamo dove ci sono delle tagliatella asciutte),
Risponde Sganapino.
«E di bón macarón cunzè con la pâsta e dal bån vén naigher». (e dei buoni maccheroni conditi con la pasta e del buon vino nero).
Nella città di un tempo «i mîṡ däl zivåll» (i mesi delle cipolle), erano quelli, terribili, della carestia e della disoccupazione, quando la gente «La n avèva gnint da fèr fumèr al camén» (Non aveva di che far fumare il camino, nel senso che mancava anche la legna).
Si legge in una relazione del 1883: «Vi sono delle classi di operai e di braccianti che, per mancanza di mezzi e per la piccola retribuzione che ricevono in ogni lavoro, vivono molti giorni di sola polenta di formentone, o non condita, o assai male. In un lavoro di arginatura del fiume Reno in Argelata, chi scrive ebbe ad osservare, nel mese di aprile scorso, il lavoro di 1200 operai e braccianti, i quali per la maggior parte eransi riuniti in squadre di 12 o 15 uomini, onde insieme eseguire un dato lavoro, a prezzo già stabilito, ed a prepararsi insieme anche il vitto. Questo, però, consisteva in una sola polenta, bensì assai grande, perché di otto o dieci chilogrammi di farina di formentone, la quale però ben cotta, e appena confezionata con poco sale, veniva subito divisa tra i contraenti. Questi poi se ne servivan anche nel pasto della sera; essendo poi ben fortunato quell’operaio che poteva associarvi qualche sostanza, come cipolla, frutta, e specialmente una piccola dose di formaggio, o di salacca (*)»
I mesi della cipolla dovevano essere più d’uno nel corso dell’anno, e dovevano esservene alcuni addirittura senza cipolla, se si usava dire: «Incû a i ò magnè pan e spudâc’» (Oggi ho mangiato pane e saliva).
(*) La salacca o sarâca è la definizione commerciale di alcuni tipi di pesce conservato sotto sale, generalmente proveniente dai paesi del nord Europa. Per realizzare le salacche sono utilizzate alcune specie di pesce azzurro (normalmente cheppie e papaline, ma anche sardine o aringhe), ovvero quelle specie che sono poco ricercate per il consumo immediato a causa di un’eccessiva ricchezza di spine nelle carni. Il pesce, una volta eviscerato, messo in salamoia e, a volte anche affumicato, viene posto in barili e conservato mediante salatura a secco.
Negli anni del dopoguerra, i barili aperti di salacche ( saracche) erano la prima cosa che si incontrava quando si entrava in una drogheria.
♣ ♥
BALILLA
(Balilla, nel senso di termine fascista)
«Andèr int i balilla» (Andare nei balilla)
Forse il primo, quello che inventò questo detto, ne fece partecipe soltanto gli amici più fidati raccomandando che non lo dicessero in giro perché era roba da finire al confino.
Invece si sa come vanno queste cose: se la battuta è buona fa presto a diffondersi. E questa si diffuse a tal punto che anche per molto tempo, nel dopoguerra, la si sentiva molto spesso soprattutto tra il popolino. Col tempo aveva perso ogni carica di cattiveria ed era diventata un modo di dire come un altro.
«Dí sô» si diceva a chi faceva un discorso stupido o si comportava in modo sciocco «vèt int i balilla?» (Dimmi, vai forse nei balilla?). Era un surrogato ironico ed elegante del rozzo ma bolognesissimo: «vèt int i cretén?» (vai nei cretini?).
♣ ♥
DIRINDÉINA E PAN GRATÈ
Capita a tutti di iniziare un discorso e poi perdere il filo. In qualche caso basta un momento di riflessione, un appropriato giro di parole per riportare il ragionamento in carreggiata. Altre volte, invece, ci si trova impelagati in un complicatissimo labirinto di vocaboli: e più si parla per uscirne più il cammino si fa difficile, sicché si finisce per balbettare frasi senza senso, terribilmente confusi se la persona con cui parliamo è di quelle che vengono dette di riguardo.
È a questo punto – quando, come si suol dire, si vorrebbe sprofondare – che il bolognese, con la su aria sorniona, mormora: «sé, dirindéṅna e pan gratè».
«Dirindéṅna» non significa nulla, «pan gratè» vuol dire pane grattugiato. Il tutto vuole essere lo sconclusionato, buffonesco commento a un discorso privo di senso.
♣ ♥
ARÉN BUTÉN
I nostri nonni e bisnonni, quando si trattava di fare la “conta” per stabilire a chi toccava “stare sotto”, per giocare a mosca cieca o ai quattro cantoni, si mettevano tutti in cerchio. Poi il più grande diceva: «Arén, Butén, Salè, Limån,Żanfrén, Żanfrån, Côla garavèla, Tudàssc, Dièvl e Pass». Si tratta di un’accozzaglia di vocaboli, alcuni intraducibili, alla quale si affidavano, per decidere a chi toccasse “stare sotto”.
In qualche caso usavano anche un’altra filastrocca, molto più nota, che diceva: «ambarabà ci ci cocò, tre civette sul comò, che facevano all’amore con il gatto del dottore, il dottore si ammalò, ambarabà ci ci cocò».
Se qualcuno faceva qualche «balutén» (ballottino, tentava di barare) non mancavano le proteste e la consueta solenne invocazione: «San Żvân pôrta l ingân» cioè San Giovanni scopre l’inganno.
Oggi è tutto un altro mondo, ma anche i nostri genitori, impegnandosi a fare un salto, hanno detto: «Salto, mi salto/ mi rompo la testa/ mi rompo il viso/ salto in Paradiso».
Quelli ancora meno giovani ricordano bene la “luna” che si giocava a «Zòp galàtt» (gallo zoppo, su un piede solo), oppure il «Dscargabaréll» (scaricabarile: effettuato da due ragazzi che si mettevano dorso contro dorso e, intrecciate le braccia, si sollevavano alternativamente, restando a vicenda l’uno sopra e l’altro sotto). O ancora il «Livapàn» (la bilancia, in cui due fanciulli a cavalcioni delle estremità di una trave, tenuta in bilico sopra un’altra, si alzavano e si abbassavano con moto alterno).
I giochi fanciulleschi d’un tempo erano parecchi, ad esempio «L’arpiatarôla» (rimpiattino o nascondino), la «Stréjja» (strega: al via del capogioco si doveva correre su qualcosa di rialzato prima di essere toccati dalla strega), «Ṡbérr e lèder» (guardie e ladri), i «Quâter cantón» (I quattro cantoni).
C’erano anche piccoli giochi d’azzardo come «Paniréṅna» (Cestina, fatta tenendo le mani chiuse a pugno), «Pèra e dspèra» (Pari o dispari), «Batmûr» (Battimuro), «Castlàtt» (Castelletto).
«Paniréṅna,paniréṅna, quèla é vûda e quèla é péṅna?» domandava l’uno e l’altro doveva indovinare in quale delle due mani chiuse fosse nascosto un piccolo oggetto.
Il «Castlàtt» lo ricordano solo i più anziani. Si giocava con quattro noci: tre disposte a triangolo e una posta sopra le tre noci. Contro il castelletto i ragazzi lanciavano, ad uno ad uno, una noce. Chi colpiva il «Castlàtt», vinceva.
«Batmûr» (battimuro) era il gioco dei più vivaci. I ragazzi ponevano a distanza di un metro e mezzo circa da un muro, un segno chiamato «bóssca». Quindi, uno alla volta, lanciavano contro il muro una moneta che, rimbalzando doveva avvicinarsi al segno, ma non sorpassarlo. Tutte le monete che andavano oltre erano vinte da chi aveva saputo far ricadere la propria a minor distanza dal segno.
C’era un tempo anche un gioco che si chiamava «Péccia blîguel» (batti l’ombelico) , lo si faceva facendo rimbalzare una moneta gettata in direzione dell’ombelico. Più tardi nel tempo, questo gioco ha assunto un altro significato e non è sempre consigliato proporre a una ragazza, in presenza di altre persone, di giocare a «Péccia blîguel».
♣ ♥
PIÂT
(Piatto)
«Un piât d bôna zîra» (Un piatto di buona cera)
Per chi ha vissuto per molti anni in un quartiere popolare, fra facchini, operai e artigiani, questa espressione sembra estremamente indicativa di un mondo e di un modo di vivere che oggi sono scomparsi.
Era una piccola comunità, una straducola stretta, con case basse e povere, la porta di casa era sempre aperta: non c’era nulla da rubare. D’estate la gente viveva nella strada, ognuno portava una seggiola, i bimbi più piccoli giocavano sotto i portici.
La gente era schietta e cordiale, un no era un no, un sì era un sì. E un invito a pranzo – a una mensa di solito molto parca – generalmente non sottintendeva secondi fini.
La colazione di lavoro non era ancora stata inventata, era soltanto una occasione di stare un po’ insieme.
«Ch’al véggna a dżunèr da nó», si diceva: venga a digiunare da noi.
«E ch’an s aspèta mégga èter che di piât ed bôna zîra» (e non si aspetti altro che dei piatti di buona cera: dei piatti cioè, alla buona, ma offerti col cuore).
Al che l’altro rispondeva: «Ma senz’altro: «dove si manduca Dio mi conduca».
Il pranzo si concludeva regolarmente con l’esortazione a finire tutto quello che c’era in tavola: «Bän» diceva la padrona di casa, indicando l’ultimo pezzetto di ciambella, «a n vrà mégga lasèr lé al pcån dla vargåggna?» (Beh!, non vorrà mica lasciare lì (sul piatto) il boccone della vergogna?).
♣ ♥
PRASÛ
(Prezzemoli)
Quando andavano lunghe, le sottane erano ornate ai bordi con frastagli ricamati: in dialetto quei frastagli erano detti :«prasû» (prezzemoli).
«Badèr ai prasû dla sô stanèla» Cioè badare ai frastagli della propria sottana, significava non impicciarsi degli affari degli altri.
Veniva usato soprattutto durante le liti fra comari: «Lî la farêv méi a badèr ai prasû dla sô stanèla, brótta scuénzia!» (Lai farebbe meglio a badare ai frastagli della sua sottana, brutta squinzia!)
♣ ♥
TÛM SÓ
(Prendimi su, raccoglimi)
La solita moglie, il solito marito e la solita richiesta di quattrini. Lei dice:«dammi diecimila lire», e lui: «sé, i én lé ch’èl dîṡen tûm só» (Sì, sono lì che dicono prendimi su, raccoglimi).
Il significato è chiaro: «L é lé ch’al dîṡ tûm só» tutto quello che non c’è o che è difficile da trovare.
In analoga circostanza un marito, in altri tempi, avrebbe risposto: «sé, i én lé ch’î cåvven» (sì, sono lì che covano).
♣ ♥
SCUASADÉN
(Pioggia breve e improvvisa)
Si dice, di chi non è molto sveglio di mente, che è nato la notte della breve e improvvisa pioggia: «L é nèd la nòt dal scuasadén». La ragione per la quale la nascita di uno sciocco sarebbe propiziata da una pioggia breve e violenta non è chiara.
I nostri nonni ci ricordavano, in giorni molto lontani, che i bambini nascono sotto i cavoli. La pioggia violenta, non danneggia solo la frutta, danneggia anche i piccini che attendono l’alba per essere raccolti. Del resto, di uno sciocco si dice, come della frutta, che è un po’ tocco.
♣ ♥
SPARADÈL
(Striscia di cuoio cucita tra la suola e la scarpa)
«Andèr fòra dal sparadèl» Uscire dallo “sparadello” corrisponde all’italiano: uscire di senno, impazzire.
Senno è, in bolognese, «al giudézzi». Si dice «Pêrder al giudézzi», (Perdere il senno),« Avair pôc giudézzi» (Avere poco senno), «Métter giudézzi» (Mettere senno), «Andèr fòra ed giudézzi» (Uscire di senno). La parola «giudézzi» oltre che difficile da pronunciare, sarebbe stato anche poco efficace: allora i bolognesi hanno cercato qualcosa di più fantasioso e divertente. Così chi dà i numeri, invece di uscire di senno, «al và fòra dal sparadèl» (Va fuori dallo sparadello) che è quella striscia di cuoio cucita tra la suola e la scarpa.
Vi sono naturalmente altri modi per indicare la pazzia: «Andèr a quèrt» (Andare a quarti di luna), «Andèr in Sant’Iṡî o al nómmer nuvanta» (Andare in Via Sant’Isaia o al numero novanta) dove c’era l’ingresso del manicomio provinciale.
Di chi si comporta in modo strano, si dice: «Ai bâla al zócc» (Gli balla la testa). Si può essere «Mât cme na cavâla» (Matto come una cavalla), «Mât stlè» (Matto spaccato).
Il vecchio bolognese, infine, mormora scuotendo il capo: «Åu, Ronchèti» (Oh! Roncati): Francesco Roncati fu per molti anni direttore del manicomio che porta il suo nome.
♣ ♥
CHÈREN
(Carne)
Un proverbio italiano dice: “Uccellin che mette coda, mangia ogni ora”, per dire che ai bambini che crescono non bisogna lesinare il mangiare. In dialetto si dovrebbe dire:«Uṡlén ch’métt la cô mâgna ògni åura». Non occorre essere bolognese per rendersi conto che, così conciato, il proverbio suona falso come una moneta fasulla.
I bolognesi, invece, dicono: «Chèrn ch’crass, mâgna spass» (Carne che cresce, mangia spesso). E’ un modo meno allusivo e gentile, ma certamente più efficace e il significato del proverbio rimane identico.
♣ ♥
SPÅUSA
(Sposa)
La storiella è risaputa ma graziosa. Siamo nell’Ottocento quando le donne portavano monumentali vestiti ricchi di imbottiture.
Un tale, presumiamo di campagna, prende moglie. La sera, quando la casa è già immersa nel silenzio, si sentono all’improvviso delle grida. È lo sposo che disperatamente urla. «Curî, curî parént, che la spåuṡa la và a finîr in gnént» (correte, correte parenti che la sposa va a finire in niente,si squaglia).
Tolte le vesti imbottite, la sposina si era rivelata più magra di quel che il marito potesse supporre.
L’espressione è poi rimasta per indicar qualunque cosa si riveli meno consistente del previsto.
♣ ♥
BÛS
(Buco)
Di uno che spende più di quello che guadagna o che si è imbarcato in un’impresa che va al di là delle sue forze o delle sue possibilità, in italiano si dice che ha fatto il passo più lungo della gamba: «l à fât al pâs pió lóng dla gamba». Ma i bolognesi sanno essere ancora più espliciti, quando affermano: «Ch’al vôl fèr al strånz pió grand dal bûṡ» (Che vuole fare lo stronzo più grande del buco).
Volgare ma efficace.
♣ ♥
ZÍO
(Zio)
C’era un certo Fonso che abitava al piano di sotto. Faceva il falegname, ma non aveva granché, almeno così dicevano e spesso non aveva niente da fare. Allora andava in cortile a fare due chiacchiere con i vicini, per nulla preoccupato. I ragazzi pensavano che la sua spensieratezza derivasse dal fatto che aveva uno zio che regolarmente lo soccorreva nei momenti di bisogno. Diceva infatti: «A sån in bulatta, biṡågna ch’a vâga dal zío».
Ci andava, infatti, e al ritorno mostrava il borsellino con le monete.
Ma in dialetto bolognese: «Andèr dal zío» significa andare al Monte di Pietà, uno zio piuttosto interessato, almeno ai tempi di allora, che dava sì un mucchietto di monetine, ma che si prendeva la collanina della Fonsa, l’orologio di «Iacmén» (Giacomino), i gemelli d’oro di Callisto.
♣ ♥
ÂCUA
(Acqua)
«L’âcua la fà marzîr infénna i fundamént» (L’acqua fa marcire anche le fondamenta).
“Bevevano i nostri padri? “- Si domandavano in coro i clienti delle osterie. Poi accertato che i padri bevevano, aggiungevano giocondamente: “e noi che figli siamo beviamo, beviamo”. Era anche una canzone cantata durante la festa delle matricole all’Università di Bologna. (Festa che non si fa più da tempo).
Un tempo il popolino considerava più che naturale terminare la settimana con una sbornia solenne. La notte del sabato la città risuonava tutta delle grida, dei canti, delle imprecazioni, dei lamenti degli ubriachi. E, frammiste a questo vociare, le urla di chi protestava dalle finestre per il sonno interrotto o le frasi scherzose lanciate a gran voce dai passanti: «Duro! Mo che scimmia! Qualla sé, ch’l’é una bèla câsa».
L’ubriaco faceva parte del paesaggio notturno della città: nessuno si scandalizzava. Era naturale bere, come dormire, mangiare, fare figli e morire tormentati dagli incubi del delirium tremens. Del resto che cosa sarebbe rimasto ai facchini, ai braccanti, agli operai se avessero rinunciato al mezzo di vino o al bicchierino di grappa? Soltanto una malinconia di una vita senza speranza.
Evviva il vino, dunque! E al diavolo il fegato! «Ògni dé pâsa un dé» (ogni giorno passa un giorno), diceva la gente. Era un carpe diem del popolo. E allora beviamo, dimentichiamo i guai, le miserie, la moglie ammalata, i figli laceri. E a chi invitava alla moderazione, la risposta, convincente come un assioma: «L’âcua la fà marzîr infénna i fundamént» (L’acqua fa marcire anche le fondamenta).
♣ ♥
PRÈST
(Presto)
«Pió prèst che sóbbit» (Più presto che subito). «Cmanda la Franza, eh?» (comanda la Francia, eh?) dicevano gli amici al nonno. E infatti in casa comandava la nonna, tipo energico, dai modi bruschi e autoritari. Le piaceva dare ordini: a uno pulisci qui, a un altro compera questo e questo.
Si andava a prendere il latte in latteria, dove vendevano le cioccolatine con la figurine degli attori e le trottole di latta per pochi soldi.
«A m arcmànd» (Mi raccomando) diceva la nonna «fà pió prèst che sóbbit» (fa più presto che subito). Si correva perché la nonna non solo comandava, ma adoperava le mani, e per fare più presto che subito non bisognava perdere nemmeno un secondo.
♣ ♥
DINTÉN
(Dentino)
All’uscita della fabbrica, in un quartiere della periferia, alcune giovani operaie, la Fonsa, la Gisella, la Cleonice, aspettano l’autobus.
Due pappagalli cercano di “attaccare”. Niente di male: qualche frase galante, qualche spiritosaggine. La Gisella e la Cleonice sorridono divertite, ma la Fonsa, che ama far l’ingenua, mostra di non gradire le attenzioni dei due e li aggredisce con un: «Cretini» che fa voltare la gente.
«Eh» fa uno dei giovani,«Cum l é catîva!» (Eh, com’è cattiva!)
«Cattiva o non cattiva» ribatte la Fonsa «se non la smettono chiamo una guardia. Non ho mica l’abitudine di parlare con uomini che non conosco»
«Mo sé» risponde l’altro «Ch’la m måsstra bän s l à al dintén in båcca!» (Ma si, mi mostri bene se ha il dentino in bocca).
Così garbatamente i bolognesi prendono in giro chi vuol mostrarsi ingenuo e sprovveduto: «mostrami se hai il dentino in bocca». Visto che sei così innocente e puro mi viene perfino il dubbio che tu non abbia nemmeno messo il primo dentino.
♣ ♥
RÅNPER L’ÂRIA
(Rompere l’aria)
L’ambiente è quello piccolo borghese. Diamo ai padroni di casa un nome petroniano: Scannabissi. È il giorno degli addobbi. Al centro c’è il tavolo con i piatti di torta di riso, la ciambella le bottiglie di Alchermes.
La signora Clementina, minuta e vestita di nero, amica degli Scannabissi, entra in casa per far visita alla famiglia. Parlano degli addobbi, della processione, della banda che suonerà la sera; poi la signora Scannabissi domanda alla Clementina se «vuol favorire».
«Grâzie tant» dice la Clementina (parla un bel dialetto aperto di una volta) «Mo såul un pôc ed brazadèla par rånper l’âria». (Grazie tante, ma solo un poco di ciambella per rompere l’aria).
Ai non bolognesi questo «un po’ di ciambella per rompere l’aria» non dirà probabilmente niente, ma chi ha sentito parlare i petroniani di una volta riporta l’immagine di un clima e di un mondo talmente lontano da sembrare irreale.
♣ ♥
PULÄNT
(Polenta)
Un tizio in ristrettezze batte all’uscio di un amico. Questi lo ascolta, lo compiange, lo esorta a farsi coraggio, ma non scuce nemmeno una lira; i tempi sono duri, dice sospirando.
L’altro torna a casa: «Ti ha dato niente?»
«Sé» risponde «al m à dè egli òs dla pulänt» (Sì, mi ha dato le ossa della polenta).
«C’era da immaginarselo» sospira la moglie «l é tante strécc ch’al dscurdgarêv un pdòc par cavèri la pèl» (é così stretto (tirchio) che scorticherebbe un pidocchio per ricavarne la pelle».
Avrebbe anche potuto dire: «A tôr só quall ch’lâsa lú-lé dóvv l é pasè ai môr d fâm una furmîga» (A raccogliere quello che lascia dove è passato, muore di fame una formica).
Oppure: «A n dà da pluchèr gnanc una cåddga» (Non dà da piluccare neppure una cotica). Oppure: «A n i câsca gnént» (non gli casca niente). O ancora: «L é strécc cóme una péggna vairda» (Stretto come una pigna verde – acerba).
♣ ♥
SMÊCO
(parola che significa qualunque materia atta a coprire un difetto)
«Fèr al só ṡmêco» vuol dire fare, in apparenza, la sua figura. Lo ṡmêco è (era?) una specie di cera che gli scultori spalmavano sulle loro opere, per rifinirle e aumentarne la bellezza. Metaforicamente significa qualunque materia atta a coprire un difetto.
Si diceva, riferendosi per esempio ad un vecchio mobile: «Dâi in vatta un pôc d ṡmêco parché al fâga la sô bèla figûra» (dagli sopra un po’ di «ṡmêco» perché faccia la sua bella figura).
Anche il belletto è uno «ṡmêco», come tutti i prodotti di bellezza usati da uomini e donne per restaurarsi il viso.
♣ ♥
SANMICHÊL ARBALTÈ
(San Michele rovesciato)
Passa un ometto male in arnese, in cattiva salute. Il popolano dice: «Al pèr un sanmichêl arbaltè» Per San Michele, si intende “trasloco”; «Arbaltè», significa “rovesciato”. Un trasloco, insomma, com’erano quelli dei poveri, un tempo. Un misero carretto, poche cianfrusaglie, il marito che tirava sbuffando tra le stanghe, la moglie che spingeva e i figli che tentavano di puntellare alla meno peggio il carico pericolante.
In una commedia di Fiacchi, “Al Sgnèr Pirén” (Il signor Pierino) così viene descritto un trasloco: «Alla destra (del carretto) a i êra mé con (c’ero io con) il Duomo di Milano, di carta intaliata (intagliata), dirò accosì (così), un mio errore di giovinezza al quale però ho afezione (mi sono affezionato) perché a m custò dla fadîga (mi costò della fatica) e otto soldi di gomma, che allora era di quella vera arabica, brîṡa cómm l é qualla d adès, ch’la s plócca (non come quella di adesso che si lecca), la s plócca e l é listàss che gnént (si lecca ed è la stessa cosa che niente). La mia Ergia (Argia), puvréṅna (poverina), l avèva in brâz la sô tulatta (in braccio la sua toilette), coperta se vogliamo da un burazino (strofinaccio) il quale lasciava però che si vedessero le forme dell’oggetto in questione. La mî Lucrezia l avèva dsfudrè una bûrsa ed pèl (La mia Lucrezia aveva sfoderato una borsa di pelle), che io, a dîr la veritè, a n i avèva mai véssta (a dire la verità non gliela avevo mai vista), un arcordo di un suvo (un ricordo di un suo) fratello morto in Russia congelato con Napoleone il grande, e ci aveva messo dentro le gioie di famiglia, poche e per la maggior parte, matte, e in brâz da cl ètra banda (e in braccio dall’altra parte) l avèva ón ed chi banbinén ed zîra (aveva uno di quei bambinelli di cera) che sembravano vivi, e che lei tiene caro perché dice che assomiglia alla nostra Ergia quand l èra céṅna (Argia quando era piccola)»
Il detto “far Sanmichele” è molto antico. Risale al tempo in cui i contratti di locazione scadevano il 29 settembre, giorno di San Michele, e non l’otto maggio come avvenne più tardi.
♣ ♥
ARÄNGA
(Aringa)
«L’è dura l’aränga» (E’ dura l’aringa*)
A pianterreno abitava la Gigia, che era vedova e aveva cinque figli. Tutti i giorni andava al gruppo rionale a prendere la minestra. Tornava portando una pentola piena di riso e fagioli e un po’ di pane.
D’estate la gente stava seduta sotto i portici, c’era anche il nonno, mangiava pane e mortadella. La Gigia passava, con la sua pentola, e, quand’era entrata in casa, il nonno, scuotendo il capo, mormorava: «Eh, l è dura l’aränga». (E’ dura l’aringa, come dire è dura la vita)
Non era una protesta, era la rassegnazione di quanto fosse difficile e tribolata la vita dei poveri.
(*) L’aringa era il pesce più comune e meno costoso che si trovava sul mercato. Veniva venduta pressata in grandi barili esposti, aperti, nelle vecchie drogherie.
♣ ♥
BÅCCA
(Bocca)
«Avrir la båcca pr arsurèr i dént» (Aprire la bocca per rinfrescare i denti).
Un modo bolognese per offendere. Nel parlare bolognese manca quasi del tutto quel tipo di ingiuria che in altre parti fa balenare il coltello. Alla parola dura, che lascia il segno come una frustata, i bolognesi preferiscono la frase spiritosa, il gioco di parole, l’immagine colorita. Graffiano e come, ma sul momento non lasciano il segno. Il segno esce dopo, quando, ripensandoci, ci si accorge che l’ingiuria era nascosta dietro la battuta divertente.
Così se, litigando, noi diciamo:«Ló l avérra la båcca såul pr arsurèr i dént» (Lei apre la bocca solo per rinfrescare i denti), l’altro, tutt’al più ribatterà che siamo noi a rinfrescare i denti. Eppure il giochetto di parole voleva significare che l’altro parlava a vanvera, faceva discorsi stupidi; che, insomma, l’unico risultato del suo gran vociare era di dare aria alla dentatura.
♣ ♥
CUNFURTADÅUR
(Confortatore, colui che conforta)
La donnetta è stata colpita da un lutto ed ora spesso piange. Le vicine cercano di farle coraggio. Si fanno i soliti discorsi di circostanza: abbia fede in Dio, lui poveretto non soffre più, ecc.
La donnetta ascolta, poi scuote il capo: «Lì la dscårr parché a cunfurtadåur n i dôl la tèsta» (Lei parla perché al confortatore non duole il capo).
A Bologna si dice anche: «As supôrta méi i guâi di èter che i sû» (Si sopportano meglio i guai degli altri che i propri).
♣ ♥
DÂI DAL ŻASS
(Dagli del gesso!)
Questo modo di dire bolognese deriva dal carnevale. Un tempo non usavano i coriandoli di carta ed i bolognesi usavano « I curiandèl d Månt Dunè» (I coriandoli di Monte Donato).
Monte Donato è a pochi chilometri da Bologna, sulle colline. Un tempo c’erano ricche cave di gesso; oggi ci sono villette signorili.
I coriandoli di Monte Donato erano ovviamente di gesso; anzi erano semplicemente gesso, in polvere o in scaglie o in blocchetti.
C’erano carri appositamente costruiti e gente debitamente bardata: camicione bianco e maschera di fitta rete metallica che gettava palate di gesso sulla folla. E c’era gente fra la folla, altrettanto debitamente bardata, che restituiva gesso a quelli dei carri.
Il grido di battaglia era: «Dâi dal żass» (Dagli del gesso).
Dicono che i bolognesi di un tempo ci si divertissero pazzamente e deve essere vero giacché «dâi dal żass» (dagli del gesso), diventò un modo di dire assai popolare.
In una poesia di Bonzi una fioraia dell’Arena del Sole, dopo aver invano offerto dei fiori ad uno spettatore, così esclama: «A n vól tôr gnénte, da bån? Pròpi as capéss che tótt quall ch’cåssta di góbbi a ló an i pièṡ. Oh ch’strâz ed boletèri….dâi dal żass» (non vuole prendere niente davvero? Si capisce proprio che tutto quello che costa dei soldi a lei non piace. Oh che straccio di uomo in bolletta…. dagli del gesso).
Dagli del gesso, insomma: al tirchio, come al pretenzioso, al cattivo giocatore di carte, come al chiacchierone
♣ ♥
SFORTUNÈ
(Sfortunato)
«A chi nâs sfortunè a i casca la cà in có» ( A chi nasce sfortunato gli cade addosso la casa).
E’ vero la fortuna è bendata e pesca tra gli uomini, ma la sfortuna sembra invece fare con molta cura le sue scelte e, trovata la vittima, raramente l’abbandona.
Di questi poveracci, destinati a ricevere addosso la casa, si dice che «I én sfortunè cómm i can in cîṡa» (che sono sfortunati come i cani in chiesa). E, infatti, chi è più sfortunato di un cane in chiesa? Non lo vogliono, lo cacciano. I cani non sono ammessi, se non in determinate circostanze.
♣ ♥
NAPOLEÅN
(Napoleone)
Non c’era gusto ad arrabbiarsi con la zia. Si poteva anche gettare a terra un piatto o urlare, per farla arrabbiare, ma la zia dava una alzata di spalle e mormorava: «Urla pure. La i é pasè anc a Napoleån» (Urla pure. E’ passata anche a Napoleone), Se la rabbia è passata a Napoleone, sarebbe passata anche a noi.
Non aveva grande stima dei grandi capi del tempo, era una antifascista di quelle radicate nelle sue convinzioni.
Diceva: «A n i fó mâi palâz d inperatåur ch’a n i èva pisè dänter un muradåur» (Non ci fu mai un palazzo d’imperatore dove non abbia pisciato un muratore), oppure: «A n i fó mâi bèla schèrpa ch’l a n dvintéss brótta zavâta». (Non ci fu mai una bella scarpa che non diventasse brutta ciabatta).
Era una bella donna, ma morì zitella. Forse era un po’ indisponente.
♣ ♥
FURBÉN
(Furbastro)
«Al furbén dal deṡêrt» (Il furbastro del deserto).
Ci sono due versioni sull’origine del detto che fu popolarissimo a Bologna attorno al 1936.
Siamo in Africa. Un soldato sta sudando in una zona desertica. Passa un aeroplano e lui comincia a correre a perdifiato.
«Ma che cosa fai?» gli domanda il commilitone.
«Ohi, rincorro l’aeroplano per stare all’ombra delle ali».
Siamo in Africa: due esploratori camminano nel deserto, uno davanti l’altro dietro. Quello dietro tocca con la mano la spalla del compagno che si volta e domanda: «Ît stè té?», (Sei stato tu?).
Sia il soldato sia l’esploratore sono furbastri del deserto.
♣ ♥
CAVÉCC’
(Cavicchio)
«Nâser con al cavécc’» (Nascere col cavicchio).
Ci sono vari tipi di cavicchio: si chiama cavicchio il legnetto rotondo e appuntito a una estremità che si pianta nel muro o a un asse per appenderci roba; è un cavicchio il legno rotondo e appuntito, di maggiori dimensioni, con cui si fanno i buchi nel terreno per piantare o seminare ortaggi; anche il piolo delle scale di legno portatili si chiama cavicchio.
Sulle navi i cavicchi sono piccole zeppe troncoconiche di legno duro usate per turare i fori lasciati dai chiodi nel fasciami di legno e di acciaio; negli strumenti musicali, invece, il cavicchio è il piolo girevole a cui si annodano le corde.
Nel caso del dialetto bolognese non sappiamo bene di quale genere di cavicchio si tratti; sappiamo solo che nascere «con al cavécc» significa essere fortunati fin dalla nascita. Si capisce bene, senza doverlo specificare, dove sia necessario avere il cavicchio al momento della nascita. Possiamo assicuravi che chi ce l’ha sarà accompagnato per tutta la vita dalla buona sorte.
Esiste perfino un inno al cavicchio. E’ di un poeta dialettale dell’Ottocento: Antonio Chierici. Secondo il Chierici: «Al cavécc’ méss pulidén / fà sapiént i sumarén / pr al cavécc’ as pôl utgnîr / nâstr e cråus da cavalîr / pr al cavécc’ cla fâta ctè / acsé bän s é maridè / sänza mérit, sänza blazza / l’à avó tanta contintazza». ( Il cavicchio messo a posto bene / fa sapienti i somari / per mezzo del cavicchio si può ottenere / nastro e croce di cavaliere / per mezzo del cavicchio quella tipa fatta così così / si è maritata molto bene / senza meriti e senza bellezza / ha avuto tanta contentezza).
Ma attenzione, non sempre dal «cavécc’» deriva prosperità. Se vi capita di battere «al cûl int un cavécc’» (di battere il sedere in un cavicchio), non rallegratevi, significherà che avete dichiarato fallimento.
♣ ♥
LUMÈGA
(Lumaca)
In campagna i bambini giocavano con quello che trovavano. Non erano rare le lumache che strisciavano tra l’erba o nelle siepi. Quando ne trovavano una “chiusa” con il corpo, appunto, racchiuso nella sua casetta, si mettevano a recitare una cantilena:
«Lumèga, lumèga,
tîra fòra quâter côren.
Ónna par mé,
ónna par té,
e qualli ch’ai avanza,
dâli a tô maré».
(Lumaca, lumaca, tira fuori quattro corna. Una per me, una per te, e quelle che rimangono, dalle a tuo marito).
♣ ♥
ÈSER DA ÔV E DA LÂT
(Essere da uova e da latte)
Essere da uova e da latte. Il modo di dire deriva dal commercio delle aringhe che potevano essere femmine con massa di uova in formazione e maschi con sacca spermatica (latte).
Il bottegaio usava chiedere al cliente quale preferiva. Se il cliente era indifferente rispondeva: «Mé a sän da ôv e da lât». (Io sono da uova e da latte).
Il detto è divenuto proverbiale per significare disponibilità ad ogni soluzione.
♣ ♥
CARÅGGNA
(Carogna)
Finiva a botte, fra i ragazzi, soltanto quando nelle dispute qualcuno tirava in ballo il nome e l’onore della madre. Si poteva passare sopra a qualunque offesa, ma questa no. Così, era anche fra gli adulti e più di un colpo di coltello fu vibrato per un apprezzamento pesante nei riguardi di una mamma, di una sorella o di una moglie. Qualcuno allora deve aver pensato: troviamo un eufemismo che consenta l’offesa e riduca il rischio.
Nacque così: «Caråggna té e chi t à dè la maila còta» (carogna te e chi ti ha dato la mela cotta). Come ben sanno i meno giovani, la mela cotta sostituiva frequentemente la poppata nell’alimentazione dei neonati.
♣ ♥
BUTAIGA
(Bottega)
Passa un giovanotto ben vestito, aitante, pipa in bocca. Sale su un’auto sportiva e parte. La giovane non nasconde una certa ammirazione, ma la madre interviene. «Ma che cosa guardi? Io quei tipi lì, li conosco. Tótt quall ch’é in mâsstra l é in butaiga» (Tutto quello che è in mostra è in bottega). Vale a dire che non c’è altro in quella persona oltre l’apparenza.
«Avair la butaiga avêrta» (Avere la bottega aperta) non ha alcun riferimento con la frase precedente: significa avere dimenticato di abbottonare la patta dei pantaloni.
♣ ♥
LÄNGUA
(Lingua)
I giovani, in genere, sono pigri. La Fonsa dice al figlio: «Vai ben giù un momento a comperare il latte»
«Ma la lattaia è lontana» si lamenta il figlio «e io sono stanco».
«Mó sé, figurati» ribatte la Fonsa «a fare tutta quella strada, a t sûda la längua in båcca» (Ma sì, ti suda la lingua in bocca).
«A t sûda la längua in båcca» viene anche usato per prendere in giro chi, per spavalderia, sostiene di avere caldo, mentre trema dal freddo.
♣ ♥
ANDÈR A TRABB
(Andare a «trabb» cioè “a trebbo”, significa “riunirsi con altre persone”
D’inverno, in campagna si andava a «Trabb» ci si riuniva nelle stalle, dove c’era più caldo per la presenza degli animali, e nello stesso tempo le donne filavano la lana o la stoppa, e spesso si raccontavano storie e favole. Spesso c’era qualcuno che raccontava storie e lo faceva di mestiere. Era un momento di collettività fraterna davvero irrecuperabile.
Se non c’erano le stalle si andava a «trabb» nelle case dei vicini e l’atmosfera non cambiava.
Ci scrive Nonna Elena.
Fantastico! Amo il dialetto, sono le nostre radici! Ci sono modi di dire che sono molto più efficaci in dialetto che in italiano.
Ricordo un detto del mio nonno materno che riusciva a farmi piangere quando ero piccolina: «Stét qué stasîra, c’andän a trabb da Fróll?» (Stai qui da me questa sera e vieni con me a casa di Frullo a sentire le sue storie?). Ma io piangevo perché la sera volevo andare a casa mia!
Allora per farmi ridere mi raccontava:
«Al sêt che ägli òt ai vén cal nôv dutåur ch’al dîṡ che ägli ónng’ di pî i én dågg?» (Lo sai che alle otto verrà quel nuovo dottore che dice che le unghie dei piedi sono dodici?), dove si usano i numeri sette, nove, dieci, undici nel senso di “sai, nuovo, dice, unghie”.
(Grazie Nonna Elena)
♣ ♥
PULINTÉIN
(Pastetta – Imbroglio)
Dice il protagonista di una canzonetta di Carlo Musi: «Al månnd l é fât acsé» (il mondo è fatto così). Trovatevi in un paese di provincia come in una città grande all’epoca delle elezioni. Sentite una gazzarra, vedete un fermento da perder la testa! Manifesti di ogni genere, ognuno dei quali, questo si capisce, tira l’acqua al suo mulino!
Dal sindaco all’operaio «Tótt i s dan d’atåuren» (tutti si danno da fare) per propagandare le proprie massime: volete abolire del sale? Volete l’abolizione dell’ordine? Distruggere tutto quanto vi è di regolare, d’esagerato? Eleggere Tizio, Caio, Sempronio!
«E lé: åu, arcôrdet bän, té! T srè bäin ón di nûster! E quand a säin ala tirè del stròf, la dvånta tótta una pió bèla pulinteṅna d pèrt intàiṡi, ch’l é parché a n psair brîṡa dîr al sô parair e fèr capîr come due e due facciano quattro». ( E lì [quando sarai lì] oh, ricordati bene [stai attento]! Sarai pure uno dei nostri! E quando siamo alla fine delle strofe, diventa tutta una bella polentina di parti intese [larghe intese], perché lì non si può dire il proprio parere e fare capire come due più due facciano quattro).
Come avete capito, «Pulinteṅna» (Polentina) corrisponde all’italiano “pastetta”: significa cioè imbroglio, accordo segreto per un fine illecito.
Da «Pulinteṅna» è derivato «pulintén» (polentino), che è sempre un imbroglio, ma assai meno grave. Fa dei polentini il giocatore di carte che tenta dei trucchetti, la domestica che ruba qualche lira sulla spesa.
Se poi il raggiro viene scoperto, il bolognese, per restare nel campo della gastronomia, dice che l’imbroglione «L à fât padèla» (ha fatto padella) e definisce le impasticciate giustificazioni un tentativo di «inmacarunèr incôsa» (mescolare tutto come si fa col ragù nei maccheroni).
♣ ♥
NÔNA
(Nonna)
«A i è mî nôna in guflån» (C’è mia nonna a coccoloni)
In certe occasioni una bella frase in vernacolo è più distensiva di una manciata di compresse di tranquillanti. Pensate un po’ a quando vostra moglie, come sempre un po’ distratta, vi dice: «Prendi la macchina fotografica, così oggi, mentre siamo in gita, fotografiamo i bambini».
Ma voi non sapete dove si trovi la macchina fotografica (o un altro oggetto qualsiasi), siete un «gran disordinato» e il compito di mettere le cose in ordine deve per forza assumerlo vostra moglie. Così le domandate dove ha messo la macchina fotografica.
Lei, che sta pettinando la più piccola, dice che l’ha messa nel tal cassetto. Voi aprite il tal cassetto, poi riferite a vostra moglie di averlo trovato pieno di biancheria. Lei dice che è impossibile, che la messa proprio là, che non vedete mai niente.
Le dite che si renda conto di persona. Si rende conto, poi dice che allora l’ha messa forse nell’armadio. Frugate inutilmente nell’armadio, e lei vi consiglia di guardare in camera da pranzo.
Al momento di partire state esplorando il comò. Lei si affaccia e domanda: «Allora, c’è?».
Al che voi rispondete in dialetto: «Sé, a i è mî nôna in guflån» (Sì, c’è mia nonna a coccoloni).
Magari vostra moglie vi rimprovererebbe di essere volgari, ma è una bella soddisfazione conoscere un po’ di dialetto.
♣ ♥
CANZUNATTA
(Canzonetta)
«L é un quèl ch’al s cånpra con na canzunatta» (E’ una cosa che si compra con una canzonetta).
Comprare una cosa per una canzonetta significava ottenerla quasi per niente. «E’ stata una vera bazza» diceva la massaia mostrando il capo di biancheria acquistato in una liquidazione. «A l ò paghè na canzunatta» (L’ho pagato una canzonetta).
Si alludeva senza dubbio alle canzonette che gli orbini cantavano nei caffè e per le strade. «La vèl mänc dla canzunatta d un urbén» (Vale meno di una canzonetta di un orbino) si diceva infatti di una cosa di poco valore.
Gli orbini furono i juke-box della vecchia Bologna. Fin dalla metà del Quattrocento, riuniti in una compagnia che risiedeva nella chiesa di San Bartolomeo, godevano di non pochi privilegi: soltanto gli orbini bolognesi, per esempio, potevano cantare e suonare fra le mura della città. Possedevano anche un patrimonio comune che fu incamerato da Napoleone. Lavoravano a squadre. In talune solennità o quando era a Bologna qualche personaggio illustre, si riunivano per fare una serenata dividendosi il guadagno. Il duca di Montpensier, e poi suo figlio don Antonio d’Orleans, fecero sempre agli orbini generose offerte.
Alcuni furono ottimi suonatori di violino. Il capo degli orbini, Antonio Brendoli, nei primi anni del 1900, era conosciuto col soprannome di Mancinelli, celebre direttore d’orchestra.
♣ ♥
TIRASÓ
(Tira su)
Un «tirasó» è quel che si dice in italiano un “prendingiro”.
Al tempo in cui la città era cinta di mura, i frodatori del dazio issavano le merci sui bastioni servendosi di corde munite di uncino.
Erano chiamati dal popolino i «tirasó».
Dello stesso strattagemma si servivano coloro che, rimasti fuori dalle mura avevano “fatto tardi”. Con l’aiuto di amici, si facevano buttare delle corde per farsi issare sulle mura e poi lasciarsi cadere all’interno. A volte gli amici burloni, lasciavano andare le corde, facendo ricadere di nuovo il malcapitato, fuori dalle mura.
Caddero le mura, ma la parola restò fino ad indicare una persona che si prende gioco del prossimo.
♣ ♥
VINTARÔLA
(Ventarola, una specie di ventaglio per ravvivare il fuoco, ma anche foglio volante con zirudèl e componenti satirici inventato dal G.C.Croce)
«Andèr int el vintarôl. Bèda che i t métten int el vintarôl» ( Andare sulle ventarole. Sta attento che ti mettono sulle ventarole). Si diceva un tempo a chi, per esempio, indossava abiti ridicoli o diceva stupidaggini.
Perché le “ventarole”?
«El vintarôl» le ventarole, ora scomparse, erano una nota caratteristica della vita cittadina.
Vi era un tipo che girava per la città senza giacca, con la camicia sempre bianca di bucato, con in testa un cappello di paglia a tesa larga, da contadino, con un paniere al braccio da cui pendevano le “ventarole”. Queste, oltre a servire per farsi vento, perché allora i ventagli («i vintâi») erano oggetti di lusso, equivalevano al numero unico umoristico dell’anno. Su di esse, infatti, venivano fissate delle canzoni, «zirudèl», caricature allusive ai fatti più noti accaduti, ai tipi più ridicoli, alle mode più sciocche, e non vi era casa, negozio, studio in cui non fossero disposte sui tavoli «el vintarôl», e, mentre si aspettava il signor avvocato, il copista usciva dal suo sgabuzzino con le tendine verdi, per portarvi la vintarôla, dicendo, fra intrattenibili risa: «ch’al leża bän cla mattîria dal milurdén che invêzi dl’arlói l avèva un navån» (legga la battuta dello zerbinotto che invece dell’orologio aveva una rapa) e le lacrime sgorgavano dal ciglio per eccesso di ilarità.
Dice Antonio Fiacchi: “Il venditore cantava una nenia caratteristica che si perdeva nell’afa irrespirabile dei portici bui: «Bèli vintarôl, Signoriiii! Bèli canzunàtt, padrån! A i n é ed tótti el qualitè, signori. A i n é per tutti i prezzi, padrån».
Negli ultimi tempi però hanno perduto ogni caratteristica. Non più canzonette locali stampate, non più «zirudèl» argute e bonarie. Vi erano caricature tagliate da giornaletti umoristici o dal Pasquino, e le poesie: Si scopron le tombe e La bella Gigogin. Così non avevano più ragione di esistere, cessavano di essere bolognesi, e i buli e le bule della scalinata dell’Arena, avevano i loro bravi ventagli, e le tradizionali ventarole giacevano bisunte in qualche osteria giù di strada, dove il vecchio boccale non sapeva rassegnarsi ad essere scacciato dal litro”.
♣ ♥
PANCÔT
(Pancotto)
«An cradd gnanc int al pancôt» (Non crede nemmeno nel pancotto).
Il pancotto era una zuppa di pane raffermo ammollito in acqua e olio, cosparsa di croste di formaggio. Una zuppa quindi povera e fatta di cose avanzate.
A prima vista “Non credere nemmeno nel pancotto” può sembrare una frase volgare se detta con tono di riprovazione, ma anche piuttosto sciocca. Perché scandalizzarsi se uno non crede nel pancotto, in quella zuppa tanto misera e insipida?
Per un bolognese sembrerebbe più comprensibile, caso mai, rammaricarsi perché uno non crede nelle cotolette alla bolognese ricoperte di tartufo o alla zuppa imperiale.
Tuttavia la frase ha una sua profondità. È la risposta sferzante all’ateo che ipocritamente vuol far credere di avere una fede.
«Ma anch’io credo in qualcosa» dice l’ateo.
«Chi, ló?» (Chi, lei?) sbotta il credente con una sprezzante sghignazzata. «Mo s’an cradd gnanc int al pancôt»
E qui “pancôt” (pancotto) sta per la vita mondana, materiale. Come può, l’ateo, credere in Dio se non crede neppure in qualcosa di concreto, riscontrabile, addirittura palpabile come il pancotto?
A questo punto è legittimo domandarsi: ma perché “pancôt e non tajadèl? (Perché pancotto e non tagliatelle?)
Risposta: chi mangia tagliatelle è abituato ad una mensa doviziosa. Perciò non ha significato, o ne ha poco, dire a uno che può scegliere a suo piacimento fra tortellini, lasagne, maccheroncini con prosciutto, stricchetti verdi: «Lei non crede nemmeno nelle tagliatelle». Può ribattere: non ci credo perché le tagliatelle sono un piatto per ricchi.
Il pancotto, invece, era il cibo dei più poveri, dei miserrimi: al di qua e al di là del “pancôt” c’era il vuoto, c’erano il digiuno e la fame. Il pancotto assurge quindi quasi a simbolo della sopravvivenza, della Vita. Ecco perché è cosa terribile e spaventosa non credere nemmeno «int al pancôt».
♣ ♥
CIMÎR (o ancora più antico) ZIMÎR
(Cimiero)
«Avair al cimîr», alla lettera vuol dire: portare il cimiero, o l’elmo, ma il significato vero è molto meno marziale. Porta, infatti, il cimiero chi, per sua disgrazia, è cornuto.
Oggi il detto è quasi del tutto dimenticato, non perché non vi siano mogli, o mariti, che tradiscono, ma per la ragione, molto ovvia, che nessuno porta, nemmeno a carnevale, le armature con relativo cimiero.
Oggi si dice, con minore eleganza ma con più incisività: «èser bacc» essere becco.
«Balè, ragazû: l é méi eser bacc che magnèr di faṡû» (ballate, ragazzi, è meglio essere cornuti che mangiare fagioli).
«Äl côren el i en cunpâgna i dént, che i dan fastîdi quand i spónten, mó dåpp i ajûten a magnèr» (Le corna sono come i denti, che danno fastidio quando spuntano, ma poi aiutano a mangiare).
«S’la mi fà ch’a n al sèva, s’al sò ch’a séppa cuntänt par psair vîver in pèṡ e chiêt mé, lî e ló» (Se me le fa che io non lo sappia, se lo so, che io sia contento per poter vivere in pace e quiete io, lui e lei).
♣ ♥
PIÓ
(Più)
Due stanno litigando: «Ló l é un èṡen» (Lei è un asino), fa uno.
E l’altro:«Al pió cgnóss al mänc» (il più conosce il meno).
È un modo elegante per replicare a un’offesa.
♣ ♥
ÀNŻEL
(Angelo)
«Avair durmé in brâz al ànżel» (Aver dormito in braccia all’angelo).
Secondo i nostri nonni aveva passato la notte in braccio agli angeli chi si svegliava sereno e felice. Le celestiali creature erano, insomma, i tranquillanti dei bolognesi di un tempo.
Il marito apriva gli occhi, sorrideva e la moglie diceva: «As vadd ch’l à durmé in brâz ai ànżel ».
Non sempre, però, l’alba coglieva i bolognesi di buon umore. La moglie se ne accorgeva subito, dal primo sguardo feroce, dal primo mugolio all’aprirsi della finestra. Allora sospirava e diceva: «Allegri, l à durmé con al cûl scuêrt» (Allegri, ha dormito con sedere scoperto).
♣ ♥
CAVÂLA
(Cavalla)
Oggi, con scarsa immaginazione, diciamo di una bella ragazza che assomiglia a un’attrice famosa o a una cantante, ma, un tempo, i termini di raffronto erano diversi: così una donna di belle forme veniva definita: «Un pèz ed cavâla da sój»
(Un pezzo di cavalla da fango)
E al suo passaggio, a testimoniare l’ammirazione, invece di frasi più o meno galanti, bastava un entusiastico: «Buonasera!”. Senza contare che, non usando ancora fra le donne del popolo il trucco, si poteva affermare di una ragazza che sembrava:«Un lât e un vén» (Un latte e un vino).
Non tutti gli apprezzamenti però erano galanti: di una ragazza molto magra, per esempio, si diceva che era devota «dla Madôna degli âs» (della Madonna delle assi). Quando una ragazza era molto magra, senza seno e senza rotondità, veniva paragonata, con lo spirito che contraddistingue i bolognesi, ad un asse di legno.
♣ ♥
PIPÉN
(Pipetto, piccola pipa)
«Carghèr int al pipén» (Caricare nel pipetto).
In genere, tra due litiganti, quello che si propone di caricare l’altro nel pipetto, è il più alto e il più robusto. «Carghèr int al pipén» uno, significa infatti averne ragione con facilità.
«Mé lu-lé, a m al cârg int al pipén e pó al fómm in dåu tirè» (Io, quello lì, me lo carico nel pipetto e poi lo fumo in due tirate).
Ma non sempre è il più prestante o il più apparentemente dotato ad avere la meglio. Ci sono tipi dall’aria non molto sveglia che riescono a fare una brillante carriera. Allora si dice: «Al parèva un cretén e invêzi a si é carghè tótt int al pipén» (Sembrava un cretino e invece se li è caricati tutti nel pipetto).
Il pipetto (o pipino) cui si allude è certamente il vecchio «Pipén da muradåur» da muratore, un piccolo vaso di creta nel quale era conficcato un grosso tubetto di legno. Costava un soldo, carico e con lo zolfanello.
Un tempo, quando le tecniche dello judò e del karatè erano del tutto ignote e un uomo alto e robusto poteva, con un certo margine di sicurezza, minacciare di caricare nella pipa chi era piccolo ed esile; oltre al «Pipén» la gente fumava anche la genovesina, più piccola, più svelta e più canterina delle altre.
Queste notizie sono state prese da un Almanacco di “Ehi! Ch’al scûsa del 1892”. Secondo l’autore dell’articoletto al «Pipén da muradåur» alle prima boccate spellava la lingua e il palato, ma dopo, tra le pipe democratiche, si mostrava il più sincero.
Non così la genovesina che spellava la lingua con maggiore efficacia. La si fumava tenendola stretta tra i denti. C’era poi il gassino, una genovesina ridotta che faceva da “mensola al naso del fumatore che, per non bruciarsi, era costretto a tenerla in bocca quasi alla rovescia. Il fumatore del gessino – avvertiva l’articolo – è eminentemente analfabeta e vagabondo e sputa senza levarselo dall’angolo della bocca”.
♣ ♥
CÀ
(Casa)
Il facchino dai bicipiti poderosi fa guizzare i muscoli poi esclama: «A stâg qué, d cà» (Sto qui, di casa).
«A stâg qué d cà» esclama il mercante di bestiame battendo la mano sul portafogli che gli gonfia la giacca.
Sto qui di casa: cioè è qui la mia forza, queste sono le mie credenziali.
«Luvén dal Båurg» (Lupino del Borgo), il facchino che fece fortuna, vendendo concime naturale, un giorno andò ai bagni di Riolo. Il professore che allora dirigeva lo stabilimento termale, vedendolo piuttosto male in arnese, gli domandò con una certa diffidenza: «Avete poi la maniera di fare i bagni?» E Luvén, dando una bella manata sul portafogli: «A stâg qué d cà, chèro al mî profesåur» (Sto qui di casa, caro il mio professore).
♣ ♥
PÂSA L ÀNŻEL
(Passa l’angelo)
«Pâsa l ànżel» (Passa l’angelo) era un gioco dei bambini.
Uno faceva da angelo, un altro da diavolo, un terzo dirigeva il gioco. Il direttore chiamava l’angelo che rispondeva: “Non posso volare, perché il diavolo mi piglia” e il direttore: “Apri le ali e vola qui da me”.
L’angelo allora correva verso il direttore del gioco mentre il demonio gli lanciava un fazzoletto: se lo coglieva, il lanciatore rimaneva diavolo.
Questo gioco che assieme al girotondo, ai quattro cantoni, a guardie e ladri ha nutrito la fanciullezza dei bimbi di qualche tempo fa, si chiama «Pâsa l ànżel », passa l’angelo.
Un gioco di rappresentazione simbolica che ha per argomento l’eterna lotta tra il bene e il male.
♣ ♥
FRÈ DI SÊRUV
(Frate dei Servi)
«An vdrêv gnanc un frè di sêruv int la naiv» (Non vedrebbe un frate dei Servi nella neve).
A Bologna c’è la magnifica Chiesa di Santa Maria dei Servi, in Strada Maggiore, retta dai Servi di Maria. Sono frati minori cappuccini vestiti con una tonaca nera.
Non vedere un frate dei Servi nella neve, significa non trovare mai niente, dove è ovvio che ci sia.
Capita soprattutto ai ragazzi che hanno la testa tra le nuvole, di cercare una cosa che è bene in vista senza trovarla.
Allora la madre si dispera: « Mo cum avaggna da fèr con cal ragâz?– dice al marito – an truvarêv gnanc la gèra in Raggn e l’âcua in mèr» (Ma come dobbiamo fare con quel ragazzo, non troverebbe neppure la ghiaia in Reno e l’acqua in mare).
Ma il marito la prende con filosofia. «Aspetta che cresca» dice «Alla sua età anch’io ero distratto. Figurati «ch’an aré vésst gnanc un frè di sêruv int la naiv» (Non avrei visto neppure un frate dei Servi nella neve).
♣ ♥
BUSLÔT
(Bussolotto)
«Scûsum, buslôt, se at dâg un scuplôt»(Scusami, bussolotto, se ti do una scoppola).
Un tempo nei negozi non c’era il registratore di cassa, il padrone metteva i soldi in una ciotola di legno o in un bussolotto di metallo. Era una bella tentazione per il garzone di bottega quel bussolotto pieno di monetine. Una tentazione alla quale non era facile resistere.
Si racconta che un giovane commesso, durante un’assenza del principale, andasse a pescare nel bussolotto e che, forse per vincere gli scrupoli che lo facevano esitare, o per fa tacere la voce della coscienza, prima di compiere il furto, mormorasse: «Scûsum, buslôt, se at dâg un scuplôt». Il detto rimase, ironico commento alle imprese dei cassieri infedeli.
♣ ♥
NABBIA
(Nebbia)
«Insachèr la nabbia» (insaccare la nebbia).
C’è niente di più sciocco che tentare di mettere la nebbia in un sacco?
Per dedicarsi ad un’attività del genere bisogna avere al “Granèr guâst” (il granaio guasto) o, per dirla in lingua, avere qualche rotella fuori posto. Ma il bolognese può insaccare la nebbia anche senza essere sciocco, perché il detto vuole indicare il comportarsi vacuo di chi perde il suo tempo a far cose di nessuna utilità. Come, appunto, ammesso che ciò fosse possibile, introdurre la nebbia in un sacco.
♣ ♥
MÓJ
(Bagnato)
«Avair un pè a mój e ch l èter int l’acua» (Avere un piede a bagno e uno nell’acqua).
Se si prende un poveraccio carico di debiti, di salute cagionevole, tormentato da una moglie bisbetica, e fargli trovare al suo ritorno a casa l’usciere con un ordine di pignoramento, quel poveraccio ha davvero un piede in bagno e l’altro nell’acqua. È irrimediabilmente inguaiato.
Nella frase del detto bolognese, apparentemente scherzosa, c’è la malinconia di una sequenza del grande Chaplin.
♣ ♥
GARÉTT
(Garretti – Calcagni – Talloni)
«A i réd inféṅna i garétt del schèrp» (Gli ridono perfino i calcagni delle scarpe).
La felicità dell’infanzia, così piena e perfetta. Le giornate lunghe e placide. Il domani così lontano e festoso. La gioia di addormentarsi con la testa posata sulla spalla della mamma.
«Guèrda – diceva la nonna – a i réd inféṅna i garétt del schèrp» (Guarda – diceva la nonna – gli ridono perfino i calcagni delle scarpe). Ed era vero. Nulla potrà più ridarci quella gioia serena.
♣ ♥
BÛDRI
(Budrio)
Budrio, cittadina nei pressi di Bologna. La moglie insiste, non vuole averla persa. Da mezz’ora il marito l’ascolta e sbuffa. Poi improvvisamente, lui esplode: «Ohu, cinéṅna, va mó a Bûdri a fèr al dandèl». (Oh! Piccola, vai a Budrio a fare il dondolo).
La moglie si offende ed ha perfettamente ragione, perché il dondolo a cui si riferisce il marito non è, come si potrebbe pensare, un gioco. Pare che Budrio, in passato, abbia goduto di una certa notorietà per i suoi abilissimi boia. Fare il dondolo a Budrio significa perciò pendere da una corda.
Senz’altro più gentile l’esortazione: «Mó va bain a Bûdri a sdazêr l acua piuvêna». (Ma va a Budrio a setacciare l’acqua piovana), espressione che viene rivolta a chi secca con discorsi sciocchi.
♣ ♥
BÉN
(Bene)
«A t åugur tótt i bén dal månd fôra che pisèr» (Ti auguro tutti i beni del mondo meno quello di pisciare).
Un esempio della cordiale crudeltà dei bolognesi. In luogo delle drammatiche maledizioni di altri dialetti (quando è proprio fuori di sé il petroniano arriva al massimo ad augurare un “azidänt” (accidente), questo, in apparenza è sorridente: ti auguro tutti i beni all’infuori di quello di poter fare la pipì. Si può augurare di peggio?
♣ ♥
BÂFI
(Baffi)
I baffi erano un tempo il segno della maturità. I giovani li portavano sottili, due virgolette appena accennate. I baffoni folti e maestosi, quelli che con irriverenza oggi vengono chiamati “a manubrio” spettavano ai più anziani.
C’è in ogni album di famiglia, un ritratto del nonno: busto eretto, bombetta in testa, sguardo piantato, con aria di sfida, dritto dritto dentro l’obiettivo, e i baffi, volti orgogliosamente in su o ricadenti sul labbro a mo’ di tricheco, ispidi o morbidamente ondulati.
Ai ragazzi si diceva: «Té sta zétt, t an è gnanch méss só i bâfi» (Tu stai zitto che non ha ancora messo su i baffi) oppure: «T’a t fè la bèrba col sugamän» (Ti fai la barba con l’asciugamano).
L’importanza attribuita a quei ciuffetti di peli che la gente ostentava sotto il naso come i gradi di una divisa era tale che nacque un detto: «Métters i bâfi» (Mettersi i baffi) che significava mostrare i denti, farsi valere e temere.
♣ ♥
MÛSI
(Musi)
«Ch al Mûsi» (Quel Musi) non era il notissimo cantautore petroniano. L’equivoco nacque perché Carlo Musi imitava alla perfezione gli ubriachi. Era infatti dietro a chi aveva bevuto troppo che veniva gridata la frase: «Oh, ch al Mûsi».
Il Musi, cui faceva riferimento il beffeggiatore, era un liquorista che aveva il negozio in Via Barberia, all’angolo con Via Nosadella. Da quella fabbrica di acquavite, piuttosto scadente, usciva spesso gente ubriaca fradicia. Perciò, incontrando per la strada un individuo ondeggiante, veniva spontaneo domandarsi: «It stè da Mûsi?» (Sei stato da Musi?). Oppure: «It paränt ed Mûsi?» (Sei parente di Musi?).
Queste frasi, semplificate dai monelli, finirono per concretarsi in una sola: «Oh, ch al Mûsi».
L’ubriachezza, nella Bologna di un tempo, non era una scandalo. «I ciavgôn» (I chiaviconi, grandi chiaviche) o al «Salvavén» (Salva-vino: un utensile di rane o di legno, simile all’imbuto, ma di maggior grandezza, che veniva usato per travasare il vino da una botte all’altra), come venivano chiamati i bevitori, facevano parte del passeggio notturno della città. Facchini, operai, piccoli artigiani, sentivano spesso il bisogno, come si diceva scherzosamente: «Ed bagnèr la puîgla» (Di bagnare “la puîgla”, che è quella pellicina bianca che viene ai polli sulla punta della lingua). Oppure: «Bâter só la bacca a un bichîr d vén» (Battere la bocca su un bicchiere di vino).
“Bevi, bevi compar, se no vi ammazzerò” si cantava all’osteria. “Non mi ammazzar compar che tutto berrò”.
E si beveva veramente di tutto: dal «Fuiat d un zért vén ch al fa scurdèr i dèbit o ch amâza i bigâtt» (Dai quartini di un certo vino che fa dimenticare i debiti o che ammazza i vermi), all’«Albèna ch farév arsusitèr i môrt» (all’Albana che farebbe risuscitare i morti).
Dai «Cichét» (Bicchierino di grappa o altro liquore forte), ai «Bichirén ed petrôli» (Bicchierini di petrolio, ovvero di grappa). Dai «Zètt e chiét» (Zitto e quieto), ai «Sotvaus» (Sottovoce). Erano chiamati così i liquori bevuti al mattino, quando ancora la città dormiva.
Da un «Grôss e rôm» (Grosso e rum), oppure «Fîl d fèr» (Filo di ferro), o «Pardézz» (Pezzo di pietra), a un «Felicenotte», che era l’ultimo della giornata prima di andare a letto.
Il «Grôss e rôm» era un misto di aperitivi vari (marsala, vermut, ecc. e alcool) ottenuto mescendo, a due mani, con due bottiglie, entro un singolo bicchiere collocato sopra un piattino, nel quale si raccoglieva il liquido rigurgitante che si beveva poi per ultimo.
«Quant muclén èt tôlt a st åura?» (Quanti moccolini (ultimi pezzettini di una candela – per significare un’unità di misura di un liquore) hai preso (bevuto) a quest’ora? si domandavano i clienti delle osterie. Oppure: «Chissà quant t in fè del via crucis» (Chissà quante ne fai delle via crucis): le “via crucis” erano l’insieme delle soste nelle varie osterie.
A sera tutti tornavano a casa «Ch i avêven i ûcc’ ed vaidér» (Che avevano gli occhi vitrei).
Vi sono molti modi, in bolognese, per definire una sbornia: «Êser dûr» (Essere duro). «Inbarièg» (Ubriaco). «Inbarièg spånt» (Ubriaco fradicio). «Avàir la sbränza, la ciucca, la sémmia, la bâla, la casarléṅna» (Avere la sbronza, la ciucca, la scimmia, la palla, la cassettina). «Êser in ciaréṅna, in cinbalis bene sonantibus, in gringola, instiatinè, alîgher, sô ed gîr, sbranz, parté, schicchirûti, bréll, tréll, canpanél, côt, patôch, inscajè, inscufiè, inbariègh, madûr» Essere in chiaretta, in cinbalis bene sonantibus, in gringola, schizzato, allegro, su di giri, sbronzo, partito, schicchiruti (intraducibile), brillo, trillo, campanile (si allude al campanile che quando suonano le campane, dondola), cotto, patocco, incagliato, incuffiato, ubriaco, maturo).
♣ ♥
BÛS DAL PANCÔT
(Buco del pancotto)
«Al bûs dal pancôt», letteralmente il buco del pancotto, sta ad indicare, scherzosamente, l’esofago. A parte la grossolanità, l’immagine tradisce le sue origini popolaresche per il fatto di considerare la gola il buco del pancotto, che, fra le minestre, è indubbiamente la più umile ed economica, fatta com’è con pane raffermo a fettine e inzuppato in molta acqua e pochissimo olio. In ambiente borghese l’esofago sarebbe divenuto il buco dei tortellini, delle tagliatelle e delle lasagne.
«Cussa vôlla, biṡågna lavurèr pr al bûs dal pancôt» (Cosa vuole, bisogna lavorare per il buco del pancotto).
Oggi nessuno mangia più pane raffermo inzuppato nell’acqua /fra l’altro dicono che fa ingrassare), cosicché «al bûs dal pancôt» è rimasto soltanto nel fiorito linguaggio dei burattini.
«Facci la carità» dice Fagiolino eternamente affamato, «Facci la carità a un povero giovane ch l a al bûs dal pancôt tutto ruznento per il digiuno» (Faccia la carità a un povero giovane che ha il buco del pancotto tutto arrugginito dal digiuno).
♣ ♥
SCÛD
(Scudo, in bolognese significa “soldi, denaro”)
Lo scudo era la moneta pontificia formata da 100 baiocchi. Il baiocco da 10 denari.
Lo scudo fu cambiato con Decreto del 1° ottobre1859 in lire italiane 5,32.
Sino all’ultima guerra era ancora invalso l’uso di chiamare la moneta da 5 lire d’argento «al scûd».
Le monete in circolazione fino all’inizio dell’ultimo conflitto erano: 5 centesimi in rame = «al bajôch» / 10 centesimi in rame = «la bajôca da dû» / 20 centesimi di nichel = «la biziclàtta» (la bicicletta) / 50 centesimi di nichel = «al mèz franch» / 1 lira di nichel = «al franch» / 2 lire di nichel = «al cavurén» / 5 lire d’argento = «al scûd» / 10 lire d’argento = «al mèz maranghén» / 20 lire d’argento = «al maranghén». La banconota da 50 lire = «la chèrta»
Il denaro, in genere veniva detto «la grèna»
Essere ricco = «Avàir di bajûch».
Scherzosamente la banconota veniva chiamata «al svulatån» e il vecchio marengo d’oro (20 lire) «Ucén d’zvàtta» (Occhietto di civetta).
Il primo marengo d’oro, fatto coniare da Napoleone per celebrare la battaglia di Marengo, portava la scritta: “L’Italie delivrè a Marengo”. Ancora pochi anni fa, i veri bolognesi, per definire una persona falsa, dicevano: «L é fèls cómm una bajôca dal côl lóngh» (E’ falso come un baiocco dal collo lungo) con riferimento a una moneta da 10 centesimi di rame falsificata e riconoscibile perché il collo di Vittorio Emanuele II era più lungo del normale.
♣ ♥
BURDIGÅN
(Scarafaggio)
Scarafaggio (Blatta orientalis), grosso insetto blattoideo, un tempo molto comune nelle case, soprattutto se umide. Uscivano di notte a “pascolare” sui pavimenti, ma appena si accendeva la luce correvano a nascondersi. Durante l’ultima guerra giunse da noi un blattoideo più piccolo di color tabacco, la Blatella germanica.
Il nome di «burdigån» era dato anche ad alcuni Coleotteri nerastri, come lo Scarabeo sacro (Ateucus sacer), noto ai contadini come: «Burdigån dla mêrda» (Scarafaggio della merda), per l’abitudine di rotolare pallottole di sterco (nella quali depone le uova). Bruno Sgarzi ne fa oggetto di una scherzosa poesia.
«Mo guèrda, guèrda al burdigån dla mêrda
Ch l arvôlta la sô bâla!
A l ajôsta, al la léssa, la abrâza,
a la spénz con la scheṅna, con la spâla,
con al pèt, con la pânza,
con la tèsta, i zanpén;
ai fa drî una fadîga ch al l amâza.
Va là, va là, puvrén,
fra mé e té a j é bän pôca diferàinza:
avän al stass destén!»
(Ma guarda, guarda lo scarafaggio della merda/ che ribalta la sua pallottola!/ L’aggiusta, la liscia, l’abbraccia)/ la spinge con la schiena, con la spalla/ con il petto, con la pancia/ con la testa, le zampette/ fa una fatica che l’ammazza/ Va là, va là, poverino/ fra me e te c’è ben poca differenza/ abbiamo lo stesso destino!)
♣ ♥
MUIÈR
(Moglie)
«Pan d un dé, muièr d un mais e vén d un ânn» (Pane di un giorno, moglie di un mese e vino di un anno). Bisogna ammettere che i nostri progenitori avevano idee molto chiare sulla stagionatura. Tutti d’accordo no? Eppure c’era qualcuno che pretendeva addirittura di più. Gli andava bene il pane di un giorno, non eccepiva sul vino imbottigliato da un anno, ma pretendeva la moglie di quindici anni: «Pan d un dé, vén d un ânn e muièr d cuénds ânn»
E poiché siamo in tema di pane e vino (la moglie la lasciamo da parte), ecco un’altra massima che si ritrova anche in altri dialetti: «Pan con i ûcc’, furmài sänz ûcc’, vén c al chèva i ûcc’» (Pane coi buchi (ben lievitato), formaggio senza buchi (liscio e compatto), vino che tolga gli occhi (che ubriachi).
♣ ♥
NINNA NANNA
«Fa la nâna fiôl d’un frè
Ch a t diró chi l é al tô pè;
l é al curèt dla Caritè,
fa la nâna indurmintè.
Fa la nâna, fâla pûr
ch’andarän a lèt al bûr,
con la lómm sàinza stupén,
fa la nâna al mi pinén».
(Fa la nanna figlio di un frate/ che ti dirò chi è tuo padre/ è il curato della Carità/ fa la nanna addormentata/ Fa la nanna, falla pure/ che andremo a letto al buio/con la lucerna senza stoppino/ fa la nanna il mio bambino)
♣ ♥
NINNA NANNA
«Fiôca, fiôca la bianculéṅna,
aväin pan, aväin faréṅna,
aväin furmàint da masnèr,
fiôca, fiôca, s’la vôl fiuchèr».
(Fiocca, fiocca, la biancolina / abbiamo pane, abbiamo farina/ abbiamo frumento da macinare / fiocca, fiocca, se vuole fioccare).
♣ ♥
ROSA DEI VENTI IN BOLOGNESE
VÀINT
(Vento)
Veronàisa = Tramontana (vento che soffia da Nord)
Bûra = Grecale (vento che soffia da Nord-Est)
Rumagnôla = Levante (vento che soffia da Est)
Bagnamurâja = Scirocco (vento che soffia da Sud-Est)
Muntân = Ostro (vento che soffia da Sud)
Garbèn = Libeccio (Vento che soffia da Sud-Ovest)
Vàint da sîra = Ponente (vento che soffia da Ovest)
Sarnêra = Maestrale (vento che soffia da Nord-Ovest)
♣ ♥
PROVERBI LEGATI AI VENTI
La bûra trî dé la dûra = Il Grecale dura tre giorni
Sarnêra o c l avéra o c la sêra = Il maestrale o apre (rasserena) o chiude (annuvola).
♣ ♥
LA VCIATTA
(La Befana)
Ariva la vciatta c la vén da lasó
Mó quand a s è vîc an s in pôl pió
El gânb i én sutîli e sanza virtó
E anc el calzàtt in stan brîsa só.
Arriva la vecchietta che viene da lassù (/ ma quando si è vecchi non se ne può più / le gambe sono sottili e senza virtù / e anche le calze non stanno più su.
(Grazie a Roberta)
♣ ♥
TRÒTA TRÒTA CAVALÒTA
(Trotta trotta cavallina)
Tròta tròta cavalòta
Un panîr pén d arcòta
Un bèl piât ed tajadèl
par rinpîr al tó budèl
Se t ê pó d la murtadèla
la giurnè la srà pió bèla
Co i fasû dentr in t al paról
Fa la nâna ragazól
Int la pgnâta un bån cutghén
a buîr pianén pianén
Fa la nâna al mî putén.
Trotta trotta cavallina / Un paniere pieno di ricotta / Un bel piatto di tagliatelle / per riempire le tua budella / Se hai poi della mortadella / la giornata sarà più bella / Con i fagioli dentro il paiolo / Fa la nanna ragazzino / Nella pignatta (c’è) un buon cotechino / A bollire pian pianino / Fa la nanna il mio bambino / trotta trotta cavallina.
(Grazie a Mario Gnaccarini)
♣ ♥
ÂNMA
(Anima, nocciolo)
«Ânma sô, mândga sô» (Anima sua, manica sua): chi fa di testa sua, paga di tasca sua. Con lo stesso significato « Ânma sô, picâja sô».
«An s vadd un ânma» (non si vede nessuno).
Con la parola «Ânma» il bolognese indicava anche un sottile materassino di penne che, nella stagione invernale veniva posto sul pagliericcio (materasso imbottito di foglie granoturco).
Una bella poesia scritta da Brunello Sgarzi, gioca sul doppio significato della parola “anima” e “nocciolo”.
Parchè, mugnèga ed vlûd, bèla indurà,
daulza cunpâgna al mèl,
culaur dal zîl indò al saul va za,
parchè saul me, spôrch, brótt, con dantr al fèl,
avrèvv da vîver par l’eternitè,
parchè mé sé e té na?
té un ânma t l è e mé? Fôrsi, chissà?
Perché albicocca di velluto, bella dorata / dolce come il miele / colore del cielo dove il sole scende / perché solo io, sporco, brutto con dentro il fiele / dovrei vivere per l’eternità / Perché io sì e tu no / tu un’anima ce l’hai e io? Forse, chissà.
♣ ♥
CÛL
(Culo, deretano, sedere, ano)
Sono tanti i modi di dire del bolognese legati a questa parola. Alcuni scherzosi, altri sferzanti come di solito lo è il bolognese quando vuole esprimere concetti o situazioni particolari.
«Bûs dal cûl» è lo sfintere anale.
«Avàir ón fôra dal cûl» (Avere una persona fuori dal sedere) significa disprezzare una persona.
«Stèr a cûl pèra» (Stare a sedere pari, o comodamente) vuol dire stare bene agiatamente, avere dei soldi.
«Avàir al lèn e al cûl chèld» (Avere la lana ed il sedere caldo): avere tutto ciò che si desidera.
«Durmîr a cûl dscuêrt» (Dormire col sedere scoperto) quando ci si sveglia di cattivo umore.
«Avàir al cûl mêrd) (Avere il sedere sporco) vuol dire avere la coda di paglia.
«At tîra al cûl?» (Ti tira il sedere?), sei di cattivo umore?
«Èser cûl e camîsa» (Essere culo e camicia) così come «Èser cûl e patâja»: essere in grande intimità o in grande confidenza.
«Alchèr al cûl a ón» (Leccare il sedere a una persona), adulare eccessivamente una persona. Essere servile.
«Avàir un cavécc in t al cûl» (Avere un cavicchio nel sedere) significa avere una gran fortuna.
«Gratèrs al cûl» (Grattarsi il sedere), stare in ozio.
«Avàir pió cûl che ânma» (Avere più sedere che anima), avere una fortuna sfacciata.
«La camîsa a’n tôcca al cûl» (La camicia non tocca il sedere), quando una persona è molto allegra.
«Métter al cûl a mòi» (Mettere il sedere nel bagnato), di chi ha perso tutto, oppure, quando il tempo minaccia pioggia.
«Vultèr al cûl a ón» (Voltare il sedere a una persona), abbandonare una persona.
«Mustrèr al cûl a tótt» (Mostrare il sedere a tutti), spifferare i fatti propri.
«Mnèr al cûl» (Muovere il sedere), ancheggiare.
«Avàir al cûl grand comm ‘na cà» (Avere il sedere grande come una casa), avere una grande fortuna.
«Dèr col cûl int’un cavécc» (Colpire col sedere su un cavicchio), fare una cosa che torna a proprio danno.
«Avàir al fûg al cûl» (Avere il fuoco al sedere) avere una grande fretta.
«Sbâter al cûl in têra» (Battere il sedere a terra) cadere malamente.
«Èser da cûl e da pônta» (Essere da sedere o da punta), essere indifferenti nella scelta, va bene tutto.
«Bûs dal cûl ajùtum» (Buco del sedere aiutami), invocazione scherzosa.
«Psàirs gratèr al cûl d’cuèl» (Potersi grattare il sedere (almeno) di qualcosa), rinunciare a ottenere qualcosa che è impossibile avere.
♣ ♥
MUSÉIN
(Moscerino)
Di un bravo artigiano si dice che «Al fà i pî ai muséin», cioè che riesce perfino a fare i piedi ai moscerini tanto è abile e diligente nel fare il suo lavoro.
Fare i piedi a un insettuccio minuscolo come il moscerino non deve essere impresa facile, tuttavia c’è a Bologna chi sa fare meglio. C’è addirittura che sa «Adrizèr el ganb ai can» (Raddrizzare le gambe ai cani).
Una signora va dall’orologiaio con una vecchia sveglia a cui si è spaccata la molla.
«Si può aggiustare?», domanda.
«Ma certo» risponde l’orologiaio «que, sgnaura, a s adréza el ganb ai can» (qui, signora, si raddrizzano le gambe ai cani). Si compiono, cioè, imprese impossibili.
♣ ♥
ARMISDÈR
(Mescolare)
«Con pió la s masda, con pió la pózza» (Più la si mescola più puzza).
Avete indubbiamente capito, ma se non avete capito bene, la esplicheremo con un esempio.
La moglie dice al marito: «Te lo giuro, io non avevo un appuntamento con Fonso. L’ho incontrato per caso».
Il marito: «Va là, va là, l è méj lascèr pérder, parché con pió la smasda con pió la pózza». (Va là, va là, è meglio lasciar perdere, perché più la si mescola, più puzza).
♣ ♥
BRÔD
(Brodo)
«Ai córr al brôd» (Corre il brodo).
Oggi i medici hanno scoperto che il brodo disturba il fegato e rende nervosi. Se questo sia vero non sappiamo, certo è che il brodo compare nelle nostre mense con sempre minor frequenza. E se ci adattiamo a berne con una minestrina lo preferiamo fatto con i dadi, perché quello di cappone è troppo grasso e non lo digeriamo.
Una volta, il brodo, specialmente quello di cappone, era un’autentica e desideratissima rarità. Si preparava sì il brodo qualche volta, ma fatto con la cosiddetta punta di petto, che non è certamente la parte più appetitosa del bue, e qualche osso.
L’autentico brodo di cappone, il brodo dei tortellini, compariva poche volte sulla mensa del popolo. A Natale, a Pasqua e nel giorno degli Addobbi.
Gli Addobbi, a Bologna, si celebrano ogni dieci anni. Era appunto in quell’occasione che correva il brodo. «Ai córr al brôd» voleva significare che quel giorno, tutti nuotavano nell’abbondanza.
Pare che il detto tragga origine dalla distribuzione di generi alimentari che veniva fatta in occasione della festa della porchetta. Durante la festa, che fu soppressa all’arrivo dei francesi nel 1796, si lanciavano al popolo, dai balconi di palazzo Re Enzo, pane, carne e anche denaro. Sembra che venisse distribuito anche del brodo, da cui il detto: «Ai córr al brôd» (Corre il brodo).
♣ ♥
AL GENÊSI
(Il cappello a cilindro)
Perché a Bologna chiamassero «Genêsi» il cappello a cilindro, non è chiaro.
Antonio Fiacchi in “Bologna d’una volta” avanza due ipotesi: che il cilindro abbia preso il nome di «Genêsi» durante uno spettacolo all’Arena del Sole, dove uno del pubblico, che si chiamava Gennasi, col suo cappello a cilindro impediva la visuale. «Abbasso sor Gennasi» avrebbe cominciato a gridare uno del pubblico: di qui il nome del cilindro.
L’altra spiegazione, quella a cui Fiacchi sembra dare maggior credito, fa risalire il nome singolare alla somiglianza dei cappelli a cilindro con i «Cuartirû» (Quartiroli) che servivano a misurare la castagne.
«Cuartirû» erano appunto chiamati per scherzo i cilindri, prima che al vistoso copricapo fosse appioppato il nome di uno che coi «Cuartirû» aveva continuamente a che fare: il signor Gennasi, il maggiore commerciante di castagne della città.
«Purtèr al genêsi» (Portare il cappello a cilindro) non era simbolo di eleganza, ma significava essere cornuti.
C’è di mezzo anche stavolta un signor Gennasi. Alfredo Testoni lo fa mercante di granaglie: testa piuttosto voluminosa, coperta, durante le passeggiate, dal cappello a cilindro, moglie belloccia e di lui più giovane. Un giorno il signor Gennasi torna in anticipo dalla passeggiata e bussa alla porta. La moglie viene ad aprirgli con un certo ritardo: sostiene con le due mani il mezzo staio di ferro col quale il signor Gennasi misura le granaglie.
«Sai» gli dice, «una mia amica afferma che la tua testa è tanto grossa da non entrare nel mezzo staio. Io ho scommesso che non è vero e voglio fare la prova».
Il signor Gennasi, secondo Testoni, non eccepì, e la moglie gli calò fin sulle spalle il mezzo staio, mentre un uomo guadagnava velocemente la porta.
Da quel giorno i mariti sfortunati portarono «Al Genêsi».
♣ ♥
INDOVINELLO
Durmécual al durmèva,
pindécual al pindèva,
curécual al curèva,
s an gnîra pindécual, durmécual al murèva.
Soluzione: (una lepre) dormiva (sotto un pero) e (una pera) pendeva, (un cane) correva. Se non c’era (la pera, che pendendo cadde)), la (lepre) che dormiva, sarebbe morta.
Un indovinello difficile, anche per i bambini, abituati a vivere in campagna con i frutti e gli animali.
(Grazie a Lia)
♣ ♠
CHIUDI!
(Chiudi! Imperativo del verbo chiudere, ma forse, più propriamente: finiscila!)
«Chiudi!» fu un modo di dire tratto dall’operetta “La gran via”, molto in voga a Bologna, sulle fine dell’ottocento. Carlo Musi ci fece addirittura una canzonetta. Non si sa bene l’esatto significato. Lo stesso Musi, nella prima strofa, dice che questo «Chiudi!» «An s capéss cussa al sia» (Non si capisce cosa sia).
Ci affidiamo agli esempi portati da Musi: di carnevale si gridava «chiudi!» alle maschere peggio vestite. Si diceva «chiudi!», agli imbroglioni che cercavano denaro in prestito. Un «chiudi!» a squarciagola era rivolto agli ubriachi che percorrevano barcollando le vie cittadine. E «chiudi!» suggerisce Musi, bisognerebbe dire anche «A chi ragâz dla cmóuna» (A quei ragazzi del comune), che avevano decretato (alla fine dell’ottocento), di aumentare le tasse e il dazio
♣ ♠
TOSQUIGNO
(Toscano)
«Dscarèr in tosquigno» (parlare toscano).
Un tempo si parlava in dialetto perfino nella case patrizie, l’italiano, o meglio il toscano, come lo chiamavano i nostri nonni, era la lingua protocollare, quella usata negli atti ufficiali. Poi, col passare degli anni, pur restando il linguaggio di una gran parte dei bolognesi, il dialetto cominciò a perdere terreno
Rotto l’isolamento municipalistico cui l’aveva costretta il dominio pontificio, la città si inserì nel tessuto della vita nazionale. I ceti ricchi e quelli medi, un po’ per un sollecitazione snobistica, ma principalmente per una precisa necessità pratica legata ai sempre più stretti rapporti, industriali e commerciali, con le altre città, cominciarono a parlare con sempre con maggior frequenza l’italiano, che divenne, così, il linguaggio delle categorie più agiate.
Logico che il popolino fosse portato a considerare il «toscano» un segno di distinzione e, altrettanto logico, che quelle categorie di cittadini, in bilico fra la classe operaia e la piccola, anzi piccolissima borghesia, artigiani, impiegatucci, tentassero, non sempre con successo di esprimersi in quella lingua dalla quale ci si aspettava una patente di distinzione.
Ne scaturiva il buffo italiano che Alfredo Testoni ha nesso in bocca alla sua signora Arabella: «Un italian inbastardé» (Un italiano bastardo), come si diceva.
L’italiano di questa poesiola di Camillo Nunzi «Al ritaurén dai bâgn» (Il ritorno dai bagni) pubblicata in «Ehi c’al scusa» del 20 settembre 1884.
«S pó dèr d pîz, mó dît ed bän? (Può darsi che ci sia di peggio, ma dirti di bene?)
Li l am scréss con preténziän» (Lei mi scrisse con presunzione)
“Siamo invetta a una collina, (in cima)
una bella montagnina,
un casino romanzesco
uno sguizzero e tedesco, (svizzero)
e il più bello singolare
proprio avsino avsino al mare, (vicino, vicino)
anzi quando inferocisce
e che l’acqua ingigantisce
ci troviam tanto vicini
che sentiamo gli stiatini“. (spruzzi)
Il «Tosquinio» era appunto questo linguaggio. «Sént» (Senti), si diceva ironicamente, «Sént, lu lé, ch’al dscarr in tosquigno» (Senti, quello lì che parla in toscano).
♣ ♠
LA BRÈVA SPUSLÉŃNA
(La brava sposina)
La brèva spusléṅna la fa al lèt a la matéṅna.
La dôna acsé acsé al le fa in t’al mezdé.
La pôrca vacâza al le fa cuand l a s’azâca.
(La brava sposina fa il letto alla mattina / La donna così così lo fa a mezzogiorno / la porca vacca lo fa quando si mette a giacere).
Poi le ragazzine dovevano rifare i letti anche per i fratelli. Un gran lavoro perché i “tamarazzi” (materassi) non erano a molle, ma con le piume o con la lana (se erano abbastanza ricchi) o addirittura con le foglie di granoturco, se non c’erano neppure le galline da spennare. Di conseguenza si “agnoccavano” (si appallottolavano facilmente in blocchi pesanti).
(Grazie Lia)
♣ ♠
PULÓZZ
(Poluzzi)
«I ragâzz ed Pulózz» (I ragazzi di Poluzzi).
Quando si trattava di gente in divisa i bolognesi generalmente alludevano.
E dire che non mancavano loro le parole. In dialetto abbiamo «Sbérr, questuréṅ, carabinîr, pulisman» (Sbirro, questurino, carabiniere, vigile urbano), quanto basta per non ricorrere alla metafora.
I questurini, nel linguaggio dei vecchi bolognesi erano «I ragâzz ed Pulózz» (I ragazzi di Poluzzi. Per stabilire la qualifica del signor Poluzzi, bisognerebbe far ricerche all’Archivio di Stato. Probabilmente si trattava di un commissario o addirittura di un questore. In pensione lui, forse anche per brevità, i poliziotti restavano semplicemente «Chi ragâzz» (Quei ragazzi). Più tardi vennero chiamati «Chi sgnauri dal numeréṅ» (Quei signori col numerino), per via del numero che portavano sul berretto della divisa, in altri tempi, nel settecento, gli sbirri venivano chiamati «Manàtt» (Manette), chiaramente per le manette che portavano in cintura.
I carabinieri, altra gente in divisa, erano per i petroniani di un tempo «I suldè da l arma stórta» (i soldati dall’arma storta) per la sciabola che portavano al fianco, o anche «Chi sgnauri dal capplån» (Quei signori dal cappellone), il quale cappellone era il tradizionale raviolo.
I magistrati venivano chiamati «I sgnauri da la bratta naigra» (I signori dalla berretta nera), mentre i preti, per la irriverente e irridente fantasia popolare, erano «Sàcc ed carbån» (Sacchi di carbone).
♣ ♠
EPIFANÎ
(Epifania)
La nôt di trî Mègh
al stràl in t al fôs
al Cínno ch’al dôrum
in t la cónna dal Ra
la lónna in t al prè
la Mèder cla zîga
la môrt cla s arpiâta
drî a la ca’, in t l urtîga.
La notte dei tre Magi / le stelle nel fosso / il Bambino che dorme / nella culla del Re / la luna nel prato / la Madre che piange / la morte che si nasconde / dietro la casa, nell’ortica.
(Poesiola contadina della zona di Minerbio)
♣ ♠
ŻÛG
(Gioco)
«Chi an si zûga, mèl a i spand» (Chi non se li gioca, li spende male).
Il “Carpe diem” dei bolognesi è racchiuso in questo adagio che, nel mondo dei proverbi, tutti così edificanti, fa un po’ la figura della pecora nera.
Chi non se li gioca (i quattrini), dice lo sciagurato adagio, male li spende. Cioè è meglio vivere allegramente, fin che si può, piuttosto che pensare ad un domani che, per noi, potrebbe anche non venire.
♣ ♠
CAN
(Cane)
Di uno tardo a capire si diceva: «L é un pover fôra chi can» (E’ un povero fuori Checcone).
In chiesa, racconta una storiella, insieme con i fedeli entrarono anche due cani.
Il curato si rivolse allora ai parrocchiani, dicendo: «Fôra chi can» (Fuori quei cani).
Tra la gente in preghiera c’era anche un omaccione un po’ tonto che si chiamava «Chiccan» (Checcone).
Pensando che l’invito del curato fosse rivolto a lui se ne andò mogio mogio senza riuscire a rendersi conto perché fosse stato cacciato.
♣ ♠
MÓRT
(Morte)
«Ch’al fiól é la mi mórt» (Quel figlio è la mia morte), diceva la mamma lagnandosi del rampollo dai molti grilli per la testa.
«Ch’l ómen al srà la mi mórt» (Quell’uomo sarà la mia morte), sospirava la ragazza parlando del fidanzato scavezzacollo.
Il detto conobbe una certa fortuna al tempo in cui la gente moriva ancora di crepacuore.
«Ci pensi bene giovanotto» dicevano i personaggi delle commedie dialettali «pensi a quella povera fanciulla. Muti il suo sciagurato comportamento altrimenti «Al srà la sô mórt» (Sarà la sua morte).
Le cose si fanno però assai meno romantiche se da una parte, invece di un giovane sciagurato, c’è una padella piena di olio bollente e dall’altra, al posto della ragazza, un pollo pronto per essere messo arrosto. «L é la sô mórt» (E’ la sua morte), vale a dire che sta per essere cucinato nel modo migliore possibile.
Una poesiola della bassa bolognese dice:
S la vén la mórt
dgii bàin fórt,
che mé a ni sån
ch’a sån in canténna
ch’a chèv la spénna
e a trâgh al vén bån.
(Se viene la morte/ ditele molto forte / che io non ci sono / che sono in cantina / a togliere la spina / e a spillare il vino buono)
♣ ♠
PGNÂTA
(Pignatta, Pentola)
Quando a Bologna era molto attiva la fabbricazione artigianale di pentole e tegami di terracotta, era convinzione comune che la terra prelevata dai cimiteri fosse la migliore per questo uso.
Sarà vero?
Lo si potrebbe chiedere a Loris Nipoti, artista delle terracotta con storica bottega alla Beverara, sta di fatto che uno dei tanti sinonimi di “Morire” è appunto «Andèr a fèr tèra da pgnât» (Andare a fare terra da pentole).
E, grazie alla pentola, c’è un altro modo curioso che serve a definire una persona presa a braccetto da altre due, una per lato: «Fèr la pgnâta» (Fare la pentola con la braccia simili ai manici della medesima).
Nella terminologia bolognese della cucina, l’espressione «Métter só la pgnâta» (Mettere su la pentola), significa mettere sul fuoco la pentola con la carne da brodo, ma anche metaforicamente riuscire a mantenere la famiglia.
La metafora entra in azione anche quando si dice: «Stiumèr la pgnâta» (Schiumare la pentola) che significa sia togliere la schiuma dal brodo che eliminare il superfluo.
Nelle prescrizioni che riguardano la cucina, c’è anche un bel proverbio «Quand la pgnâta l é al fûg al cûl n é mâi a lûg» (quando la pentola è sul fuoco il sedere non è mai in un posto. Cioè quando la pentola è sul fuoco bisogna starle vicino, quindi il posteriore non è mai seduto).
Quando si nota qualcuno con i capelli tagliati malamente, si usa dire: «I l han tuṡè con la pgnâta» (Lo hanno tosato con la pignatta). Come se gli avessero infilato la testa in una casseruola, e tagliato solo i capelli rimasti fuori da quella specie di casco.
Per dire che certe persone malaticce vivono più a lungo di quelle sane, a Bologna c’è un proverbio: «Dûra pió una pgnâta råtta che ónna bôna» (Dura di più una pentola rotta che una buona).
Per evitare errori (anche nello scrivere) in bolognese si dice: «Un ôc’ ala pgnâta e ón ala gâta» (Un occhio alla pignatta ed uno alla gatta).
♣ ♠
MAND
(Mondo)
«Al mand l é bèl parché l è vari» (Il mondo è bello perché è vario).
Noi non crediamo alla bonarietà dei bolognesi: bonario significa di natura buona e semplice, indulgente, conciliante, privo di malizia, candito. Sotto la patina sorridente e cordiale, il bolognese nasconde unghie che graffiano, un animo fiero e insofferente d’ogni ingiustizia, un carattere un po’ chiuso.
Vi parlerà del tempo, della partita di calcio, di politica, ma raramente di se stesso, sicché al termine di una conversazione cordiale, divertente e in apparenza molto confidenziale, vi accorgerete di non sapere assolutamente niente di lui, nemmeno se ha moglie o figli.
Forse la bonomìa è in realtà soltanto lo scetticismo di un popolo di antica, civilissima tradizione, che affronta serenamente, con comprensione e saggezza, la vita.
Ecco perché a Bologna, teatro di episodi di fiero eroismo durante le tormentate vicende della città, la gente raramente viene alle mani. Non è bonomia o mitezza, è semplicemente civiltà. Quella civiltà che, quando la discussione si fa troppo accesa, induce il petroniano a troncarla con garbo: «Aho, sèl cussa i è d nôv? Che al mand l é bèl parché l é vari. E parché ognón la peinsa com ai pèr» (Ah! Sa cosa c’è di nuovo? Che il mondo è bello perché è vario. E perché ognuno la pensa come gli pare).
♣ ♠
GIÔSTRA
(Giostra)
Di una cosa sgangherata si diceva: «L é tótta scalastrè cm é la giôstra ed Sandréin» (È scassata come la giostra di Sandrino).
Sono pochi a Bologna quelli che ricordano la popolarissima giostra (come ha scritto Bianconi) assai più nota di qualche monumento nazionale. Ha divertito una moltitudine di gente di ogni età: piccoli, e grandi, domestiche, popolane e militari di bassa forza: i grandi per far divertire i piccoli, i militari per far divertire le ragazze e se stessi, tutti su quella specie di setaccio frullante.
A memoria d’uomo fu sempre sgangherata. Il suo organo musicale soffiava da tutti i buchi, tranne che da quelli corrispondenti alle note, per cui le suonate riuscivano qualcosa di indescrivibile.
Il suo cavallo di battaglia fu l’Inno di Garibaldi (Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda ecc……).
Eppure girò per anni e anni divertendo incessantemente.
Un brutto giorno non la vedemmo più.
♣ ♥
CÓPP
(Tegole o Coppi)
«Purtèr só i cópp» (Portare su le tegole, in italiano è corretto anche chiamarli coppi).
Oggi sono le gru e i montacarichi, ma un tempo era il manovale che portava su le tegole o i mattoni. Otto, dieci per volta, nella “mastella” (secchio di metallo (per lo più ferro zincato), arrampicandosi per le traballanti scalette di legno. Naturalmente la scalata si faceva più lunga quando arrivava il momento di portare su le tegole, perché quelle servivano per il tetto.
I muratori venivano dalla campagna: a piedi, ogni mattina e ogni sera, quelli che abitavano attorno alla città, a Casalecchio, a San Ruffillo, a San Lazzaro, a Monte Donato, all’Arcoveggio, a Corticella, alla Beverara: una marcia di sei-sette-otto chilometri sotto il sole o la pioggia.
Gli altri, i muratori della bassa di Lavino di Sotto, di Persiceto, di Castelfranco, di Budrio, di Molinella, di Medicina dormivano nelle stalle e nei fienili.
Poche ore di sonno, cibo scarso, pane con cipolla, aringa e un bicchiere di vinello.
Doveva essere ben duro, «purtèr só i cópp» sotto il bruciante sole estivo o nel gelo degli inverni bolognesi.
«Purtèr só i cópp» diventò così il simbolo di una fatica durissima.
C’è in “Bertuldin della Zena” un verso che dice: «Ai cunvgnèva, dla ca’, purtèr só i cópp» (Gli conveniva, della casa, portare su le tegole). Il poemetto di Giuseppe Maria Buini è del Settecento. Già allora «purtèr só i cópp» significava sopportare il peso della famiglia.
Oggi che il lavoro dei manovali è reso meno duro dalle macchine, «A purtèr só i cópp» (A portare su le tegole), metaforici ma non meno pesanti, sono rimasti i padri (o le madri) di famiglia.
♣ ♥
VEGLIÅN
(Veglione)
«Al vegliån d Serrachioli» (Il veglione di Serrachioli)
Era una delle più tumultuose feste carnevalesche della vecchia Bologna.
Si svolgeva, in genere, al Teatro della Nosadella. Non era un veglione per raffinati, che, invece, partecipavano a quelli del Teatro Comunale, e fra il pubblico erano in genere presenti i più noti bevitori di vino della città: «I cassarù» (Coloro che bevono come una cassa, quindi abbondantemente), come venivano chiamati in dialetto.
Le sbornie erano quindi all’ordine del giorno, tanto che, incontrando un ubriaco la gente esclamava: “addio Serrachioli”!
♣ ♥
UCC’ ED TUCHÉN
(Occhi di tacchino)
Aveva nome stellina, così cominciava una novella in un scusa del Ehi! Ch’al scusa del 1884, (Ehi! Mi scusi), era il tipo più completo di popolana che si possa immaginare: grande, forte, sana, bianca e rossa da far voglia a tutti.
«Tott i borghigiån la guardèven con i ucc’ ed tuchén» (Tutti i borghigiani, cioè gli abitanti del vecchio Borgo San Pietro), la guardavano con gli occhi di tacchino.
Chissà com’è lo sguardo del tacchino? Si pensa che «Guardèr con i ucc’ ed tuchén» o semplicemente «Ucc’ ed tuchén», (occhi di tacchino) si riferisca più che allo sguardo del vistoso animale, al suo modo di comportarsi, a quel suo buffo modo di gonfiare penne e bargigli, così come fanno molti uomini alla vista di una bella ragazza.
Di chi spasima per una donna si dice anche, in dialetto bolognese, «Ch’al fa i bî uccén» (cha fa i begli occhietti), o «ch’al fa al caldèni o l’amazè, o ch’al fa al mèl d’ôc a una ragâza» (Oppure che fa venire le scalmane o fa l’ammazzato, o che fa il mal d’occhio ad una ragazza».
Chi ha preso una cotta, poi, è «innamurè com un gât rass, o côt com’è un pass e môrt spånt» che è (innamorato come un gatto rosso, o cotto come un pesce e morto “stecchito”). «Spånt», in verità, è intraducibile, ma per rendere l’idea “morto che più morto di così non si può”.
♣ ♥
BOXER AMERICHÈN
(Boxer americani)
«L é pó turnè tu fiól da l America?»
«Sé, l éra åura!»
«E t èl purtè un regâl?»
«Un pêr ed mudànt lónghi: i boxer americhèn»
«It brîṡa cuntänt?»
«Sé, mó al fât l é che davànti a i é scrétt USA. ed drî NASA!»
(Elisa Barbari – Trovato sul web)
(«È poi tornato tuo figlio dall’America?» / «Sì, era ora!» / «E ti ha portato un regalo?» / «Un paio di mutande lunghe: i boxer amiricani» / «Non sei contento?» /«Sì, ma il fatto è che davanti c’è scritto USA e dietro NASA!»)
♣ ♥
ÂPIS
(Matita)
Mi dà un «Âpis» dice il ragazzino al cartolaio.
Privato ormai da molto tempo della elle iniziale, per i bolognesi il nome francese della matita è diventato soltanto «Âpis».
A Bologna si dice anche il «Lamo», invece che l’amo (per pescare), «Marmizî» invece di «Vermizî» (vermicelli), «Tamarâz» invece di «Materâs» (Materasso).
Fagiolino, rivolgendosi al Dott. Balanzone, lo chiama «Sgnèr dulaur» (Signor dolore).
Scherzosamente, «Fèr l âpis» (Fare la matita), sta per «Fèr l èsen» (Fare l’asino).
♣ ♥
GALVÀN
(Galvani)
Due tifosi di calcio discutono del Bologna.
Uno dice: «L’anno prossimo vinciamo il campionato». Risponde l’altro: «Sé, l é pió fâzil che Galvàn vólta la pagina» (Sì, è più facile che Galvani volti la pagina). Allude al libro che il marmoreo Galvani fa l’atto da sempre, nella piazza omonima, di sfogliare.
Altri un tempo dicevano: «L é pió fâzil che Crést vâga a bachétt» (E’ più facile che Cristo vada a bacchetti).
♣ ♥
FÓRZA
(Forza)
C’è, al bar, una sfida a braccio di ferro.
Da una parte Checco, impiegato del gas, dall’altra Archimede, imbianchino.
Da cinque minuti i due sono inchiodati al tavolino, gli occhi negli occhi, congestionati.
È difficile dire chi vincerà.
E Tullio, che fa il facchino al mercato ortofrutticolo, dice: «Figurati! I an na fórza che con un pógn i scuezzén na fatta ed pulänt!» (Hanno una forza che con un pugno schiacciano una fetta di polenta).
♣ ♥
UN SAN LUIGÉN SPIGAZÈ
«Un san Luigén spigazè»: un San Luigino sgualcito.
Non c’è irriverenza. In fondo è una manifestazione di religiosità anche questo ricorrere alle grandi figure, ai grandi motivi della cristianità, per rendere più incisiva ed efficace un’immagine.
Si dice: bello come un angelo, paziente come un santo, dolce come una Madonna.
Di un brutto ceffo a Bologna si afferma «Ch al pèr quall ch dé la lanzè a noster sgnaur».
Talvolta però l’immagine può apparire un po’ audace: è il caso di questo «San Luigén spigazè», che in italiano (San Luigino sgualcito) perde gran parte della sua efficacia.
Sembra un «San Luigén spigazè», il giovanottino sui sedici, diciassette anni macilento e sciupato. Proprio come appare macilenta l’immagine di San Luigi Gonzaga nella ingenua iconografia dei santini, per di più se sono sgualciti.
Di una giovane ragazza che abbia l’aria un po’ dimessa si dice: «Ch la pèr un suspîr in Santa Brégida», che sembra un sospiro di Santa Brigida.
♣ ♥
CÓNNA
(Culla)
Siamo al bar, una signora ancora piacente ma stagionata dice a un’amica: «Ho trentasei anni».
Un cameriere la sente e, a voce bassa, mormora: «Sé, piò qui dla cónna».
♣ ♥
FÔLA
(Favola)
Ai éra una vólta un cuntadén ch al ciamé al veterinêri par fêri vàdder al sô cavâl ch’an magnèva pió. «Adês ai avî da dèri sta medgén-na par trî dé, mó s an tâca a magnèr, bisåggna ch’al mazèdi». Al ninén, ch l’avèva sintó incósa, al curé dal cavâl: «Disó, zàirca bàn ed magnèr, sinchenà al cuntadén at mâza!».
Mó al cavâl l’andèva ed lóngh an magnèr brîsa e al veterinêri al gé: «A pruvàn êter tri dé e pò bâsta».
Al ninén al curé un êtra vólta int la stâla: «Dài, màgna dånca, se nà l’é pîz par té!».
Al térz dé, al cavâl l’ éra sàmper pió mègher e al cuntadén al ciamé al veterinêri par fèri la puntûra. Apànna ch al veterinêri l’ arivé, al cavâl al taché a magnèr e bàvver ch mé un lûder e al taché a córrer e a saltèr ch mé un mât. Al cuntadén l’ éra acsé felîz che par festegèr l’avenimånt al mazé al ninén e al fé un gràn ds’nêr!
Morêl: zàirca sàmper ed fèret i câz tû!
C’era una volta un contadino che chiamò il veterinario per fargli vedere il suo cavallo che non mangiava più. «Adesso gli dovete dare questa medicina per tre giorni, ma se non comincia a mangiare, bisogna che lo ammazziate». Il maiale che aveva sentito tutto, corse dal cavallo: «Dimmi, cerca bene di mangiare, altrimenti il contadino ti ammazza!». Ma il cavallo continuava a non mangiare e il veterinario disse: «Proviamo altre tre giorni, poi basta». Il maiale corse un’altra volta nella stalla: «Dai, mangia dunque, se no è peggio per te!». Al terzo giorno, il cavallo era sempre più magro e il contadino chiamò il veterinario per fargli la puntura. Appena il veterinario arrivò, il cavallo cominciò a mangiare e bere come un ingordo e cominciò a correre e a saltare come un matto. Il contadino era così felice che per festeggiare l’avvenimento uccise il maiale e fece un gran bel pasto!
Morale: cerca sempre di fare i cazzi tuoi.
♣ ♥
PIRÉN E LA PULÉTTICA
Pirén al tàurna a cà da scóla e al d mànda a só pèder: “Bàbbo, ai ó bisàggn che té t um spiégh la puléttica, parché d màn ai ó da fèr un téma”.
Al pèder ai pànsa un póch e pò ai dîs: “Fórsi al quèl miàur l’é quàll ed fèr un paragån con la nóstra famàia: mé a rapresànt i capitalésta, parché a lavàur e a pórt a cà i baiûch; tó mèder l’é al guéren, parché la dezîd incósa in cà; la Cesìra, la dôna ed sarvézzi, la rapresànta i operèri, parché la lavàura con un stipàndi; té t i al popolo e tó fradlén l’é la generaziàn futura, èt capé?”
“A cràdd ed sé, grazie”.
Pirén, la sîra a lêt, l’é ànch drî ch al pànsa a tótt quàll ch a i à détt só pèder e in ch al mànter als acórz che al fradlén l as l’é fâta adós, acsé al córr a ciamèr só mèder.
Ciâma e che te ciâma, mó la mèder la cunténua a runfêr e al vàdd che só pèder al n é brîsa int al só lèt, mó l é in quàll d la Cesìra!
A la matén-na, a claziån, al pèder a gli d’mânda:
“Alàura Pirén, cus èt capé d la puléttica?”
“P r adès ai ó capé che i capitalésta il câz n in ch al sît a i operèri, che al guéren al dórum, als n infréga dal pòpolo e al lâsa el futúri generaziån int la mérda!”
Pierino torna a casa da scuola e domanda a suo padre: «Papà, ho bisogno che tu mi spieghi la politica perché domani debbo fare un tema».
Il padre ci pensa un po’ e poi dice: «Forse la cosa migliore, perché tu possa capire, è che ti faccia un esempio con la nostra famiglia. Io rappresento i capilista, perché lavoro e porto a casa i soldi. Tua madre è il governo, perché decide tutto in casa. La Cesira, donna di servizio, rappresenta gli operai, perché lavora con uno stipendio. Tu sei il popolo e tuo fratellino è la generazione futura. Hai capito?»
«Credo di sì, grazie» risponde il figlio.
Pierino la sera a letto, continua a pensare a tutto quello che gli ha detto il padre e intanto si accorge che il fratellino se l’è fatta addosso e corre a chiamare sua madre.
Chiama, chiama, ma la madre continua a dormire e vede che suo padre non è nel suo letto, cambia camera, va in quella della Cesira e ci trova anche il padre.
La mattina, a colazione, il padre domanda al figlio: «Allora, Pierino, cos’hai capito della politica?»
«Per ora ho capito che i capilista lo mettono in quel posto agli operai, che il governo dorme, se ne frega del popolo e lascia le future generazioni nella merda».
♣ ♥
CREDITAUR
Creditore, colui che deve avere dei soldi che ha prestato.
«Puntuèl cóm un creditaur» (Puntuale come un creditore)
La puntualità non è mai sempre un pregio. Nel caso dei creditori, che, per sfortuna dei debitori, arrivano sempre agli appuntamenti con l’implacabile precisione dei cronometri di gran marca, è un gravissimo e criticabilissimo difetto.
A Bologna si dice appunto: “puntuale come un creditore”, per indicare chi non sgarra mai nemmeno di un minuto secondo.
♣ ♥
PÉSSA PISSÈLA
Filastrocca – o conta- di un gioco di bambini. Intraducibile.
«Péssa pissèla» è un gioco di bambini, chiamato, in Toscana: “Piso pisello”, nelle Marche: “Piede piedella”, a Roma: “Piseppisella”, in Abruzzo: fare a “Pitto pittella”.
A noi dice poco, ma stando alle nostalgie e ai ricordi che suscita negli anziani, dovette essere, ad onta delle apparenze, un gioco particolarmente affascinante.
Un nostro amico, particolarmente anziano, ha versato perfino qualche lacrimuccia parlandocene. Sospirava e riusciva soltanto a dire: Eh, la «Péssa pissèla».
La si giocava così: più bambini si mettevano a sedere in fila con le gambe stese e i piedi pari, mentre uno di loro, il capo del gioco, restava in piedi con una becchetta in mano, e recitava la seguente filastrocca, toccando successivamente, a ogni accento del verso, un piede dei suoi compagni, e nell’ultimo verso un piede ogni sillaba:
«Péssa Pissèla
Colóra sì bèla,
colóra sì fina
per Santa Martina,
la bèla pulinèla
va só par la schèla
schèla. scalón,
la panna dal pavón,
la scâtla dal mêr,
la bella città,
re, re, figlio d’un re,
metti dentro questo pè,
che ti tocca a te».
Il bambino toccato nel piede all’ultima sillaba, doveva ritirarlo, e così a mano a mano finché restava ultimo uno con un piede solo, Il bambino si alzava applaudito o fischiato, per dare il suo posto al maestro e ricominciava la filastrocca.
Il nome “Pulinèla”, motivo della filastrocca, si vuole riferire a Polissena, figlia del capitano Erasmo da Gattamelata di Bagnacavallo, giovane e sì “leggiadra e pudica” che del suo nome riempì a suo tempo tutta la Romagna, tanto che si coniarono perfino delle medaglie in suo onore.
♠ ♥
SPINZÉN
(Asticciola di legno)
I numeri del lotto reale erano scritti su un foglietto di pergamena che veniva introdotto in un foro longitudinale che attraversava una ghianda di legno.
Al momento dell’estrazione, i foglietti venivano fatti uscire dalla ghianda, mediante un’asticciola di legno che si chiamava «spinzén»
«Spinzén dal lôtt rèèl», serviva anche per indicare scherzosamente un “uomo quasi nano e tristanzuolo”.
Ma «spinzèn» sembra che, ai nostri giorni, abbia completamente mutato il significato. (Il lotto reale si è da tempo perduto per strada).
Domandando ad un uomo, bolognese, neppure tanto giovane, se ci faceva un esempio di «spinzén», ha messo le mani al petto, con un gesto malizioso, ed ha nominato un’attrice dal petto generoso ed ha aggiunto: «Qual l é l é prôpi un bèl spinzén».
♣ ♥
RUGNÓN
(Reni – Rognoni)
«Attachèrs a chi ha i rugnón grûs» (Attaccarsi a chi ha i rognoni grossi)
Non sarà morale, ma è pratico attaccarsi a quelli dai rognoni grossi cioè a chi è potente, a chi regge le leve del comando.
Oggi il detto è caduto in disuso.
Con linguaggio più sfumato, più elegante e ipocrita si raccomanda a chi vuol fa fortuna una particolare cura per le pubblic relations.
♣ ♥
ARSÓI
(Rimasugli, scarti)
Una signora di nome Bianca, era nata con un difetto non tanto visibile, ma la gente diceva che «l’éra un póc in drî» (un po’ indietro, una che non capiva bene le cose). Succede ogni tanto.
La chiamavano “Bianchina” ed era destinata ai lavori di casa. Una delle sue mansioni era quella di andare dal macellaio per comprare carne.
«L’azdaura» (la curatrice della casa), la rimproverava sempre al ritorno e diceva: «cum èla. Bianchina, it comper sèmper di arsói» (come mai Bianchina, che compri sempre degli scarti).
«Ói – rispondeva la Bianchina – anch sa ni dmand brîsa al mi dà listàss» (Eh, sì, rispondeva Bianchina, anche se non glieli domando, me li dà lo stesso).
♣ ♥
| A CLÎ ¹ Quand l’è tänp ed caranvèl fèr di sèlt sanza grinbèl pò cuntént andèrsen vî in silänzi e in pónta ed pî a zarchèr una caśleńna dóvv tafièr un’anadréńna e vulèr såtta un linzôl par magnèr sfrâpl e raviôl! Pò, in sta mûśica fiuré, lûv biasèr un dåulz candé dåu fritèl cån sî grasû e ala lómm di mirasû chèld gustèr ranûc’ cån Clî ch’la s fa vgnîr la freneśî, ch’l’é l’insónni d nôstra vétta, che però l’é tante drétta ch’an s’ariès mai ed ciapèrla, pzigutèrla e intànt baśèrla! L’é un źarmói, l’é un sprucajén, l’ha del cûruv da viulén l’é una źòja l’é un zriśén, cån Clî psairi ciacarèr cån Clî psairi anc źughèr, la Sô véggna… psair vindmèr! ¹ “Clî” la nascånd al nómm dla dòna deśiderè, ch’al n’é mai sparpadlè, sia par rispèt che par sèna gelośî! |
A SENHAL¹ Quando è tempo di carnevale far dei salti senza grembiale poi contenti andarsene via in silenzio e in punta di piedi a cercare una casina dove ingollare un’anatrina e volare sotto un lenzuolo per mangiare sfrappole e raviole! Poi, in questa musica fiorita, ghiotti masticare un dolce candito due frittelle con sei ciccioli e alla luce dei girasoli caldi gustare ranocchi con Senhal che ci fa venire la frenesia, che è il sogno della nostra vita, che però è tanto scaltra che non ci riesce mai di acchiapparla pizzicottarla e intanto baciarla! È un germoglio, è snella carina, ha delle curve da violino è una gioia è un ciliegino, con Senhal poter chiacchierare con Senhal poter anche giocare, la Sua vigna… poter vendemmiare! ¹ “Senhal”, (nome fittizio che nella poesia dei trovadori provenzali) adombrava il nome della donna amata, che non era mai divulgato sia per rispetto che per sana gelosia.http://www.poetare.it/sermenghi.html |
(Grazie a Roberta)
Amîg ed Nadèl
LûṠåur, preṠèpi, âlber e pan spzièl,
antîghi uṠànz, dågg’ mîṠ cómm intervâl,
i um dîṠen d stèr ins qualla: l é Nadèl.
E pò ai é la manfréṅna di regâl
che la m fà dîr «ragâz, brîṠa par mé!»
parché a in ò bèle un frâc, un stracantån,
e i én preziûṠ, e a i päns tótt quant i dé.
I én i mî amîg, ch’i um vôln e ch’a i vói bän.
A v aringrâzi, amîg. Con mî mujêr
e con mî fiôl, vó a sî la mî ricazza,
a sî al regâl pió bèl, a sån sinzêr,
e fèr tanta strè insàmm l’é stè una blazza.
Lóng a sta strè ch’a fän in cunpagnî,
fèm un piaṠair, an stèdi sänpr in tèsta
parché, a v cunfès, avair da tgnîruv drî
la srê såul na Ṡganghè, brîṠa una fèsta.
Int l istàss tänp, anc s’a pedghéss par dnanz,
a n sarêv brîṠa da che banda andèr.
S’a sî di amîg al tògo e brîṠa ranz
mitîv bän spâla a spâla, a mé al inpèr.
E acsé andän d lóng insàmm, mé e el mî risåurs
che pò a sî tótt vuètr, a l garantéss.
Sänza biṠåggn d cuntrât, sänza inción dscåurs,
luntàn da facuajôni e incantabéss.
Par la mî vétta e pr al sô lóng sintîr
ai é pasè, sicûr, dimónndi żänt.
Mo såul i amîg i én stè bón ed sculpîr
l’inprånta stâbil, saggn d un żuramänt.
Dånca, a chi vléss na pèrt di mî regâl
a i dégg ch’i n i vdran gnanc col canucèl
parché i amîg i én mî, fôra dal bâl!
Ciamèm pûr egoéssta. E bån Nadèl.
Gigén Lîvra – 2014
(Grazie a Luigi Lepri che ci ha inviato questa poesia, con gli auguri di Buon Natale)
ALCUNI PROVERBI E MODI DI DIRE DEL CONTADINO BOLOGNESE
(Di Gino Calari)
Abadèr a ón cómm fa al Pèpa có’i zarlatàn = Porgere attenzione a uno come fa il Papa coi ciarlatani. Non prestare attenzione.
Abundanza ed fónz, carestî ed rôba = Abbondanza di funghi, carestia di roba. I funghi abbondano negli anni piovosi.
A Cà di Frâb i piànten i fasû col revolver e ai nâs di lèder = A Ca’ de’ Fabbri, piantano i fagioli con la pistola e ne nascono dei ladri. Ca’ de’ Fabbri è una frazione del Comune di MInerbio, posta sulla Strada Statale Porrettana. Il proverbio nasce dalle solite rivalità di paese.
A cavâl ch’sûda, a ômen ch’zûra e a dôna cla zîga, a ni cradder = non credere a cavallo che suda, a uomo che giura e a donna che piange.
A cavâl dunè, an’s’guèrda in bacca = A cavallo donato non si guarda in bocca. L’età dei cavalli la si riconosce dai denti. Quindi l’acquirente, prima di concludere l’affare, apriva la bocca al cavallo e ne guardava i denti.
A chi dà e pó tôl , ai vén la béssa al côl. A chi dà e pó lâsa, la Madôna l’abrâza = A chi dona e poi riprende viene la serpe (rimorso) al collo. A chi dona e lascia, la Madonna lo abbraccia.
A chi è sfighè, tótti al masàggn i càschén int’la tésta = A chi è sfortunato, tutti i macigni cadono sulla testa.
A chi piès la taurta e a chi i turtî = Ad alcuni piace la torta ad altri i tortelli. I gusti sono diversi.
A chi sammna i fasû, a i nas al côren = A chi semina fagioli nascono le corna. Strano proverbio. Forse perché i baccelli dei fagioli si chiamavano “curnâcia” (cornacchia).
A chi va a la bâsa, tótt i sant i dân un cócc’ = A chi scende, tutti i santi danno una spinta (Tutti aiutano chi ha fortuna).
A ciapèr na dôna in paróla, l’è cmód ciapèr un buratèl par la cô = Prendere una donna in parola, è come prendere un’anguilla per la coda.
A cócc’ e spintón = A irti e spinte. Progredire faticosamente per aiuto altrui.
A cûl busón = La posizione di chi sta chinato per raccogliere qualcosa a terra.
Acumdèr agl’ôv in t’al panîr = Sistemare le uova nel paniere (Sistemare i propri interessi).
A dvintèr vîc’ a se scûrta la vésta, a s’inféja al gamb e a se slèrga al brègh = Invecchiando (diventare vecchi) si accorcia la vista, si gonfiano le gambe e i calzoni diventano larghi.
A dvintèr vîc’, as dvàinta ragazû = A diventare vecchi, si ritorna bambini.
A fèr a sô môd as’campa un dé d’pió, cl’è quall dal rôch = A fare a proprio modo si vive un giorno di più che è quello del colpo secco.
A fèr i fât sû, an’s’ispôrca al man = Ad occuparsi dei fatti propri non ci si sporca le mani.
A fèr la limôsna, an’s’dvàinta puvrétt = Chi fa la carità non diventa povero. (Esiste anche la versione opposta: Chi fa la carità diventa povero).
Afiubèrs al schèrp = Abbottonarsi i (lacci) delle scarpe, ossia prendere delle precauzioni.
A fórza ed’tirerla trôp, la se strâza = A forza di tirarla si straccia.
Agàst, prepèra la cuséina: setamber la cantéina = In agosto prepara la cucina; in settembre la cantina.
Agl’én côs ch’a s’in farévv di quèder = Sono cose tanto ridicole (o singolari) che meriterebbero di essere dipinte.
Agl’ôv, i én bóni anch dapp Pasqua = Le uova sono buone anche se è passata la Pasqua.
A gn’è amaur sàinza gelosî = Non vi è amore senza gelosia.
A’gn’è badilâz ch’al n’èva al só mandgâz = Lett.: Non c’è badilaccio che non abbia il suo manicaccio. Vale a dire: non vi è donna brutta che non trovi il suo uomo.
A’ gn’è bèl cavâl ch’an dvàinta una brótta rôza = non c’è bel cavallo che non diventi un brutto ronzino.
A gn’è cà d’rà, d’prénzip o d’imperataur ch’a gn’èva pisè dàinter un muradaur = Non c’è casa di re, di principe o d’imperatore, che non v’abbia fatto pipì un muratore (Orgoglio corporativo).
A gn’è cà sàinza póndgh = Non vi è casa senta topi.
A gn’è pan = Non c’è pane; manca il lavoro. Il pane era sempre associato al lavoro.
A gn’è pan sàinza pána = Non c’è pane senza pena.
A gn’è na bèla rósa, ch’an dvàinta una patarlàinga = La “patarlàinga” è il frutto della rosa selvatica (Rosa canina o Rosa gallica. In italiano “cinorroidi”). Tale frutto, pur essendo edule all’esterno, contiene all’interno corti peli rigidi che, se ingeriti possono dare disturbi. Il significato del proverbio e: non c’è cosa bella che col tempo diventi brutta.
A gn’è schèrpa ch’an dvàinta una zavâta = Non c’è scarpa che non diventi una ciabatta.
Agl’óch ed Rizól al s’tólèn dal masnadûr pr’andèr a cà’ a bavvèr = Le oche di Rizzoli partono dal macero (che è pieno d’acqua) per andare a bere a casa.
A gróggn dûr = A muso duro.
Al busèder ai vól bôna memoria = Al bugiardo occorre una buona memoria.
A i è chi l’intand, chi n’l’intand e chi n’la vôl intander = C’è chi la capisce, chi non la capisce e chi non la vuol capire.
Ai è saimper al pîz dré da l’óss = il peggio è sempre dietro l’uscio.
A i è trai categorî d’bécch: tranvièr, ferovièr e tótt qui chi han mujèr = Ci sono tre categorie di cornuti: tranvieri, ferrovieri e tutti quelli che hanno moglie.
A i é vlô i sèvi e i mât = Ci sono voluti i saggi ed i matti. Una cosa difficile che ha richiesto doti di saggezza e di pazzia.
A i é finé i marón a Lâzér ch’al n’avèva trantasî tinâz e na tinèla = Sono finiti i marroni di Lazzaro, che ne aveva trentasei tini e una tinella. Anche i più ricchi possono diventare poveri.
A i hó un dafèr grand = Ho molto da lavorare.
Ai manca parféin al chèld par cusèr un ôv = Gli manca perfino il caldo per cuocere un uovo. E’ poverissimo.
A impièr la candàila al fûgh a’s’dvàinta puvrétt = Ad accendere la candela al fuoco si diventa poveri. Forse perché il calore del fuoco consumava la cera della candela.
A i n’è anch pr’î fiû di prît = C’è n’è anche per i figli dei preti. Vi è grande abbondanza.
Ai n’è vló dla bóna = E’ stata una cosa lunga e difficile.
Ai nôz e ai murtôri a’s’arcgnóss i parént = Alle nozze (matrimoni) e ai funerali si riconoscono i parenti (perché altrimenti sono rare le occasioni d’incontro).
A in sa pió al Pèpa e un contadéin, che al Pèpa da par sé = Ne sanno di più il Papa e un contadino assieme, che il Papa da solo. Anche i consigli degli umili possono essere utili.
Ai prèm pió la camîsa cn’è al giubän = Gli preme di più la camicia che il giubbone. Tiene più conto delle cose da poco che di quelle importanti.
Ai pûrz, an s’pôl mudèr buclèr = Ai porci non si può cambiare truogolo, Ciascuno continua nelle sue abitudini.
Ai sûda la langua in baca = Gli suda la lingua in bocca.
A i suzèz qualla d’Bainvgnó, cl’andé par dèri a i èter e a i busché ló = Gli è capitato come a Benvenuto, che andò per darle agli altri e le buscò lui.
Ai táca saimper ai dschélz, girèr in váta ai spén = Tocca sempre agli scalzi, girare (camminare) sopra gli spini.
Aiuta préma i tû, e pó i ètér s’t’pû = Aiuta prima i tuoi, e poi gli altri se puoi.
A i va i grustén a chi n’ha i dént da rusghèr = I crostini vanno a chi non ha i denti per rosicchiare.
Al calzulèr co ‘i bûs int’al schèrp = Il calzolaio con i buchi nelle scarpe.
Al côrén i én cumpagn a i dént , chi dân fastidî quand i’nasén, ma dapp i aiuten a magnèr = Le corna sono come i denti, danno fastidio quando nascono, ma poi aiutano a mangiare. Consolazione del marito tradito quando “l’amico” era danaroso.
A la fèn di cónt, s’im tolèn la massa a m’avanza la prèdica = Alla fine dei conti, se mi tolgono la messa, mi rimane la predica. Consolazione del prete sospeso “ a divinis” e di chi ha perduto qualche beneficio.
A la galéina ingaurda, ai crèpa al gôs = Alla gallina ingorda, scoppia il gozzo.
A lavurèr in cà só an’s’inspôrca maj = A lavorare in casa propria, non ci si sporca mai.
A ognón al sô ‘mstir e i cuntadén a médér = A ciascuno il suo mestiere e i contadini a mietere.
Al bàin fât par fórza, an’vèl ‘na scórza = Il bene fatto per forza non vale una scorza (non vale nulla).
Al bâl l’è bèl a cà di ètér = Il ballo (la festa da ballo) è bello a casa degli altri.
Al ban fûgh, fa al ban cûgh = Il buon fuoco, fa il buon cuoco.
Al ban marchè vûda la bisâca = il buon mercato vuota la tasca. I prezzi bassi vuotano le tasche.
Al bîsti agl’en caraggn dapp môrti: i ômén i én caraggn anch da vîv = Le bestie sono carogne dopo la morte, gli uomini sono carogne anche da vivi.
Al blazz pr’un ân, la buntè par sàimper = la bellezza per un anno, la bontà per sempre.
Al bôt an’pièsén gnanch ai cân = Le botte non piacciono nemmeno ai cani.
Al bûs dal dal pancôt = Il buco del pancotto: l’esofago.
Al bûs dla Jâcma = Il buco della Giacoma. Quello squarcio tra le nubi, verso Ponente che, secondo la tradizione popolare, è presagio di miglioramento (o peggioramento) del tempo.
Al busî al vân a brazàtt, ma al n’han brisa al gamb lónghi = Le bugie vanno sottobraccio, ma non hanno le gambe lunghe.
Al can al rausga l’ôs, parché al n’é brisa ban d’mandèrel za = Il cane rosica l’osso, perché non è capace di inghiottirlo.
Al can stà scutè da l’âqua chèlda, l’ha pôra anch d’la fradda = il cane che è stato scottato dall’acqua calda. Ha paura anche di quella fredda.
Al casca un cavâl, ch’al g’ha quater gamb = Cade un cavallo (benché) abbia quattro gambe (zampe). Gli arti del cavallo vengono comunemente detti “gambe” (forse per la nobiltà dell’animale) e non “zampe” come per gli altri quadrupedi.
Al catîvi nutézzi ién sàimpér vàiri. = Le cattive notizie sono sempre vere.
Al caval dal bruzâi al s’fàirma in tótti agl’ustarî = il cavallo del birocciaio si ferma davanti a tutte le osterie.
Al ciàcher a gl’éin cumpagna al zrîs, a ciapèren só ónna a in vén só dîs = Le chiacchiere sono come le ciliegie, a tirarne su una ne vengono dieci.
Al cûl ch’an ha mai cnussó la camisa la prémma vôlta ch’al la vadd, al s’maravàjja = il culo che non ha mai conosciuto (avuto) una camicia, la prima volta che la vede prende paura.
Al cumprèr insaggna a vandér = L’acquistare insegna a vendere.
Al cuntadén an fèdi sènter mai cóm’l’è bóna la pàira col furmâi = Al contadino non fate mai ssentire (assaggiare) quanto è buono il formaggio con le pere.
Al daulz n’è mai stè acsé chèr, se n’quand s’è pruvè prémma l’amèr = Il dolce non è mai stato tanto caro, se non quando si è provato prima l’amaro.
Al dé dla fèsta, anch i amalè i drézen la tèsta = Il giorno della festa, anche gli ammalati drizzano la testa.
Al dé dla Madôna di garzón = Il giorno dell’Annunciazione (25 marzo) si svolgeva sul sagrato delle Parrocchie il mercato dei garzoni. Erano, questi, ragazzi o uomini privi di mezzi e di famiglia, che si offrivano per lavorare presso i contadini. Il contratto aveva la durata di un anno. “L’azdaur” (capo famiglia contadina) dava vitto (a tavola con la famiglia) e alloggio (di solito nel sottoscala o nello stanziolo della stalla), un abito (di lana filata e tessuta in casa), un paio di scarpe, una camicia ed una regalìa (ad libitum) che, negli anni trenta, era di 5 lire per Pasqua e 5 lire per Natale. A volte i garzoni passavano presso la stessa famiglia molti anni. La sola speranza di riscatto sociale era, per loro, quella di mettere in cinta una delle ragazze della casa. Nessuna tragedia, venivano le nozze riparatrici e lo sposo entrava in famiglia. Di lui si diceva: “L’è andè int’al purzîl” (E’ entrato nel porcile).
Al dé d’San Martéin l’è la fèsta di bécch = Il giorno di San Martino (11 novembre) è la festa dei cornuti. Non si capisce perché, infatti, San Martino, prima soldato e poi Vescovo, non prese mai moglie. A Cento, nel giorno di San Martino, veniva nominato il cornuto dell’anno.
Al dé d’San Siman, chèva i bû d’in t‘al timan e métt la vanga in t’al bastan = Il giorno di San Simone (28 ottobre) togli i buoi da sotto il timone e metti la vanga nel bastone. Cioè togli il giogo ai buoi e metti il manico alla vanga. Non è più tempo per usare il bestiame per il lavoro nei campi, a causa del terreno bagnato per la pioggia, e allora si deve usare la vanga.
Al dé d’San Siman, o la pêrdga o al bastan = Il giorno di San Simone (28 ottobre) o la pertica o il bastone. Alla metà di ottobre cadono le castagne. Quelle che ancora non sono cadute, verso la fine del mese, debbono essere abbacchiate.
Al Dièvél an’dsfé mai craus = Il Diavolo non ha mai disfatto croci. Il diavolo nulla può contro il cielo.
Al Dièvèl insaggna a fèr al pignât, mó brisa i quérc’ = Il Diavolo insegna a fare le pentole ma non i coperchi.
Al dmandèr l’è la metè dal savair = Il domandare è la metà del sapere.
Al dôn al vólen quâtar cós: un ban maré, avair di bî fiû, vstîr pulîd e purtèr al brègh in ca’ = Le donne vogliono quattro cose: trovare un buon marito, avere dei bei figli, vestire bene e portare i pantaloni (comandare) in casa.
Al dôn al zîghen o par dulaur o pr’ingân = Le donne piangono o per dolore o per inganno.
Al dôn da bàin al’n’arén d’avàir né ûc’, né uràcc’, né langua = Le donne perbene non dovrebbero avere né occhi, né orecchie, né lingua.
Al dôn én cumpâgn î armèri: parché al stàgan fàirmi, bisaggna mantgnîri ciavè. = Le donne sono come gli armadi: perché stiano ferme (per evitare sorprese) bisogna tenerle sotto chiave.
Al dôn han sàimper al lègrum in bisâca = Le donne hanno sempre le lacrime in tasca.
Al dôn in sân un pónt pió dal dièvel = Le donne ne sanno un punto più del diavolo.
Al dûr e al madûr = Il duro e il maturo. L’acerbo e il maturo. Di chi è costretto ad adattarsi.
Al durmirévv int’na pètna da garzôl = Dormirebbe (sarebbe capace di dormire) su un pettine da garzuolo. Il garzuolo è una sottilissima fibra di canapa o di lino, il pettine per distendere le fibre aveva denti sottili ed acuminati. Dormirci sopra era certamente difficile.
Al dutaur Sgambralèt = Il medico Sgomberaletti. Di un medico poco raccomandabile.
Al fa di ragiunamènt ch’in arîvén gnanch a l’âsa dal pan = Fa dei ragionamenti che non arrivano neppure all’asse del pane. Fa dei ragionamenti stupidi. L’asse del pane era posta a una parete della cucina ad altezza d’uomo.
Al fiaur ch’an piès, al nâsc int’l’órt ed ca’ = Il fiore che non piace, nasce nell’orto di casa.
Al fómm dal sô paiéis al lûs pió ch’né al fûgh di ètér sît = Il fumo del proprio paese fa più luce che il fuoco degli altri posti. Casa mia. Casa mia.
Al fradd l’é al pèdér ed tótt i Sant = Il freddo è il padre di tutti i Santi (1° di novembre).
Al fûgh d’invérén l’é comm al pan = Il fuoco d’inverno è come il pane (indispensabile).
Al gâl al canta d’invàtta a l’aldamèra = Il gallo canta sul letamaio.
A l’infèrén a si va col slitén = All’inferno ci si va con lo slittino (cioè facilmente e senza fatica).
Al lauv mâgna anch al pîguer cuntè = Il lupo mangia anche le pecore contate.
Al lèt chèld, fa la mnèstra fradda = Il letto caldo fa la minestra fredda: chi poltrisce nel letto anziché lavorare, va in miseria.
Al magnarèvv al Dièvél e as’al’brévv in brôd = Mangerebbe il Diavolo e ne berrebbe il brodo. Di uomo famelico.
Al magnarévv i purtón d’l’infèrén = Mangerebbe le porte dell’inferno. Di grande mangiatore.
Al màis d’agast e quall d’setamber i fân andèr l’ômen ed sgalémber = Il mese di agosto e di settembre, fanno andare l’uomo di sghembo. Sono due mesi di duro lavoro in campagna: canapa, aratura, vendemmia, ecc.
Al man a ca’ só e la langua tra i dént = Le mani a casa loro (in tasca) e la lingua tra i denti.
Al mand al va a l’arvérsa = Il mondo va a rovescio.
Al mand l’è bèl parché l’è vèri = Il mondo è bello perché è vario.
Al mand l’è di dritón, brisa di quajón = Il mondo è dei dritti (furbi), non dei coglioni (fessi).
Al mand l’è una rôda, chi va só e ch va zà = Il mondo è come una ruota, chi sale e chi scende.
Al massch al córren drî al can mèghér e al caraggn = Le mosche corrono dietro ai cani magri e alle carogne.
Al mand l’è d’chi sa góder = Il mondo è di chi sa godere.
Al mastér Tampécc’ che da ‘na zôca ai chèva un cavécc = Mastro Tampiccio, che da un ciocco, ricava un cavicchio. Di artigiano di scarse qualità.
Al méi métt al cûl in sgumbéi = il miglio mette il sedere nello scompiglio. Il miglio provoca meteorismo. Il miglio era usato un tempo per l’alimentazione umana, ora è quasi sempre usato solo come cibo per gli uccelli.
Al mèl dal pîguer l’è al bàin di can = Il male delle pecore è il bene del cane (nel senso che ne mangiano le carogne)
Al mèl al vén in carôza e al va vî a pî = Il mane viene in carrozza e va via a piedi.
Al miaur cumpanâdgh, l’è la fâm = Il miglior companatico è la fame. Con molta fame è buono anche il pane da solo.
Al mî ômen = Mio marito. Così usavano dire le contadine del proprio marito. Gli uomini, da parte loro, chiamavano la moglie: Cla dôna = Quella donna.
Al mî schécc: La mî schéccia = Termini affettuosi usati dai fidanzati per chiamarsi a vicenda. Non esiste in italiano la parola “schiccio”, ma in dialetto significa, per esempio, riferita al naso, “piccolo naso”, un epiteto grazioso.
Al mujêr al s’tóln a vétta, brisa a próva = Le mogli si prendono a vita, non a prova. Questo prima dell’introduzione del divorzio.
Al muntàn, fa purtèr la zócca satta al gabàn = Il montano (vento di Ostro), fa portare il fiasco sotto il gabbano. L’Ostro, come lo scirocco, detto dai contadini “Bagnamuràia” (bagna muri), portava spesso la pioggia.
Al muradaur l’è prémma manvèl e pó master = Il muratore è prima manovale e poi mastro (per imparare il mestiere si deve cominciare dalla gavetta).
Al muscàn dagli èli d’ôr, ch’al vulé pr’al zîl, al finé int’la mérda = Il moscone dalle ali d’oro, che aveva volato per il cielo, finì nella merda.
Al n’è bèl quall ch’è bèl, ma l’è bèl quall ch’al piès = Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
Al n’è brisa bän ed fêr un’o cól bichîr = Non è capace di fare una “o” col bicchiere (di persona incapace).
Al n’è gnanch al tarzanèl = Non è nemmeno il terzanello (vinello ricavato dalle residui della vinificazione con l’aggiunta di acqua). Vale per: Non vale nemmeno un’unghia, una minima parte di altra persona.
Al n’è mégga listass che spudér in tèra = Non è come sputare in terra: non è una cosa facile.
Al n’èin tótt dôn, quali ch’an la stanèla = Non sono tutte donne quelle che hanno la sottana.
Al n’ha gnanch vést l’aria = Non è ancora visto l’aria, ossia non è ancora venuto alla luce; non è ancora nato.
Al ninén al scôsa la có tótt al dé, mó al n’i fa mai al grapp = Il maiale scossa la coda tutto il giorno, ma non l’annoda mai. Di chi si agita di continuo ma non conclude nulla.
A lói la nûs la fa al garói = A luglio la noce fa il gheriglio.
A l’ômén, quand manch a i pàinsa, a i pióv dal zîl la ricumpàinsa = All’uomo, quando ci pensa meno, dal cielo arriva la ricompensa. La ricompensa del cielo arriva all’uomo quando meno se l’aspetta.
A l’ómm ed candàila, anch la burazzénna la pèr tàila = A luce di candela, che la burazzina sembra tela. La burazzina era una tela rada e di qualità scadente usata come strofinaccio per piatti o simili.
A l’ómm ed candàila, an tôr brisa mujèr e an’cumprèr tàila = A luce di candela non prendere moglie e non comprare tela.
A lónna setembréina, sét lónn s’inchéina = Alla luna settembrina, sette lune si inchinano. La luna di settembre domina sette lune.
Al pan di ètér l’ha sèt grast e un grustén = Il pane degli altri ha sette croste e un crosino. E’ duro da mangiare.
Al pan l’ha savaur, soul sl’è guadagné cól sudaur = Il pane ha sapore solo se è guadagnato col sudore.
Al pâs pió lóngh l’è quall dla pôrta. Anche: Al pâs pió lóngh l’è quall dl’óss = Il passo più lungo è quello della porta (o dell’uscio): per i giovani che si accingessero a lasciare la famiglia.
Al pass grôss al magna al cén = Il pesce grosso mangia il piccolo.
Al pèr un burdigän (o un calabrän) int’na zóca = Sembra uno scarafaggio (o un calabrone) in un fiasco. Di persona che parla con voce bassa e continua, facendo un rumore simile a quello di un insetto chiuso in un fiasco.
Al pèr un mulén = Sembra un mulino. Di persona che chiacchiera in continuazione.
Al pèr un pizàn imbalzè = Sembra un piccione con la balza ai piedi. Di persona impacciata.
Al pió ban di róss al mazé só pèdér = Il più buono dei rossi uccise suo padre. Ai rossi di pelo veniva attribuito animo cattivo. La pió bóna dal rassi, la fiché só mèdér int’al pazz = La più buona delle rosse (di capelli) lanciò sua madre nel pozzo.
Al piôv che Dio la manda = Piove che Dio la manda, ossia piove molto forte.
Al prémm dé d’mâz, tótti agli óch al van a spâs = Il primo giorno di maggio, tutte le oche vanno a spasso. (Non ha riferimento a feste popolari)
Al prémm ch’vén dàinter l’é bacch’ = Il primo che entra è cornuto (becco). Quando in una conversazione si verifica un momento di improvviso silenzio.
Al prémm e l’ûltum i gôden l’avantâz = IL primo e l’ultimo sono avvantaggiati.
Ai pràmm pió la camîsa, ch’an fa al zibàn = Gli preme più la camicia che il giubbone. Guarda più ai piccoli interessi che a quelli grandi.
Al pulèr va a cufétt, se la galénna canta a al gâl sta zétt = Il pollaio va in rovina se canta la gallina e il gallo tace. Lo stesso della casa quando comanda una donna . Maschilismo contadino.
Al puvràtt, mantén al récch’ = Il povero (col suo lavoro) mantiene il ricco.
Al quatrén arsparmiè, l’è al prémm guadagnè = Il denaro risparmiato è il primo guadagnato.
Al quatrén fa al bajôch = Il quattrino fa il baiocco. La moneta Pontificia era lo Scudo Romano. La moneta divisionale era costituita dal Baiocco, pari ad un centesimo dello Scudo. A sua volta, il Baiocco era diviso in dieci Denari o Quattrini. Al momento dell’Unità d’Italia lo Scudo Romano venne cambiato in Lire Italiane. Uno Scudo Romano valeva 5,32 Lire.
Al saggn dla massa = Il segno della messa, cioè il tocco di campana che chiama alla messa. E così: Al saggn dla bendziän (Il segno della benedizione): Al saggn dl’Evmarî ( Il segno dell’Ave Maria).
Al sangv n’é âqua = Il sangue non è acqua.
Al saul al dà int’al fnèstér a tótt = Il sole batte alle finestre di tutti (ricchi e poveri).
Al saul l’é al fuglèr di puvrétt = Il sole è il focolare dei poveri.
Al saul vén só tótt al matén, anch se al gâl fa un sunlén = Il sole sorge tutte le mattine, anche se il gallo fa un sonnellino.
Al sbadâc’an vól ingân: o sàid, o sann, o fâm, o quèlch ètér malân: o malincunî, o catîva cumpagnî o vojja d’andèr vî = Lo sbadiglio non vuole inganno: o sete, o sonno, o fame, o qualche altro malanno: o malinconia, o cattiva compagnia, o voglia di andare via.
Al sbaglja un prît a l’altèr: an pól sbaglièr un biójch int’l’arèr? = Sbaglia un prete all’altare: non può sbagliare un bifolco (contadino) nell’arare?
Al scâpa vî ch’al pèr ónt = Scappa via che sembra unto ( velocemente).
Al Sgnaur al manda al fràdd secànd i pâgn = Il Signore manda il freddo secondo i panni.
Al Sgnaur dîs: aiûtét ch’a t’aiuterò anch’a mé = Il Signore dice: aiutati che ti aiuterò anch’io.
Al Sgnaur Maisuda, ch’al n’avèva mai lavurè = Il signor Maisuda che non aveva mai lavorato.
Al sràin d’invérén, al nóvvel d’estèd, l’amaur dal dôn e la caritè di frè, s’al dûra un’aura, al dûra asè = Il sereno d’inverno, le nuvole d’estate, l’amore delle donne e la carità dei frati , se durano un’ora, sono durati abbastanza.
Al starlôt di biójch = La stella dei bifolchi (contadini). Il pianeta Venere o Lucifero. Detto anche: Strèla buarénna (stella bovarina (dei bovari). Il riferimento ai bifolchi è dovuto al fatto che i bovari si alzano molto presto e possono vedere l’ultima stella che brilla in cielo, che è proprio Venere.
Al sumâr l’arcgnóss al bàin dla cô saul dapp ch’a la pérsa = Il somaro (L’asino) conosce i vantaggi della coda solo dopo averla persa.
Al sumâr, par trést ch’al séppa, un quèlch chèlz al le tîra = Il somaro (L’asino), per malconcio che sia, qualche calcio riesce a tirarlo.
Al sumâr di Capuzén bavv âqua e pórta vén = Il somaro (L’asino) dei Cappuccini, beve acqua e porta il vino.
Al tàimp dal térz dè d’avréll, al dûra quaranta dé = Il tempo (le condizioni meteorologiche) del tre di aprile dura quaranta giorni.
Al tàimp dla fésta, anch i amalè i drézzén la testa. = Al tempo della festa anche gli ammalati drizzano la testa.
Al tàimp dla spîga làsa stèr l’amîga; al tàimp da l’û, infénna t’in vû = Al tempo della spiga, lasciare stare l’amica; al tempo dell’uva quanta ne vuoi.
Al taimp l’é galantômen par chi pól stèr d’asptèr = Il tempo è galantuomo per chi può aspettare.
Al tira pió un cavàil ed’dôna ch’n’é un pèr ed bû = Tira di più (ha più forza) un capello di donna che un paio di buoi.
Al vàint an’và mai a lèt con la sàid = Il vento non va mai a letto con la sete. Quando tira vento piove prima di sera.
Al vèl pió incû un pèr ed mandgh che una camîsa dman = Vale di più oggi un paio di maniche che una camicia domani.
Al vén d’cà’só, al n’imbariéga brîsa = il vino di casa propria (fatto in casa) non ubriaca.
Al vén l’é la tatta di vîc = Il vino è il latte (la tetta) dei vecchi.
Al vén sîra a cà da tótt = Viene sera a casa di tutti.
Al vilàn impgnarévv al gabàn, par magnèr û, furmâi e pan = Il villano impegnerebbe il “gabbano”, per mangiare uva, formaggio e pane.
Al vilàn, la zâpa in man = Al villano, la zappa in mano.
Al vlàir imparèr l’è la metè dal savàir = Il volere imparare (il desiderio di imparare) è la metà del sapere.
Al zîl am’guèrda da la palver ed znèr e dal sói d’agast = il cielo mi guardi dalla polvere di gennaio e dal fango di agosto. E’ in netto contrasto con: Znèr pulvrèr, rimpéss al granér = gennaio polveroso, riempie il granaio.
Al zîl am’guerda da na catîva avsénna = Il cielo mi guardi da una cattiva vicina.
Al zîl am’guerda dal vàint, dal frè ch’an sta in cunvàint, dal rumétta e dal puvratt ch’fa bóna vétta = Il cielo mi guardi dal vento, dal frate che non sta in convento, dall’eremita e dal povero che fa una buona vita.
Al zîl am’guerda da quâter F: fâm, fómm, fammna e fiómm = Il cielo mi guardi da quattro F: fame, fumo, femmina e fiume.
Al zîl at’guerda da na dôna ch’èva la bèrba, da un can pastaur, da un cuntadén ch’faga al fatuar, dai prît e dai frè, ch’it fréghén da tótt i lè. = Il cielo ti guardi da una donna con la barba, da un cane pastore, da un contadino che faccia il fattore, dai preti e dai frati che ti fregano da tutti i lati.
Alzîr cmód un gât ed piamb = Agile (leggero) come un gatto di piombo.
Al zîl fa la lèna = Il cielo fa la lana. Cielo a pecorelle.
Al zôp an la tróva mai pèra- Lo zoppo non la trova mai pari.
Al zûgh l’è bèl quand l’è cûrt = Il gioco è bello quando è breve.
Âma chi t’âma: arspand a chi t’ciâma = Ama chi ti ama: rispondi a chi ti chiama.
A magnèr dal castâgn crûdi, ai vén i bdûc = A mangiare delle castagne crude, vengono i pidocchi: era un’antica credenza popolare (forse per distogliere i bambini dal mangiarne troppe).
Amaur an’vól cunséi = Amore non vuole consigli.
Amaur e gelosî, î nâsén insamm = Amore e gelosia nascono insieme. Quando nasce l’amore, nasce anche la gelosia.
Amaur e nûs ins’pólen tgnîr d’arpiat = Amore e noci non si possono nascondere. (L’amore per ovvi motivi, le noci perché muovendosi fanno rumore).
Amaur e sgnurî, in vôlén cumapgnî = Amore e signoria, non vogliono compagnia.
A mâz al tâca al spulvrâz = A maggio comincia il polverone.
Ambasadaur an’pórta panna = Ambasciatore non porta pena.
A murîr an’s’pèga dazî = A morire non si paga dazio.
A n’al truvarévv gnanch al dièvél a dzon = Non lo troverebbe neppure il diavolo a digiuno. Non lo troverebbe nessuno.
An’avàir né lûg né fûgh = Non avere né luogo né fuoco. Essere senza casa e senza focolare.
An’avàir pôra gnanch dal dièvél = Non aver paura neppure del diavolo.
An’avàir gnanch un can ch’ai péssa in tla stanèla = Non avere neppure un cane che le faccia la pipì nella sottana. Di ragazza del tutto priva di corteggiatori.
An bisaggna andèr al mulén s’an s’vól infarinèrs = Non bisogna andare al mulino, se non ci si vuole infarinare. Chi va al mulino, si infarina.
Ân bisèst, ân funèst = Anno bisestile, anno funesto.
Ân bisèst, ân malèster = Anno bisestile, anno da malanni.
An’ cgnóssr’al pan dal prêd = Non distinguere il pane dalle pietre. Di persona balorda.
An’cgnóss la pès e an’la stémma, chi n’ha pruvè la guèra prémma = Non conosce la pace e non la considera, chi non ha provato prima la guerra.
An darévv un Crést da basèr a un muribaund = Non darebbe un Crocefisso da baciare a un moribondo. Di grande egoista, avaro.
Andèr a bachétt = Andare a bacchetti. (Raccogliere legna minuta, era un compito affidato ai vecchi e ai bambini). Era anche un invito a togliersi dai piedi.
Andèr a bessabûga = Andare a zig zag (degli ubriachi).
Andèr a biatta = Andare fortissimo, (oppure rovinarsi del tutto).
Andèr a cócc e spintón = Procedere a urti e spinte. Di chi ha bisogno dell’aiuto degli altri.
Andèr a fèr dla tèra da pgnât = Andare a fare della terra da pignatte. Morire. [Nota: Per altri modi di parlare della morte si rimanda alla prima parte di questa pagina].
Andèr a fèrs fótter = Andare a farsi fottere. Andare al diavolo.
Andèr in gatón = Andare carponi. Come fanno i bambini prima di camminare eretti.
Andèr a la bâsa = Andare da basso. Scendere. Perdere il patrimonio.
Andèr a la carióla = Andare a la carriola. Andare a lavorare da bracciante. Andare in miseria.
Andèr a la fojja = Andare a la foglia. Lavoro femminile che veniva eseguito con un sacco d’ortica o di juta. In primavera le donne raccoglievano le foglie del gelso per alimentare i bachi da seta. A mezza estate raccoglievano invece le foglie dell’olmo per alimentare il bestiame, dato che in agosto scarseggiava il foraggio. Era un lavoro molto faticoso e che rovinava le mani. Per salire sugli alberi usavano lunghe scale di legno di robinia.
Andèr al côt e al crûd = (Letteralmente andare al cotto e al crudo) Andare in miseria.
Andèr a l’érba = Andare a erba. Andare a raccogliere l’erba per i conigli. Oppure andare in luoghi appartati ed erbosi per gli innamorati.
Andèr a lèt con la madôna = Andare a letto senza cena.
Andèr a lét insàmm = Andare a letto insieme. Vivere in concubinato.
Andèr a l’ôrba = Andare alla cieca.
Andèr al ricôver = Andare al ricovero (all’ospizio).
Andèr al só destén = Andare al suo destino.
Andèr a mèl un ragazól = Abortire (involontariamente).
Andèr a quèrt ed lónna = Andare a quarti di luna. Impazzire: Cambiare facilmente umore.
Andèr a Ramma sàinza vaddér al Pèpa = Andare a Roma senza vedere il Papa. Fare una cosa tralasciando la parte più importante.
Andèr a slôfen = Andare a dormire. Dal tedesco schlaffen.
Andèr a tór al vó = Andare a prendere il voi. I nostri contadini usavano trattare i figli non sposati col “tu”, mentre i figli tutti davano del “voi” ai genitori. Quando una ragazza si sposava, dopo 40 giorni dalle nozze si recava dalla vecchia famiglia per prendere il “voi” dai genitori. Anche ai figli maschi sposati spettava il “voi”. Il “lei” era riservato ai superiori, cioè al padrone e al fattore.
Andèr a ûc assré = Andare ad occhi chiusi.
Andèr con al gamb a l’ària = Andare a gambe all’aria: fallire, rovinarsi.
Andèr con la testa int’al sâch = Camminare con la testa nel sacco.
Andèr da galeót a marinèr = Andare da galeotto a marinaio. Cascare dalla padella alla brace.
Andèr drétt fîl = Tirare diritto.
Andèr fôra da la grazia ed’Dio = Andare fuori dalla grazia di Dio. Infuriarsi.
Andèr fôra dal sparadèl = Uscire dal seminato.
Andèr in cîsa a dispèt di Sant = Entrare in chiesa a dispetto dei Santi.
Andèr in gringola = Andare in brodo di giuggiole.
Andèr in purzîl = Andare nel porcile. Dello sposo che andava a vivere presso la famiglia della sposa. Era una condizione umiliante ed avveniva, di norma, quando lo sposo era povero e non di famiglia contadina.
Andèr in spèda = Andare in spada. Di chi cammina con sussiego.
Andèr in squézz = Svanire, finire nel nulla; mancare nel rapporto sessuale.
Andèr int’al canèl = Andare nel canale. Andare all’inferno.
Andèr int’î quaión = Andare nei coglioni. Di cosa che irrita.
Andèrl ‘a tôr int’al bisachén d’arlóii = Andarlo a prendere nel taschino dell’orologio. Andare a quel paese.
An dèr né in sî né in sèt = Non dare né in sei, né in sette. Essere totalmente incapace, non sapere prendere delle decisioni.
Andèr tant pr’al mói, cómm’pr’al sótt = Andare nel bagnato, come nell’asciutto. Essere da uovo e da latte.
Andèr za da cuntadén = Andare giù (smettere) di fare il contadino. Un tempo era una condizione molto triste. Una famiglia cessava di lavorare un podere per diversi motivi. O si scioglieva la comunione famigliare per disaccordo, o per motivi politici, o per motivi di incapacità di lavoro a giudizio del padrone. Chi smetteva di fare il contadino finiva per fare il bracciante o andare a garzone. Entrava così nella categoria dei poveri.
Andèr za d’squèdér = Andare giù di squadra. Uscire dalla retta via.
Andèr za pr’al schèl ed canténna = Andare giù per le scale di cantina. Rovinarsi, perdere la considerazione altrui.
An dîr brisa gât, s’al n’è int’al sâch = Non dire gatto se non è nel sacco.
An dscarrer ed córda in cà d’ l’impichè = Non parlare di corda in casa dell’impiccato.
An èser né chèren né pass = Non essere né carne né pesce.
An’fèr a chi étèr quall t’an vréss par tè = Non fare agli altro quello che non vorresti per te.
An fèr tótt quall ch’t’pû, an magnèr tótt quall ch’t’vû, an spànder tótt quall ch’t’ê, an dîr tótt quall ch’t’sê = Non fare tutto quello che puoi, non mangiare tutto quello che vuoi, non spendere tutto quello che hai, non dire tutto quello che sai. Moderazione.
Ân funzè, ân tribulè = L’anno dei funghi (piovoso) è l’anno dei triboli.
An gratèr la panza a la zighéla, st’an vû ch’la zîga = Non grattare la pancia alla cicala, se non vuoi che pianga. E’ come dire “Lascia stare il can che dorme” = Lasa stèr al can ch’al dróum.
A n’i avanza mai chèren in pcarî, ch’al dièvél an la pórta vî = Non rimane mai carne in macelleria, che il diavolo non se la porti via. (Non c’è donna brutta che non trovi un uomo).
An i é bèrba d’ômen ch’î arîva = Non c’è barba d’uomo che lo raggiunga. Non c’è chi gli stia alla pari.
An’i fó mai ban côl arscaldè, né garzàn turnè = Non ci fu mai un buon cavolo riscaldato, né garzone ritornato.
An’i é pianta sàinza fiaur, an’i é dôna sainza amaur = Non c’è pianta senza fiori, non c’è donna senza amore.
An i é pió cativ saurd ed quall ch’an vôl intandèr = Non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare.
An’i é mai una cunsulaziàn sàinza un dsgóst = Non c’è mai una consolazione senza un dispiacere.
An’i é mèl che al prît an gôda = Non c’è male che il prete non goda (non tragga vantaggio).
An’i é regénna, cla n’èva bisaggn dla sô asvénna = Non c’è regina che non abbia bisogno della sua vicina.
An’i é Sant, né Madôn = Non ci sono Santi, né Madonne. Non c’è scampo o rimedio.
An’i vaddèr lómm da la fâm = Non vederci dalla fame.
Ânma sô, picâja sô = Anima sua, appiccagnolo suo. Chi fa di testa sua paga di tasca sua.
An m’éra mai d’avîs = Non vedevo l’ora.
A ni n’é una fstûga = Non ce n’è nemmeno un poco. Fstûga = Festuca, Fuscello.
An nàiva brisa tótt l’invêren = Non nevica sempre d’inverno. Ricordati che sopra le nubi, splende sempre il sole (Inno alla gioia dalla Nona di Beethoven).
Ân nóv, vétta nóva = Anno nuovo, vita nuova.
An sân brisa nèd la nôt dal squasadén = Non sono nato la notte del piccolo scroscio di pioggia. Non sono stupido.
An sân brisa nèd la nôt di nuvantanóv mamalóch = Non sono nato la notte dei novantanove mamelucchi. Non sono uno sciocco.
An sân brisa nèd pr’al bûs dla dazz = Non sono nato attraverso il buco della grondaia. Non sono stupido.
An s’arcórda i mûrt a tèvla = Non si ricordano i morti a tavola. È di cattivo gusto ricordare persone morte mentre si mangia.
An’s’arvîsa gnanch int’al pisèr = Non gli somiglia neppure nel pisciare. Di persona che pretende di assomigliare a persona che è migliore di lui.
An savàir dir pâpa in trai vôlt : Non sapere dire papa in tre volte. Di chi non sa fare nemmeno le cose più facili.
An savàir gnanch d’papa fràda = Non avere il sapore neppure della minestra fredda. Di chi è ignorante.
An savàir né d’mé né d’tè = Non sapere né di me né di te. Di persona insipida, priva di ogni attrattiva.
An s’è pluchè un ôs = Non s’ è leccato un osso. Di chi, in un pranzo, non ha potuto mangiare.
An’s’pôl cavèr sangv da un radisén = Non si può togliere sangue da un ravanello. Di persona avara o di campo aridissimo.
An s’giódica un sumâr da stèr a zèzer = Non si giudica un asino in decubito.
An’s’mesna sàinz’aqua = Non si macina senz’acqua. Viene usato in senso figurato per: «Non si mangia senza bere» (vino, naturalmente). An’s’pól masnèr a sacch = Non si può macinare a secco.
An’s’môr ed passiàn = Non si muore di passione.
An’s’pól andèr in paradîs in carôza = Non si può andare in paradiso in carrozza.
An’s’pól avàir al lén e a cul chèld = Non si può avere il lino e il culo caldo. Le lenzuola di lino danno un senso di fresco.
An’s’pól avàir al mêl sàinza masch = Non si può avere il miele senza le mosche.
An’s’pól avàir chèren sàinza la zónta = Non si può avere carne senza l’aggiunta. Per i contadini “chèren” era la carne da brodo (da pignatta = da pgnâta). Il macellaio, assieme alla polpa (copertina, girello, doppione, ecc.) dava anche la “zónta” (l’aggiunta) fatta di ossa, cartilagine, ecc.
An’s’pól avàir la batt péina e la mujèr imbarièga = Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
An’s’pól bavver e stuflèr = Non si può bere e fischiare (contemporaneamente).
An’s’pól cavèr un ranôcc’ dal pantàn = Non si può togliere la rana dal pantano.
An’s’pól ciapèr i spéll par la pônta = Non si possono prendere gli spilli per la punta.
An’s’pól dîr gât inféin ch’al n’è in t’al sâch = Non si può dire gatto finché non è nel sacco.
An’spól fèr nôz con di lumègh = Non è possibile fare nozze con delle lumache.
An’s’pól lighèr al vîd con la susézza = Non si possono legare le viti con la salciccia.
An’s’pól rubèr in cà di lèdér = Non è possibile rubare in casa dei ladri.
An’s’pól tgnîr dû gâl in t’un pulèr = Non si possono tenere due galli in un pollaio.
An’stimèr al cavâl da la sèla = Non stimare il cavallo dalla sella.
An’tén gnanch la péssa = Non trattiene neppure l’urina. Di persona che non sa mantenere un segreto.
An’t’fidér ed sràin d’nôt, nóvvél d’estèd, amaur ed dôna, uraziàn ed frè = Non ti fidare del sereno di notte, delle nuvole d’estate, dell’amore della donna e delle preghiere del frate.
An vèl né Crést, né Santa Marî = Non vale né Cristo, né Santa Maria = Non valgono nemmeno le preghiere.
An s’plócca una cadga = Non si lecca neppure una cotica. Non si combina nulla (o in affari o con le donne).
An tôr brisa la chèren d’in bacca al gât = Non prendere la carne dalla bocca del gatto (potrebbe mordere).
An’vèl stuflèr se i bû i n‘an sàid = Non serve fischiare se i buoi non hanno sete. I bifolchi usavano fischiare per indurre i bovini a bere.
A ognón al sô amstîr, i cuntadéin a mèder = A ciascuno il proprio mestiere, i contatini a mietere. (Tanto, vuol dire il proverbio, non sono capaci di fare altro).
A paghèr e a murîr, a s’è sàimper in tàimp = A pagare e a morire, c’è sempre tempo.
A pàil e a saggn = A pelo e a segno. Di cosa che viene appuntino.
A pinsèr mèl as’fa pchè, mó quési mai a se sbâlia = A pensar male si fa peccato, ma quasi mai si sbaglia.
A pgnâta ch’bói, an s’acosta al gât = Alla pentola che bolle, il gatto non si avvicina.
Âqua ch’córr an pórta vlàin = Acqua che corre non porta veleno (I caratteri impulsivi non serbano rancore).
Âqua, dièta e servizièl, guarrésen da ôgni mèl = Acqua, dieta e clistere, guariscono da ogni male.
Âqua e ciàcher, an fâ fritèl = Acqua e chiacchiere non fanno frittelle.
Âqua ed currî, tótt i mèl ai porta vî = L’acqua corrente, guarisce tutti i mali.
Âqua fàirma, l’an guadagna = Acqua ferma non guadagna ( se l’acqua è ferma, il mulino non lavora).
A quaranta, quèlca vôlta as manca = A quaranta (anni) qualche volta si può mancare. Di marito che fa cilecca.
Arbâter l’óss = Accostare l’uscio.
Ardûrsers in’t’la pâja = Ridursi alla paglia. Di chi va in malora.
Arèr pr’al drétt = Arare in modo retto. Rigare diritto.
Arguèrdet da la palver ed’znèr e dal sói ed zóggn = Guardati dalla polvere di gennaio e dal fango di giugno.
Aria d’aldamèra = Aria di letamaio. Si riteneva che gli effluvi del letamaio giovassero alle malattie respiratorie.
Aria dla fnèstra, caulp ed balèstra = Aria della finestra, colpo di balestra. (Colpo di freddo, torcicollo)
Aria ed’satta, fa rimpîr la paza = Aria di sotto fa riempire la pozza . Il vento del Nord-Est porta pioggia.
Arivér a la fén dla cavdâgna = Arrivare alla fine della cavedagna (stradicciola di campagna). Giungere al termine della vita.
Armagnèr salè = Rimanere salata, o di sale. Di ragazza che non trova marito.
Arstèr a bacca sótta = Rimanere a bocca asciutta. Andare con una donna e non ricavare nulla.
Arvàdder al cusdûr a ón = Rivedere le cuciture di uno. Fare le bucce a una persona.
A San Biès la naiv a’i piès = A San Biagio (3 febbraio) piace la neve.
A saŝ trât, an si pàinsa pió = A sasso tirato, non ci si pensa più. Cosa fatta capo ha. (Sasso tirato non si può più fermare).
Ascaulta, guèrda e tès, s’t’vû campè in pès = Ascolta, guarda e taci, se vuoi vivere in pace.
As’ciâpa pió massch con na gaza ed mêl, che con na barélla d’asà = Si catturano più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Con le buone si ottiene tutto.
As dîs al pché e brisa al pcadàur = Si dice il peccato e non il peccatore.
As lîga la baca ai sâch, mó brisa la tèsta ai mât = Si lega la bocca ai sacchi, ma non alle teste dei matti.
As pózza pr’un’ai, quant pr’una rasta = Si puzza per un aglio, come per una resta. La resta era una treccia di agli uniti per il gambo.
As ‘psain dèr la man = Ci possiamo dare la mano. Di due persone che si trovano nelle stesse condizioni (in genere di disavventura).
As sa indóv as nâs, mó an’s’sa indóv as’ mûr = Si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore.
Assrèr l’óss in fassa = Chiudere l’uscio (lasciandolo) socchiuso.
Assrèr un ôc = Chiudere un occhio. Lasciar perdere.
A stèr in ca’ a s’fa la móffa = a stare in casa si fa la muffa (si ammuffisce).
A stèr co’i mât, a s’dvainta mât = A stare coi matti, si diventa matti.
As vadd di can caghèr di viulén = si vedono dei cani cagare dei violini, Si vedono cose impensabili.
Atais a la cîsa, luntàn da Dio = Vicino alla Chiesa, lontano da Dio.
A tè, int’han brisa dè la maila côta da ragazôl = A te non hanno dato la mela cotta da piccolo. Si riteneva che la mela cotta contribuisse allo sviluppo anche mentale dei piccoli. Perciò la levatrice (“ bèlia”) dava al neonato un cucchiaino di mela cotta, così come lo lavava in acqua contenente un uovo crudo sbattuto che, si credeva, contribuisse a rafforzare le ossa, pertanto, il detto di cui sopra, veniva rivolto a chi manifestava poco senno.
A tèvla an’s’dvainta mai vîc’ = A tavola non si diventa mai vecchi.
A tèvla e a lèt, an i vól rispètt = A tavola e a letto, non ci vuole rispetto.
A tór mujèr a s’métt giudézzi = A pender moglie si mette giudizio. A sposarsi si mette la testa a posto.
A tótt ai è rimedi, fôra che a la mórt = A tutto c’e rimedio fuorché alla morte.
A tótt’i dé, basta al sô fastîdi = A ogni giorno, basta il suo fastidio.
A una bèla ca’, un bel caminaról = A una bella casa, un bel comignolo.
Avain fât tràinta , fàn trantón = Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno.
Avàir agl’uracc’ ch’a si vadda a travers = Avere le orecchie trasparenti. Di persona deperita.
Avàir al fillatt tajè pulîd = Avere il filetto ben tagliato. Vale per “Avere la parola facile”.
Avàir al man fâti a rampén = Avere le mani a forma di rampino. Essere ladro.
Avàir al marcàis = Avere le mestruazioni. Oppure: Avàir i sû quî = Avere le sue cose. Oppure: Avàir i parént = Avere i parenti.
Avàir al mèl dl’agnèl: ai crass la panza e ai cala l’usèl = Avere il male dell’agnello: gli cresce la pancia e gli cala l’uccello. Invecchiare.
Avàir ancóra al bagaràn atâc’ae blîguel = Avere ancora il Bagherone attaccato all’ombelico. Ragazzo immaturo. Dalla vecchia usanza delle levatrici di porre una moneta di rame (Bagherone del valore di mezzo baiocco) sull’ombelico dei neonati. Il motivo potrebbe forse ricercarsi nel potere battericida dei sali di rame che, probabilmente, si formavano a contatto col sangue.
Avàir bvó dal bród d’óca = Aver bevuto del brodo d’oca. Di persona insulsa.
Avàir dal gnôch satta al lasén = Avere un gnocco sotto le ascelle. Vale per “Non aver voglia di lavorare”.
Avàir di madón al saul = Avere delle zolle al sole. Possedere terreni.
Avàir dla câca satta al nès = Avere la cacca sotto al naso. Avere una supponenza. Darsi del tono.
Avàir dla róba inféna a i ûc’ = Avere roba fino agli occhi. Avere abbondanza.
Avàir dû mustâz = Lett: avere due mustacchi. Avere due volti. Di uomo doppio, che manifesta con persone diverse opinioni diverse sullo stesso argomento.
Avàir durmé col cûl scuèrt = Avere dormito col culo scoperto. Svegliarsi di malumore.
Avàir i marón dûr = Avere i testicoli duri. Essere forte di carattere.
Avàirén pén al bisachén = Averne piene le tasche.
Avàiren pûch di spécc’ e manch da baratèr = Averne pochi degli spiccioli e meno da cambiare. Di chi è deciso a tirare dritto senza paura.
Avàir int’al scàtel = Avere nelle scatole. Avere in uggia. Oppure: Avàir int’î quaión = Avere nei coglioni, avere antipatia.
Avàir i marón stra l’óss = Avere i testicoli tra l’uscio. Essere senza via d’uscita.
Avàir i pî in tla fôsa = Avere i piedi nella fossa. Essere vicino alla morte.
Avàir i ûc’ in casàn = Avere gli occhi socchiusi.
Avàir i ûc’ fudrè d’parsótt = Avere gli occhi foderati di prosciutto. Non vedere l’evidenza.
Avàir la bacca dal faurén = Avere la bocca del forno. Avere una bocca molto grande.
Avàir la panza a la gaula = Avere la pancia alla gola. Delle gestanti al termine della gravidanza. Di persona molto panciuta.
Avàir la lónna = Avere la luna. Essere di cattivo umore.
Avàir l’aqua cèra in bacca = Avere acqua chiara in bocca. Avere il senso di nausea.
Avàir la róba a pâch e mnèstra = Avere la roba a pachi e minestra. Avere abbondanza di cose e stare bene.
Avàir la tésta int’al novvél = Avere la testa fra le nuvole.
Avàir l’infingardîsia int’agl’ôss = Essere pigri per natura. Infingardîsia è intraducibile, la parola che rende più l’idea è “stanchezza” oppure “voglia di non combinare niente”, fino nelle ossa.
Avàir l’ór a mèza gamba = Avere l’oro fino a mezza gamba. Essere ricchi.
Avàir magnè dal zarvèl ed’gât = Aver mangiato del cervello di gatto. Vale per essere stupidi.
Avàir musghè al tatt a sô mêder = Aver morsicato le mammelle alla propria madre. Essere sfortunato. Essere di cattivo carattere.
Avàir pió cûl che anma = Avere più culo che anima. Avere una fortuna sfacciata.
Avàir una camîsa in dôs e ch’l’ètra int’al fôs = Avere una camicia indosso e l’altra nel fosso (a lavare). Essere privo di mezzi.
Avàir una fâm da comediànt = Avere una fame da commediante. I guitti di un tempo conducevano una vita grama.
Avàir una fâm da sgantén = Avere una fame da segantino. Il lavoro del segantino era molto faticoso e provocava una grande fame.
Avàir una langua cla cûs e cla tàja = Avere una lingua che cuce e taglia. Una malalingua.
Avàir una miséria ch’bâla al trascàn = Avere una miseria che balla il trescone. Il trescone era un ballo contadino dal ritmo frenetico, forse la miseria era tanto grande da essere essa stessa frenetica.
Avàir una miséria cla fa i cinén = Avere una miseria che fa i bambini.
Avàir una muièr bóna, mó taraghéggna = Avere una moglie buona, ma puntigliosa, caparbia.
Avàir un caulp ed’bechîsia = Essere vittima di una distrazione.
Avàir un cûl ch’al fa al nîd i rundócc = Avere un sedere dove i rondoni fanno il nido. Avere una fortuna sfacciata.
Avàir un cûl ch’al pèr ‘na zôca da pchèr = Avere una sede che sembra una tavolozza da macellaio. Di donna molto abbondante nel posteriore. Molto pregiata.
Avàir un nês ch’al guèrda a la glôria = Avere un naso rivolto all’insù. Darsi delle arie.
Avàir un pà a mói e cl’ètér int’l’aqua = Avere un piede a mollo e l’altro nell’acqua. Essere tra l’incudine e il martello.
Avàir un pèl piantè dedrî = Avere un palo piantato dietro. Stare rigido.
Avàir un vtièrî ch’ai fómma l’aria = Avere un abito che fuma l’aria (elegantissimo).
Avàir vindó la sàida = Avere venduto la seta. Vale per essere vestito a nuovo. La seta, e più precisamente il bozzolo, era il primo prodotto vendibile dopo l’inverno. I contadini coglievano l’occasione della vendita per acquistare qualche indumento.
Avanzèr ed stócc = Rimanere di stucco. Rimanere stupiti.
A voj ch’al pióva, mó ch’al timpèsta pó no! = Voglio che piova, ma che tempesti poi no! Voglio che vada male, ma malissimo poi no!
Avréll tótt i dé un baréll; mâz tótt i dé un tinâz = Aprile tutti i giorni un barile (di pioggia); maggio tutti i giorni un tino (di pioggia).
Avréll piuvaus, mâz ventaus, ân venturaus = Aprile piovoso, maggio ventoso, anno venturoso (pieno di avventure).
Azidàint a tè e a cla vèra cla n’t’ha brisa magnè da cén = Accidenti a te e a quella scrofa che non ti ha mangiato da piccolo.
Azuntèr râm a la mascla = Lett: Aggiungere rame al mestolo. Qualcosa che si dice o si fa oltre quello già detto o fatto.
Bacca asrè, an’ciàpa massch = Bocca chiusa non prende mosche.
Bacch e bastunè = Becco e bastonato. Il “Cornuto”. Richiama il “cornuto e mazziato” dei napoletani.
Badèr ai só prasû = Badare ai prezzemoli propri. Non occuparsi dei fatti altrui. Altra versione: Badèr ai prassû dla só stanèla = Badare ai prezzemoli della propria sottana. “Prasôl” significa anche “sfilacciatura” di un tessuto.
Bajûch e amizézzia, i fan stèr la giustézzia = Denaro e amicizia, fermano la giustizia.
Bajûch e capón, i én sàimper bón = Soldi e capponi sono sempre buoni.
Bajûch e santitè, metè e metè = denaro e santità, metà e metà. Si deve fare una tara sulle ricchezze ed i meriti attribuiti alle persone.
Bajûch in câsa e aldàm in mâsa, in’dân brisa frût = Denaro in cassa e letame in massa non danno frutti (non rendono). Il denaro deve essere investito e il letame deve essere sparso nei campi.
Balè ragazû, saltè ragazû, l’é méi èser bécch che magnèr di fasû = Ballate ragazzi, saltate ragazzi, è meglio essere cornuti che mangiare (solo) fagioli.
Balèr la vècia = Ballare la vecchia. Quel fenomeno di rifrazione che si manifesta nelle ore calde dell’estate quando la luce vicino al suolo si mette a vibrare.
Ban da frézzér = Buono da friggere. Persona di cui non fidarsi.
Ban vén, fa ban sangv = Buon vino fa buon sangue.
Barâta, barâta, d’una cavâla a i’avanzé una gâta = Baratta, baratta, di una cavalla rimase una gatta. A forza di fare cambi, al posto di una cavalla, rimase una gatta.
Baratèr la farénna in rammel = Cambiare la farina in crusca (fare un cattivo affare).
Barbîr zauvén e dutaur vèc’ = Barbiere giovane (perché ha la mano ferma) e dottore vecchio (perché ha esperienza).
Batr’ al cûl in tèra = Battere il culo in terra. Finire malamente.
Batr ‘al cûl int’un cavécc’ = Battere il culo in un cavicchio. Fare una cosa che torna a proprio danno.
Batèr la generèl = Battere la generale. In termine militare vale per suonare l’adunata generale. Veniva usato per “riunire un folto gruppo di amici per fare bisboccia”.
Batr’al nès dapartótt = Mettere il naso dappertutto. Impicciarsi di tutti e di tutto.
Bavv’dal vén e lâsa che l’âqua la vâga al mulén = Bevi del vino e lascia che l’acqua vada al mulino.
Bavver dal brôd d’oca = Bere del brodo d’oca. Perdere tempo. Ascoltare con attenzione tutto ciò che gli altri dicono (anche le sciocchezze).
Bavver sainza sàid e fèr l’amaur fôra ed stasàn, i én dau côs da bazurlàn = Bere senza sete e fare l’amore fuori stagione, sono due cose da sciocco.
Bèla fórza, amazèr ón ch’al chèga = Bella forza, uccidere uno mentre fa i suoi bisogni (è in momento di debolezza). Col dovuto rispetto, ricorda il detto di Francesco Ferrucci a Maramaldo: “Vile tu uccidi un uomo morto”.
Bèla in vésta, dàinter trésta = Bella da vedere, ma cattiva d’animo. Di certi frutti e di certe donne.
Bèl in fâsa, brótt in piâza = Bello in fasce (da piccolo), brutto in piazza (da grande). Altro proverbio guarda la cosa all’inverso: Brótt in fâsa, bèl in piâza.
Bèl tàimp. Salût e quatréin, in stóffn inción, né grand e né céin = Bel tempo, salute e quattrini, non stancano nessuno, né grandi e né piccoli.
Bès ed bacca, cór an tacca = Bacio di bocca, cuore non tocca. Non impegna, non compromette.
Bianch cmód al bigât dal pén = Bianco come la larva del pino. Persona molto pallida. Viene paragonata alla larva della Processionaria del pino (Thaumatopaea pytiocampa; Lepidottero). Lo strano è che la larva della Thaumatopaea è pelosa e tutt’altro che bianca.
Bianc cmód un tâi d’navàn = Bianco come una fetta di navone. Esangue, di un pallore cadaverico. La radice carnosa del Navone (Brassica napus) è bianchissima al taglio.
Biasèr di paternôster = Lett. Masticare dei paternoster. Pregare continuamente a bassa voce.
Biasèr la curànna = Lett. Masticare la corona. Recitare il Rosario.
Bisaggna andghèr indóvv a i è dl’aqua èlta = Ci si deve annegare dove l’acqua è alta.
Bisaggna avàir al scarpian in’t’al bursèl = Bisogna avere lo scorpione nel borsello. La paura dello scorpione trattiene dal mettere la mano nel borsello per prendere danaro.
Bisaggna batèr al fèr, infénna cl’è chèld = Bisogna battere il fero finché è caldo.
Bisaggna balèr secand la mûsica = Bisogna ballare secondo la musica. Ci si deve regolare secondo le opportunità
Bisaggna fèr al pâs secand la gamba, se nà a se strâza al cavâl dal brègh = Bisogna fare il passo secondo la gamba, altrimenti si straccia il cavallo dei pantaloni.
Bisaggna fèr la scuràzza secand al bûs = Lett. Bisogna scoreggiare secondo il buco (del sedere). Il significato è identico a quello appena sopra (fare il passo secondo la gamba).
Bisaggna plèr la gâza, sàinza fèrla zighèr = Bisogna pelare la gazza senza farla piangere. Variante: bisaggna scurdghèr la gâta, sainza fèrla zighèr = Bisogna scorticare la gatta, senza farla piangere.
Bisaggna sumnèr con la man, brisa con al sâch = Bisogna seminare con la mano, non col sacco. Si regola meglio la quantità e la densità del seme e si evita lo sciupio di semente.
Bîstia ch’an bavv, bîstia trésta = Bestia (bovino) che non beve, bestia che vale posco.
Bisugnarév che quand la dôna nâs, l’ômen zapâs = Bisognerebbe che quando la donna nasce, l’uomo zappasse. Il senso è che nel matrimonio l’uomo dovrebbe essere assai più anziano della donna.
Bóna lèna = Lett. Buona lana. Persona scaltra, maliziosa, furba.
Bonanôtt cóla e scctievo sggnaur Pastézz = Buonanotte colla e non c’è altro, signor Pasticcio. Si dice di quando si ritiene che un affare sia andato a male. Cosi come: Bonanôtt ai sunadûr = Buonanotte suonatori. Per dire anche che la cosa è finita.
Bóni paról e trést fât, ingânén i sèvi e i mât = Parole buone e azioni cattive, ingannano i saggi e i matti.
Brâza al côl e gamb a lèt = Braccia al collo e gambe a letto. Così si curano gli arti malati.
Bréll; tréll; campanéll; côt; spulpè = Brillo; trillo; campanile; cotto; spolpato. In ordine crescente i diversi gradi dell’ebbrezza.
Brisa ban d’balèr = Non essere capaci di ballare. Offesa sanguinosa, forse la più grave. Il ballo, infatti, aveva una grande importanza nella vita sociale delle nostre campagne. Era un momento d’incontro, di conoscenza tra i giovani e di sfogo che, a parte il ballo, la Messa, la festa patronale, non avevano altre occasioni per incontrarsi.
Brótta cómm al pchè murtèl = Brutta (di donna) come il peccato mortale.
Brótt cómm un spurâc = Brutto come uno spauracchio spaventapasseri.
Brótt e lóngh cumpâgn una quaràisma = Brutto e lungo come una Quaresima.
Brusèr al pajàn = Bruciare il pagliericco. Usufruire di una prestazione senza pagare il corrispettivo (specie di prostitute).
Brûsa, brûsa, Cranvèl, t’an pôsa pió turnèr infénna a la nôt ed Nadèl = Brucia, brucia, Carnevale, che tu non possa più tornare fino alla notte di Natale. Lo si diceva a mezzanotte del martedì grasso.
Bruntlèr un pèzz ed pan = Dare agli altri con molta malagrazia, malvolentieri .
Butàiga avérta, aspéta cumérzi = Bottega aperta, attende commercio.
Buvinèl = Imbuto. Rivolto a chi, giocando, fa un colpo molto fortunato.
Ca fâta, pussiàn sfâta = Casa costruita, possessione (podere) disfatta. Per l’alto costo del costruire. Altro proverbio simile: Chi vôl dèr fand a la bûrsa, fâga fabrichèr = Chi vuole spendere tutto quello che possiede, faccia costruire. Altro ancora: Ca quant basta, têra quant as’pôl = Casa quanto basta e terra quanto si può.
Cambièr l’âqua al canarén = Cambiare l’acqua al canarino = Orinare.
Campa cavâl, che l’érba crass = Campa cavallo che l’erba cresce.
Campèr con la têsta int’al sâch = Vivere con la testa nel sacco, alla cieca.
Can afamè, an bèda a bastunè = Il cane affamato non si cura delle bastonate.
Can an mâgna can = Cane non mangia cane.
Can ch’baja, an môsga brisa = Cane che abbaia, non morde.
Can da pchèr, pôrz da munér e dôna da ustarî, a ni tulèdi mai, par la Verginmarî = Cane da macellaio, maiale da mugnaio e donna da osteria, non prendeteli mai per la Vergine Maria. Tutti abituati troppo bene.
Capîr pr’âria = Comprendere al volo. Un tizio che si vantava di capire le cose al volo, usava dire: Mé a’péss’in âria = Io piscio in aria.
Cârga cénna la vûda al bôsch, cârga grôsa la stiânca agl’ôs = Il carico piccolo vuota il bosco, il carico grande rompe le ossa. Bisogna lavorare con calma, senza sforzi che stancano.
Caschèr al budèl = Il cadere delle budella: perdersi d’animo.
Caschèr al furmâi só int’al lasâgn = Cadere il cacio sulle lasagne.
Caschèr da la sann; Murîr da la sann = Cadere dal sonno; Morire dal sonno.
Caschèr in t’al balatràn = Cadere in basso. Balatràn era la parte bassa dei filatoi da seta azionati ad acqua.
Caschèr za dal pirôl = Cadere dal piolo (gradino). Nelle famiglie tutte le moine sono riservate all’ultimo nato: quello che lo precedeva era negletto. L’è caschè za dal pirôl.
Caschèr da vâl = Lett: cadere dal setaccio =Perdere la stima; Perdere la simpatia.
Castîga la cagna, ch’al can starà a ca’ = Castiga la cagna e il cane resterà a casa sua.
Castighèr col bastan dla bumbèsa = Castigare con un bastone di cotone idrofilo. Castigare in modo apparente.
Catèr al cô dla gavatta = Trovare il bandolo della matassa.
Cavâl vèc’érba tandra = Il cavallo vecchio vuole erba tenera. L’uomo anziano vuole donna giovane.
Cavèr ón d’int’i pdûc’ = Togliere uno dallo stato di miseria. Lett: Togliere uno dai pidocchi.
Cavèr un quèl da la bacca = Togliere una cosa dalla bocca. Rinunciare a una cosa utile per darla agli altri.
Cavî e guai, mànchen mai = Capelli e guai, non mancano mai.
Cgnósser la mérda a nès e l’urtîga a tâst = Lett. Conoscere la merda a naso e l’ortica al tasto. Capacità veramente singolari.
Ch’al pôch’ ed stàint = Quel poco che serve per vivere stentatamente.
Che al zîl at’guèrda da quâtr côs: fâm, fómm, fiómm e famna catîva = Che il cielo ti guardi (protegga) da quattro cose: fame, fumo, fiume (le piene dei fiumi e torrenti della nostra provincia sono state e lo sono ancora, un incubo per i nostri contadini) e da donna cattiva.
Che bî cavî, ch’avî ch’a vói ch’a vi cavèdi vî = Che bei capelli che avete, che voglio che ve li caviate. Scioglilingua o gioco di parole.
Che càulpa n’ha la gâta se l’azdaura l’è mâta = Che colpa ne ha la gatta se la reggitrice (della casa) è matta.
Chèld ed pâgn’an fé mai dân = Caldo di abiti, non fece mai male.
Chèlz ed cavâla, an fé mai mèl al puledrén = Calcio di cavalla, non ha mai fatto male al puledro.
Chèren ch’crass l’an pôl stèr fàirma: chèren ch’câla l’an pôl stèr zétta = Carne che cresce (l’infanzia) non può stare ferma, carne che cala (la vecchiaia) non può stare zitta.
Chèren ch’crass, mâgna spass = Carne che cresce (cioè i bambini) mangia spesso.
Chèren fa chèren; passa fa vas = Carne fa carne; pesce fa vento intestinale. Si dubitava delle virtù nutritive del pesce.
Chèrta canta e vilàn dôrum = Carta canta e villano dorme.
Chi a i n’ha dimondi, chi an n’ha brîsa e chi è sàinza camîsa = Chi ne ha molti, chi non ne ha e chi è senza camicia.
Chi la slónga, la scâpa = Chi la rinvia, la evita. Non fare oggi ciò che puoi fare domani.
Chi ama al can, ama al padran = Chi ama il cane ama il padrone.
Chi an bâla par Cranvèl, o ch’al môr o ch’al sta mèl = Chi non balla per Carnevale, o è morente o sta male.
Chi an’fa, an fâla, chi an’maina bû, an’arbèlta câr = Chi non fa non falla, chi non conduce buoi, non rovescia carri.
Chi an’fîla par Nadèl, suspira par Cranvèl = Chi non fila per Natale, sospira per Carnevale. Andando verso la primavera si allungano le giornate e rimane meno tempo per filare perché le ore di luce debbono essere utilizzate per i lavori nei campi.
Chi an’zûga par Nadèl, chi an’bâla par Cranvèl e chi an’s’imbarièga par San Martén, al farà’na bróta fén = Chi non gioca per Natale, chi non balla per Carnevale e chi non si ubriaca per San Martino, farà una brutta fine.
Chi n’s’anîga int’al mèr, al s’anîga int’al fiómm = Chi non si annega nel mare, si annega nel fiume.
Chi arîva prémm al mulén, mèsna = Chi arriva primo al mulino, macina.
Chi as’fîda, l’avanza imbruiè = chi si fida, rimane imbrogliato.
Chi avéss, chi pséss, e chi fóss l’éra al ra di quajón = Chi avesse, chi potesse, chi fosse, era il re dei coglioni (minchioni).
Chi bain sèra, an vôl guèra = Chi chiude bene (chi si chiude bene in casa), non vuole guerra (non vuole grane).
Chi bâla sàinza sunèr, l’è mât da lighèr = Chi balla senza musica, è pazzo da legare.
Chi canta a tèvla e a lèt, l’è un mât parfèt = Chi canta a tavola e a letto, è un matto perfetto.
Chi cmàinza mèl, finéss pîz = Chi comincia male, finisce peggio.
Chi d’galénna nâs, al tén raspèr = Chi nasce da gallina, è costretto a razzolare.
Chi dôrum col can, al’s’lîva col póls = Chi dorme col cane, si alza con le pulci.
Chi dôrum d’agast, dôrum a sô cast = Chi dorme d’agosto, dorme a proprio costo. Agosto è un mese di grandi lavori, chi dorme, perde guadagno.
Chi dscarr mèl par dedrî, al dscarr al cûl = Chi parla male dietro le spalle, parla al deretano.
Chi dsprèza, caumpra = Chi disprezza, compera.
Chi d’un èter l’amstîr vôl fèr, al s’fa minciunèr = Chi vuol fare il mestiere di un altro, si fa ridere dietro.
Chi é fortunè, al pôl balèr cóm al vôl = Chi è fortunato, può ballare come vuole.
Chi é busèder é lèder = Chi è bugiardo è ladro.
Chi é cuntàint, al lauv le mâgna = Chi è contento, il lupo lo mangia. Secondo antica credenza, non bisogna mai mostrare gioia e felicità, perché il Maligno è sempre in agguato.
Chi é gelàus, é bacch’ = Chi è geloso, è cornuto.
Chi é inamurè, lûs = Chi è innamorato, si illumina. Molto poetico.
Chi é in pî al câsca fazilmàint = Chi sta in piedi, può facilmente cadere.
Chi é in suspèt. l’é in difèt = Chi è in sospetto, è in difetto.
Chi é int’l’óss, da impâz a tótt = Chi è fermo sulla soglia, impedisce il passaggio a tutti.
Chi é mât a la sîra, é mât anch a la maténna = Chi è matto alla sera, è matto anche al mattino.
Chi é sgnè da Dio è sgnè da î ômen = Chi è segnato da Dio, è segnato anche dagli uomini. Si riteneva un tempo che le persone malformate o con difetti fisici fossero di animo malvagio.
Chi é stè musghè da la béssa, ha pôra anch dla lusèrta = Chi è stato morso da una biscia, ha paura anche della lucertola. La stessa cosa: Al can stà scutè da l’aqua chèlda, ha pôra anch dla fradda = Il cane che è stato scottato dall’acqua calda, ha paura anche della fredda.
Chi é svêlt a magnèr, é svêlt a lavurèr = Chi mangia rapidamente, rapidamente lavora.
Chi é una canâja, s’al sammna al furmàint, al cój d’la pâja = Chi è una canaglia, se semina il grano, raccoglie paglia. Punizione divina che non sempre viene.
Chi fa al cant sàinza l’ôst a le fa dau vôlt = Chi fa il conto senza l’oste, lo fa due volte.
Chi fa a sô môd, pèga ed sô bisâca = Chi fa a modo suo, paga di tasca propria.
Chi fa dal bàin, an’s’pôl aspptèr che bàin = Chi fa del bene, si aspetti bene. Molto ottimista.
Chi fa i vèrs pió fûrt, ha rasan = Chi grida più forte, ha ragione
Chi fa dal mèl, an’s’aspèta dal bàin = Chi fa del male, non si aspetti del bene.
Chi fa prèst i dént, lâsa prèst i parént = Chi fa presto i denti, lascia presto i parenti. La dentizione precoce era considerata un presagio di vita breve.
Chi fîla sutîl, sta un pèz a urdîr; chi fîla grôss, métt prèst indôs = Chi fila sottile impiega più tempo a ordire; chi fila grosso indossa presto (non bisogna essere troppo meticolosi).
Chi ha al câr e i bû, fa prèst i fât sû = Chi ha il carro ed i buoi, fa presto i fatti suoi.
Chi ha al misclén in man, al fa la mnèstra a sô môd = Chi ha il mestolo in mano, fa la minestra a modo suo.
Chi ha al pan al n’ha brîsa i dént, chi ha i dénti al n’ha brîsa al pan = Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane.
Chi ha al zôc par Nadèl, al le téggna par Febrèr = Chi ha il ciocco per Natale, lo tenga per Febbraio (mese freddo).
Chi ha bisaggn, al se sdcômda = Chi ha bisogno, si scomodi (si muova).
Chi filè avè una camîsa, e chi an filè brîsa ai n’avè dau = Chi filò ebbe una camicia, e chi non filò ne ebbe due.
Chi ha bôni uracc’, intanda = Chi ha buone orecchie intenda.
Chi ha dagli uracc’ cénni al môr prèst = Chi ha orecchie piccole muore presto. Una delle tante credenze popolari.
Chi ha d’avàir ventûra, al n’ha bisaggn ed livèrs a bonaura = Chi è destinato ad avere fortuna, non ha bisogno di alzarsi presto.
Chi ha di bajûch, ha di parént = Chi ha soldi, ha parenti.
Chi ha di bdûc è san = Chi ha i pidocchi è sano. Forse perché i parassiti attaccavano preferibilmente coloro che avevano il sangue sano e, quindi, più nutriente.
Chi ha di bon cavâl in stâla, pôl anch andèr a pî = Chi ha dei buoni cavalli nella stalla, può anche andare a piedi. Tanto tutti sanno che di cavalli ne ha.
Chi ha di fiû, tôtt i pcón i n‘én sû = Chi ha dei figli, non tutti i bocconi sono suoi. Deve nutrire per primi i figli.
Chi ha di zûch, fa dal bragguel = Chi ha dei ceppi, fa delle schegge. (la braggla era una grossa scheggia di legno ottenuta spaccando dei grossi ceppi). Chi ha il molto, ha il poco.
Chi ha fât al mèl, fâga la penitàinza = Chi ha fatto il male, faccia la penitenza.
Chi ha i bû da par sé, al pôl arèr al lonedé = Chi ha i buoi in proprietà, può arare quando crede e quindi, anche il lunedì. Può arare quando vuole e non deve attendere i comodi di altri.
Chi ha la brîga, s’la dsbrîga = Chi ha la bega, la risolva.
Chi ha l’amèr in bacca, an’pôl spudèr daulz = Chi ha l’amaro in bocca, non può sputare dolce.
Chi ha la sèlvia in ca, è mèdich e an’al sa = Chi ha la salvia in casa, è medico e non lo sa. La salvia comune (Salvia officinalis) è coltivata come condimento. Ha anche virtù stimolanti, sudorifiche, toniche ed astringenti. Altre specie simili sono la Salvia sclarea, spontanea in Italia meridionale, usata per aromatizzare il vermouth, la Salvia pratensis (Ciarèla) le cui foglie sono toniche e stimolanti. Appartengono alla famiglia delle labiate.
Chi ha la tass e la raggna, d’èter mèl an bisaggna = Chi ha la tosse e la rogna non ha bisogno di altri mali (soffre già abbastanza).
Chi ha magnè l’arvàjja, ch’al spâza la curnâcia = Chi ha mangiato i piselli, pulisca i baccelli.
Chi ha mèl a la panza, an mâgna marón = Chi ha mal di pancia, non mangi castagne.
Chi ha pió giudézzi, al métta in ôvra = Chi ha più senno, lo usi.
Chi ha pisè, ch’al sûga = Chi ha pisciato, asciughi.
Chi ha pôra, an magna taiadèl = Chi ha paura, non mangia tagliatelle (Il mondo è degli audaci).
Chi ha pûch pâgn, mèl as’crûv = Chi ha pochi vestiti, si copre malamente.
Chi ha un ban zucàn, ch’al le téggna par San Biasàn = Chi ha una buona damigiana, la tenga per San Biagio (3 febbraio).
Chi ha un ban maré, a s’i cnóss int’la fâza = Chi ha un buon marito, la si riconosce dalla faccia (La donna che ha un buon marito la si riconosce a guardarla).
Chi ha un bèl nès, ha un bèl chès = Chi ha un bel naso, ha un bel caso.
nChi ha un zôch ban, al’téggna par marzan = Chi ha un buon ciocco, lo tenga per marzo.
Ch’imprèsta timpèsta = Letteramnente: chi impresta, tempesta (Gli oggetti prestati, spesso non tornano tutti indietro e o non ritornano affatto).
Chi invcéss, amatéss = Chi invecchia, impazzisce. (Riferito, di solito, a chi si innamora in tarda età).
Chi in zoventó ciâpa ch’al vézzi, quand l’é vèc’, l’attand a cl’ufézzi = Chi in gioventù prende quel vizio, quando è vecchio conserva la stessa abitudine (Il lupo perde il pelo ma non il vizio).
Chi la dûra, la vénz = Chi tiene duro la vince.
Chi la fa satta la nàiv, la se dscrûv = A farla sotto la neve, si scopre (quando la neve si scioglie).
Chi lavaura fa al spàis ed chi sta in ca = Chi lavora fa le spese di chi resta in casa.
Chi la slônga, la scâpa = Chi riesce a rinviarla, riesce ad evitarla.
Chi la trà vî a palè, la va a zarchèr col cucièr = Chi la getta a palate (la ricchezza) la va a cercare col cucchiaio.
Chi lavaura l’ha una camîsa, ch’in lavarua al n’ha dau = Chi lavora ha una camicia, chi non lavora ne ha due.
Chi lavaura, va in malaura, chi n’lavaura tant’ai va: l’é po méi an lavurèr se in malaura a s’ha d’andèr = Chi lavora va in malora, chi non lavora ci va lo stesso: è quindi meglio non lavorare, se in malora si deve andare.
Chi la vôl côta, chi la vôl crûda, chi vôl la taurta, chi vôl i turtî = Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi vuole la torta, chi vuole i tortelli (Tot capita, tot sententiae).
Chi magna in pî, magna par trî = Chi mangia in piedi, mangia per tre.
Chi l’ha d’ôr, chi l’ha d’arzàint e chi l’an vèl un azidàint = Chi l’ha d’oro, chi l’ha d’argento e chi non vale un accidente. (Della diversa fortuna delle donne indipendentemente dal merito).
Chi li fa, li pèga = Chi li fa, li paga (Dei debiti).
Chi li pôrta, l’é l’ûltum a savàirel = Chi le porta, è l’ultimo a saperlo (delle corna).
Chi manazza al mèl, a’s’plócca al dîda = Chi maneggia il miele, si lecca le dita. Vedi: (Chi va al mulèn, al s’infarénna = Chi va al mulino, si infarina).
Chi mâza al ninén, sta bàin prûn puctén = Chi uccide il maiale, sta bene per un po’ (di tempo).
Chi mâza la polsa marzarôla, mâza la mèder e anch la fiôla = Chi uccide la pulce di marzo, uccide la madre e anche la figlia (perché impedisce la generazione successiva).
Chi mett la zauvna atàis al vèc’, métt la cónna atàis al lèt = Chi mette una giovane vicino ad un vecchio, mette la culla vicino al letto. (Dal matrimonio tra una donna giovane ed un uomo anziano nascono molti figli, almeno così si credeva).
Chi métt al mât da par sé, painsa la nôt a quall ch’l’ha da fèr al dé = Un matto, lasciato solo, pensa la notte alle pazzie che farà il giorno dopo.
Chi minciauna è minciunè = Chi prende in giro, viene preso in giro.
Chi mûda lûgh, mûda furtónna = Chi cambia posto (paese), cambia fortuna (anche la propria vita).
Chi mûra in invèren, mûra in etèren = Chi costruisce in inverno, costruisce per l’eternità.
Chi m’vôl bain, um’brèva; chi m’vôl mèl um’lôda = Chi mi vuol bene mi sgrida, che mi vuole male, mi loda.
Chi nâs bèla, nâs maridè = Chi nasce bella, nasce maritata.
Chi nâs èsen, môr sumâr = Chi nasce asino, muove somaro.
Chi nâs mât, an guaréss mâi = Chi nasce matto, non guarisce mai.
Chi nâs sfighè, tótti al masaggn i caschen in t’la tèsta = Chi nasce sfortunato, tutti i macigni gli cadono in testa.
Chi n’astôpa busén, astôpa busàn = Chi non chiude i buchi piccoli, chiude quelli grandi. (Chi non cura la manutenzione ordinaria, deve fare quella straordinaria).
Chi n’campra i âi al dé d’San Zvân, l’é puvràtt tótt l’ân = Chi non compra gli agli per il giorno di San Giovanni Battista (24 giugno) è povero tutto l’anno. (Antica credenza popolare).
Chi n’chèga cagarà, chi n’péssa murirà = Chi non caga, cagherà, chi non piscia morirà. (Il proverbio mette in evidenza la maggior gravità della ritenzione dell’orina rispetto a quella delle feci).
Chi n’cradd a la bôna mèder, al cradd a la mèla madraggna = Chi non crede alla buona madre, crede poi alla cattiva matrigna.
Chi n’è ban pr’al Ra, al n’é ban gnanch par la Regénna = Chi non è buono per il Re, non è buono neppure per la Regina Frase di scherno che veniva rivolta ai riformati (Schèrt ed lèva = Scarti di leva).
Chi n’ha che un ôc’, spass a s’al sfràiga = Chi ha un occhio solo, spesso se lo frega.
Chi n’ha magna, e chi an n’ha sbadâcia = Che ne ha mangia, chi non ne ha sbadiglia.
Chi n’ha vargagna, tótt al mand l’é sô = Chi non ha vergogna, tutto il mondo è suo. Vergogna vale anche per “pudore”.
Chi n’ha zarvèl, êva gamb = Chi non ha testa, abbia gambe.
Chi n’in pôrta, n’in frôsta = Chi non porta (abiti), non li consuma.
Chi n’magna, ha magnè = Chi non mangia, ha già mangiato.
Chi n’magna la galénna par cranvèl, la magna int’al cavzèl = Chi non mangia la gallina per Carnevale, la mangia al capezzale (cioè da ammalato).
Chi’n mantén la gâta, mantén i póndgh = Chi non mantiene la gatta, mantiene i topi.
Chi n’pàinsa prémma, suspîra dapp = Chi non riflette prima (di fare una cosa), sospira dopo.
Chi n’péssa in cumpagnî, l’é un lèder e una spî = Chi non piscia in compagnia, è un ladro e una spia.
Chi pió spand, manch spand = Chi più spende di più, meno spende.
Chi n’pôl bâter al cavâl, bât la sèla = Chi non può battere il cavallo, batte la sella.
Chi n’sa zughèr, zûga danèr = Chi non sa giocare, giochi denaro.
Chi n’vôl bàin al bîsti, an vôl bàin gnanch ai cristiàn = Chi non ama gli animali, non ama nemmeno gli esseri umani.
Chi n’vôl balèr, ch’an vâga a la fèsta = Chi non vuole ballare, non vada alla festa.
Chi n’zûga, vénz sàimper = Chi non gioca, vince sempre.
Chi padéss, cumpatéss = Chi patisce, compatisce.
Chi pèga dèbit, aquèsta crèdit = Chi paga i debiti, acquista credito.
Chi pèga inànz trât, n’ha mai al lavurîr bàin fât = Chi paga in anticipo, non ha mai un lavoro ben fatto.
Chi pèrd l’unaur, pèrd incôsa: chi pèrd la fàid, pèrd al rèst = Chi perde l’onore, perde tutto: chi perde la fede perde il resto.
Chi pianta la pèlma, an cój i frût = Chi pianta la palma, non raccoglie i frutti.
Chi pîgra as’fa, al lauv la mâgna = Chi pecora si fa, lupo la mangia.
Chi pôl andèr al pâs pr’al sótt, ch’an vâga ed caursa pr’al sói = Chi può andare al passo nell’asciutto, non vada di corsa nel fango.
Chi pratica al zôp, tén zupghèr = Chi pratica lo zoppo, bisogna che zoppichi.
Chi prémm arîva, prémm alôza = Chi prima arriva, per primo trova da dormire.
Chi ramp pèga, e i sdûz i én sû = Chi rompe paga, e i cocci sono suoi.
Chi sbalia impèra = Chi sbaglia, impara. (Sbagliando s’impara).
Chi sammna con la lónna setembrénna, s’al sammna dal furmàint, al cój dl’avàina = Chi semina con la luna settembrina, se semina frumento, raccoglie avena. (Settembre non è il mese adatto per le semine).
Chi sammna fèv sàinza guarnèri, li cój sàinza curnâcia = Chi semina fave senza concimarle, le raccoglie senza baccelli. La fava seminata senza concime, non produce frutto.
Chi sammna i fasû, a i nâs el côren = A chi semina fagioli, nascono le corna.
Chi sammna pr’al sótt, al cój tótt = Chi semina col terreno asciutto, raccoglie tutto.
Chi s’arpèra satta la frâsca, l’ha qualla ch’piôv e qualla ch’câsca = Chi si ripara sotto la frasca, ha l’acqua che piove e quella che gocciola dalle foglie.
Chi sbadâcia, zàirca dôn = Chi sbadiglia, cerca donne.
Chi sbàja ed’sô tèsta, pèga ed sô bisâca = Chi sbaglia di testa sua, paga di tasca sua.
Chi sêrv Dio, ha un ban padran = Chi serve Dio, ha un buon padrone.
Chi sguâza una vôlta, an stàinta sàimper = Chi gode una volta, non stenta sempre. Infatti, almeno una volta, ha goduto.
Chi s’marîda, zûga un térn al lôt = Chi si sposa, gioca un terno al lotto.
Chi sôfer par amaur, an’sént dulaur = Chi soffre per amore, non sente dolore.
Chi spand in fûria, stanta adêsi = Chi spende in fretta, stenta adagio.
Chi spâza la ca ed sîra, mûr puvratt = Chi spazza la casa di sera, muore povero. (Vecchia superstizione).
Chi spûda a l’èlta al spûd ai câsca int’la fâza = Chi sputa verso l’alto, gli cade lo sputo in faccia.
Chi sta bàin, an’s’môva = Chi sta bene, non si muova.
Chi stémma, an campra = Chi stima, non compra.
Chi strasénna al pan da vîv, dapp’môrt al’andrà a cójjer con un panîr sàinza fand = Chi sciupa il pane da vivo, dopo la morte sarà costretto a raccoglierlo con un paniere senza fondo. Lo si diceva ai bambini per invitarli a non sciupare il pane.
Chi s’vôl bàin, an s’vôl mai mèl = Chi si vuole bene, non si vorrà mai male. Qualcosa dell’amore rimane sempre.
Chi tèrd arîva, mèl alôza = Chi tardi arriva, male alloggia.
Chi va al mulén, al’s’infarénna = Chi va al mulino, si infarina.
Chi va a nôz, va a bambôz = Chi va a nozze va a (lett. bamboccio) cioè a bimbo piccolo neonato. Era usanza che gli invitati al pranzo di nozze venissero invitati anche al battesimo, anzi, mentre a nozze non si portavano regali, al battesimo si dovevano portare. Alla cerimonia non partecipava la madre alla quale era interdetto l’ingresso in chiesa sino alla ricomparsa del flusso mensile, previa, tuttavia di un’assoluzione del peccato originale che, in tempi maschilisti, pare toccasse solo la donna. La cerimonia si svolgeva quasi di nascosto, con l’ingresso, in chiesa, della donna (neomamma) che doveva portare in mano una candela accesa benedetta il giorno della candelora il 2 febbraio. L’ingresso non poteva avvenire dalla porta principale, ma da un porta secondaria laterale.
Chi va col zôp, tén zupghèr = Chi va con lo zoppo, deve zoppicare.
Chi va fôra dal sô mstîr, fa la sóppa int’al panîr = Chi va fuori dal suo mestiere, fa la zuppa nel paniere (cioè non combina nulla).
Chi va piàn, va san e va luntàn; chi va fôrt, va a la môrt = Chi va piano, va lontano; chi va forte va alla morte.
Chi vénz la prémma al pérd al sâch e la farénna = Chi vince la prima (partita o giocata), perde il sacco e la farina. Vedi anche: La prémma l’é di trést = La prima (giocata) è dei tristi (incapaci).
Chi vindammna trôp prèst, svénna pôch e tótt agrèst = Chi vendemmia troppo presto, svina poco e tutto agresto. L’agresto, che a volte veniva prodotto volutamente, era una specie di vino di uva acerba che veniva usato per bibita (allungato con acqua), oppure al posto dell’aceto.
Chi vîv bàin , bàin al môr = Chi vive bene, muore bene.
Chi vîv mèl, mèl môr = Chi vive male, muore male.
Chi vôl al pàss, bisagna ch’al s’immója = Chi vuole il pesce, deve bagnarsi.
Chi vôl bàin aparîr, l’ha prémma da padîr = Chi vuole apparire bene, prima deve patire. Non si raggiunge un risultato senza aver prima sofferto.
Chi vôl cuntintèr tótt, an cuntàinta inción = Chi vuole accontentare tutti, non accontenta nessuno.
Chi vôl dèr fand a la bûrsa, faga fabrichèr = Chi vuole dare fondo alla borsa, faccia fabbricare.
Chi vôl fèr un birichén, fâga un ciarghén = Chi vuol fare un birichino, faccia un chierichetto.
Chi vôl imparèr quèl, al vâga dal pió vèc’ = Chi vuole imparare qualcosa, vada (si rivolga) dal più vecchio.
Chi vôl ôv, bisaggna ch’al téggna la galénna = Chi vuole uova, deve tenere le galline.
Chi vôl stèr san, péssa spass cmôd fa al can = Chi vuole stare sano, deve orinare spesso come fa il cane.
Chi vôl va, ch’n’vôl manda = Chi vuole va, chi non vuole, manda. Chi vuole una cosa a suo modo deve andare di persona.
Chi vôl va, ch’n’vôl rèsta a ca = Chi vuole va, chi non vuole resta a casa.
Chi zàirca acâta e chi dmanda impèra = Chi cerca trova e chi domanda impara.
tChi zâpa la véggna d’agast, al rimpéss la canténna ed mast = Chi zappa la vigna in agosto, riempie la cantina di mosto.
Ciacarè pûr, mó agl’én côren d’ôr = Chiacchierate pure, ma sono corna d’oro. Diceva il contadino a chi alludeva ad una tresca della moglie con il padrone.
Ciamèrs ed’cîsa = Lett: Chiamarsi di chiesa. Cioè tirarsi fuori da una questione. Il detto viene, forse, dall’immunità di cui godevano le chiese e i relativi sagrati. Quando un ricercato riusciva a mettere piede sul sagrato, diceva: Mé am ciâm ed’cîsa e gli altri non potevano più arrestarlo. La chiesa ed il sagrato non erano territorio italiano (e forse non lo sono neppure adesso).
Ciapèr al fôrt = Prendere il forte, cioè inacidire (del vino).
Ciapèr la gâta = Prendere la gatta (ubriacarsi). Oppure Ciapèr la sémmia = Prendere la scimmia.
Cinén e calcadén = Piccolo, ma piantagrane.
Ch’la pièsa, ch’la tèsa e ch’la stâga in chèsa = Che piaccia, che taccia e che stia in casa. Le doti di una buona moglie.
Cla dôna = Mia moglie.
C’la dôna la pèr un lât e un vén = Quella donna sembra un latte e un vino. Ha un colorito bianco e rosa.
C’la dôna, saimper la sdâza e mai la fa pan = Quella donna, setaccia sempre e non fa mai il pane. Di donna che sembra fare, ma che non conclude.
Cmandèr a bacàtta = Comandare a bacchetta.
Cócch, cócch da la panna bîsa, stra quant ân um’marîdia? = Cuculo, cuculo dalla penna grigia, fra quanti anni mi sposerò? Dal numero del “cucu”, le ragazze desumevano gli anni mancanti al matrimonio.
Cól tàimp a s’métt giudézzi = Col tempo si mette giudizio (si diventa saggi).
Con al tàimp e la pâja as madûra al nèspel = Col tempo e con la paglia maturano le nespole.
Con dal bôni bràjj as’guîda i cavâl, con la prudàinza l’ômen = Con delle buone briglie si guida il cavallo, con la prudenza l’uomo.
Con di garavlén as ‘fa di grâp = Con dei racemoli si fanno i grappoli. Con il soldo si fanno i milioni.
Con i bajûch e l’amizézzia, as’fa stèr anch la giustézzia = Con del denaro e con l’amicizia, si ferma anche la giustizia.
Con la malézzia e l’ingân, as pâsa mèz ân; con la malézzia e l’èrt as pâsa l’ètra pèrt = Con la malizia e l’inganno si passa metà dell’anno; con la malizia e l’arte si passa l’altra parte.
Con l’amaur, a i è l’amèr = Con l’amore, c’è l’amaro.
Con pió la s’armàsda, con pió la pózza = Più la si mescola, più puzza.
Córrer cmôd fa al ninén a la jânda = Correre come fa il maiale alla ghianda. Fare una cosa molto volentieri.
Córrer la cavalénna = Correre la cavallina. Fare vita dissoluta.
Côs da dîr satta a la fûga = Cose da dire sotto la cappa del camino. Sciocchezze, cose risibili.
Córrer drî al parpâi = Correre dietro alle farfalle. Fantasticare.
Crèpa l’avarézzia! I magnen un ôv in dsdôt e al tarrel i al dân al can! = Crepi l’avarizia! Mangiano un uovo in diciotto e il tuorlo lo danno al cane!
Crést l’ha distribuè dal craus: qui chi èren avanzè sàinza i l’én andè a zarchèr = Cristo ha distribuito le croci: chi è rimasto senza le è andato a cercare.
Crudeltè, cunsómma amaur = Crudeltà consuma amore.
Culaur d’un tâi d’navân = Colore di un taglio di navone. Colorito pallido, esangue.
Cûl nûd e budèl vsté ed vlûd = Sedere nudo e intestino foderato di velluto: cioè, cura più il mangiare che il vestire.
Cumprèr una côsa pr’un pèz ed pan = Comprare una cosa per un pezzo di pane. Pagare un’inezia.
Cuntàint me, cuntàint tótt = Contento io, contenti tutti.
Cuntèr cómm un pajâz in Paradîs = Contare come un pagliaccio in Paradiso. Non godere di considerazione alcuna.
Cuntèr da sfrâpel = Raccontare frottole.
Cuntèr cmôd un stamp da castagnâz = Essere considerato come uno stampo da castagnaccio, cioè poco.
Curiaus, n’asculté mai côsa ch’ai piaséss = Un curioso, non ascoltò mai una cosa di suo gradimento.
Cusénna nôva, chi n’in pôrta, a n’in trôva = Cucina nuova chi non ne porta (del cibo), non ne trova.
Custèr un ôc! = Costare un occhio, (costare molto). Oppure Custèr un ôc dla tèsta = Costare un occhio della testa.
Cuvèr i rustézz = Stare vicino al fuoco per godere del calore fino alla fine, fino a quando ci sono tizzoni (rustézz).
Da Cranvél a Pasqua, tótta l’érba fa armisdânza = Da Carnevale a Pasqua tutte le erbe fanno mescolanza. L’armisdânza era un’insalata di erbe spontanee miste che di solito veniva condita con sale, aceto e lardo. (Ora nei supermercati si trova la misticanza, assai più delicata e fine rispetto alle erbe di campo).
Dai a ch’al can = Dagli a quel cane.
Dai catîv custómm ai vén al bôni lazz = Dai cattivi costumi, nascono buone leggi.
Dai e dai, la zivalla la d’vàinta ai = Dai e dai la cipolla diventa aglio.
Da i ûc’ as’acgnóss l’ômen = Gli uomini si riconoscono dagli occhi.
Da la tèvla an’livèret mâi, se la bacca l’an sa d’furmâi = Non alzarti mai dalla tavola se la bocca non ha il sapore del formaggio.
Dai bèli zôch ai nâs al bèli bragguel = Dalle belle ceppaie nascono i bei virgulti.
Dal brótt zôch as’chèva al bèli bragguel = Dalle brutte ceppaie nascono i migliori virgulti.
Dal détt al fât a i é un gran trât = Dal detto al fatto c’è un grande tratto.
Dal dîr al fèr a i é un fôs da saltèr = Dal dire al fare c’è un fosso da saltare.
Dal dîr al fèr i’é d’mèz al mèr = Dal dire al fare, c’è in mezzo il mare.
Dal pôch, an’s’gôd = Del poco non si gode.
Dal pôch a s’in gôd, dal purasè a s’in fa nôz = Del poco se ne gode, del molto se ne fa nozze.
Dal scrân e di bichîr an’é mai purasè = Di sedie e di bicchieri non ve ne sono mai troppi..
Dal trést pagaduar bisaggna tôr d’incôssa = Dal cattivo pagatore bisogna prendere di tutto (quello che ti dà).
Dapp al nóvvel a’i vén al sràin = Dopo le nuvole, viene il sereno.
Dapp al tran, vén l’âqua o la timpèsta = Dopo il tuono, viene la pioggia o la grandine.
Dapp la guèra, vén la pès = Dopo la guerra, viene la pace.
Dapp Nadèl, tótt i dé l’é Cranvèl = Dopo Natale, tutti i giorni è Carnevale.
Da San Martén a Nadèl, tótt i puvrétt i stân mèl = Da San Martino a Natale, tutti i poveri stanno male. Per i poveri si intendono i braccianti che vivevano del lavoro a giornata; dopo San Martino (11 novembre) terminavano i lavori dei campi dai quali traevano il loro magro salario. Per la verità, stavano male anche dopo Natale.
Da Santa Catarénna a Nadèl, un màis uguèl = Da Santa Caterina (25 novembre) a Natale vi è un mese preciso.
D’avréll un canèl, ed mâz un tursèl = In aprile un cannello, in maggio un rotolo. Si riferisce allo stato di avanzamento della tessitura della canapa. In aprile un cannello, cioè una piccola quantità, in maggio un rotolo, cioè una quantità notevole. Al tursèl (plurale: tursî) era un rotolo di tela della lunghezza di qualche metro.
D’bèl tàimp e pan frasch inción é mai stóff = Di bel tempo e di pane fresco, nessuno è mai stanco.
D’bôna tèra tû la véggna, d’bôna mèder tû la fiôla = Di buona terra prendi la vigna, di buona madre prendi la figlia.
Dèr a intander lózzel par lantèren la n’é da galantômen = Dare da intendere lucciole per lanterne, non è da galantuomo.
Dèr (o Tôr) al bîsti a la mudnàisa = Dare o prendere il bestiame alla modenese, cioè a “Soccida”. La “Soccida” è un particolare contratto nel quale una delle parti conferisce il bestiame e l’altra la custodia e il mantenimento, dividendo gli utili. In bolognese la “Soccida” e detta Zvâdga.
Dèr al gnôch = Lett: dare il gnocco. Gesto di spregio che si fa ponendo una mano nell’incavo del gomito dell’altro braccio. (Il cosiddetto gesto dell’ombrello).
Dèr al pan-pan a ón = Dire a uno il fatto suo.
Dèr al saul = Dare il sole. Vale per picchiare.
Dèr al viôl = Donare le viole. Gesto simbolico col quale le ragazze di un tempo facevano capire al corteggiatore di averlo in simpatia. In caso contrario il dono era costituito da un mazzo di agli.
Dèr ciâcra = Dare parole, parlare. Quando una ragazza concedeva ad un corteggiatore di rivolgerle la parola.
Dèr dal lóster = Dare del lucido, adulare.
Dèr dal savàn = Dare del sapone, adulare
Dèrel indóvv a’s’nèsa i mlón = Darlo (metterlo) dove si annusano i meloni. Sodomizzare.
Dères za al massch con la cô = Allontanare le mosche con la propria coda. Essere capace di curare i propri affari senza l’auto di altri.
Dèr fûgh a la mâchina = Dare fuoco alla macchina, cioè dare inizio a qualche cosa.
Dèr i âi = dare gli agli. Un tempo le ragazze che intendevano rifiutare la corte di un giovanotto, gli donava un mazzo di agli. È il contrario di Dèr al viôl = Dare le viole.
Dèr i ànser = Ansimare. Modo scherzoso per chi ansima. Ànser = Marroni bolliti ed appassiti. Ansèr = Ansimare.
Dèr i dént sû = Storcere il muso, fare l’aria schifata.
Dèr in’t’al bisachén d’l’arloi = Dare nel taschino dell’orologio, significa buggerare una persona.
Dèr l’asiôl a ón = Cacciare in malo modo una persona . L’asiôl è un orbettino, una piccola biscia.
Dèr par d’fôra = Uscire dai gangheri.
D’furmàint marzulén, al sâch an’vén pén = Il grano marzuolo (seminato in primavera) non riempie il sacco.
Dimóndi fómm pôch arôst = Molto fumo, poco arrosto.
Din, dón, din dón: la guèra i la fân i cuntadén e i quajón = Din, don, din don: la guerra la fanno i contadini e i minchioni. I contadini hanno pagato il maggior contributo alle guerre d’Italia. Era difficile entrare in una casa colonica senza vedere alla parete l’ingrandimento della fotografia del padre, dello zio, del fratello morto in guerra.
Dio a i fa, pô a i acumpâgna = Dio li fa, poi li accompagna.
Dio al dîs: aiûtet, ch’a t’aiutaró = Dio dice: aiutati che ti aiuterò.
Dio an’pèga tótt i sâbet = Dio non paga tutti i sabati.
Dio vadd, Dio pruvadd = Dio vede. Dio provvede.
Dîr a fiôla parchè l’intanda nôra = Dire a figlia perché nuora intenda.
Dîs Dan Dundén, che tótt i dé, Dio dà di dón = Dice Don Dondini che tutti i giorni Dio reca doni. (Scioglilingua)
Divîder a bacca (o “partîr a bacca”) = Dividere a bocca (o spartire a bocca). Nelle divisioni delle famiglie coloniche alcuni cespiti venivano divisi per persone calcolandosi “bacca intîra (Bocca intera) ogni persona di 24 anni compiuti, nulla per chi aveva meno di 12 anni e 1/12° di “bocca” per ogni anno dai 12 ai 24 anni.
Divîder a stîrpa = Dividere a stirpe. Nelle divisioni delle famiglie coloniche, il capitale, esclusi i generi “da bocca”, veniva diviso per stirpi, intendendosi per stirpe quel gruppo di componenti della famiglia che avevano un capostipite vivente in comune.
Dl’Albanàn, a in tacca pôch al padràn = Dell’Albanone, ne tocca poco al padrone. La varietà di Albana detta “Albanone”, perché molto primaticcia, veniva mangiata fresca dai contadini e dagli uccelli e, quindi, al concedente ne toccava poca.
Dmandand a s’va a Ramma = Chiedendo si va a Roma.
Dmandèr a l’ôst s’l’ha dal ban vén = Chiedere all’oste se ha del buon vino. Fare una cosa che prevede una risposta ovvia.
Dnânz da un móll, drî da un stiôp, luntan da un mât = Davanti a un mulo, dietro a un fucile, lontano da un matto.
Dôna cénna la pèr una pulsénna = Donna piccola, sembra una pulcina. La donna piccola di statura sembra sempre giovane.
Dôna ch’zîga, ômen ch’zûra e cavâl ch’sûda, an i cradder = Non credere a donna che piange, a uomo che giura e a cavallo che suda.
Dôna col nès insó, ónna par ca e pó pió = Donna col naso all’insù, una per casa e poi più.
Dôna dai gran caprézzi, dôna sàinza giudézzi = Donna dai grandi capricci, donna senza giudizio.
Dôn, cavâl, sumâr, condûsi col stangatt = Donne, cavalli e asini, guidali col bastone.
Dôna da tatta, zâpa da biatta e vâca da vidèl, int’al camp an’i purtèr = Donna che allatta, zappa smanicata e vacca che ha partorito, non portarle nel campo.
Dôna ed’bôna raza, la fa prémma la ragâza = Donna di buona razza partorisce prima la femmina. Era credenza assai diffusa. Altro proverbio dice : In ca’ dal galantômen, prémma la dôna e pó l’ômen = In casa del galantuomo, (nasce) prima la donna e poi l’uomo.
Dôna e lónna, incû, sràin, edman brónna = Donna e luna, oggi sereno, domani nuvoloso.
Dôna in trazza, cavâl in cavazza = Per ben figurare la donna deve avere la treccia ed i cavalli la capezza.
Dôna mégra, pigra e ôca, quand t’in cât, tûn sàimper pôca = Donna magra, pecora e oca, quando ne trovi, prendine poca (Altri tempi ed altri gusti).
Dôna nèna, tótta tèna = Donna nana, tutta tana.
Dôn, cavâl e bîsti: tèsta cénna! = Donne, cavalli e bovini: testa piccola.
Dôn e bû, tûi dai avsén tû = Donne e buoi, prendili solo dai tuoi vicini. Prendi moglie e compra bovini solo da chi conosci.
Dôn e dân, l’è tótt un malân = Donne e danno, è tutto un malanno.
Dôn e guai, in mànchen mai = Donne e guai, non mancano mai.
Dôn e turtî, s’in én bón, in én bî = Donne e tortellini, se non sono buoni, non sono belli.
Dôn, zói e tàila an guardèri a lómm ed candàila = Donne, gioielli e tela, non guardarli a luce di candela.
Dóvv a i é innuzàinza, ai é pruvidàinza = Dove c’è innocenza, c’è provvidenza.
Dóvv as’mâgna, an s’ragâgna = Dove si mangia, non si fa lite.
Drî al catîv a i vén al ban = Dopo il cattivo, viene il buono.
Drî a l’èlta, a i é la bâsa = Dopo la salita, comincia la discesa.
Dscarrer cmôd ón ch’al gira int’al paciûg = Parlare come uno che cammina nel fango. Esprimersi male, in modo impacciato.
Dscarrer cmôd una mnénna cla péssa int l’aqua = Parlare come una gattina che faccia la pipì nell’acqua. Di donna che parla con una voce flebile.
Dscarrer cmôd un mâz ed sûlfen = Parlare come un mazzo di zolfanelli. Parlare a vanvera.
Dscarrer in pónta ed’furzénna = Parlare in punta di forchetta. Parlare forbito.
Dscàrret o chèghet? = Parli o caghi? Lo si dice a chi parla a vanvera, in modo non coerente.
Dscarrer parché a s’ha la langua in bacca = Parlare perché si ha la lingua in bocca. Parlare senza riflettere, a vavera.
Dscuràn ed chi èter, s’a vlàn redder = Parliamo degli altri, se vogliamo ridere. È più facile ridere degli altri che di noi stessi.
Dscurdghèr un pdôc par vander la pèl = Scorticare un pidocchio per venderne la pelle. Essere molto avaro.
Dscrûver la quâia = Scoprire la quaglia. (scoprire l’inganno). Vale per Magnèr la fójja = Mangiare la foglia (scoprire l’inganno).
Dsfèr al baladûr = Lett.: Distruggere il locale da ballo. Fare piazza pulita
Dunén è môrt al sbdèl e Dunè sta mèl = Donino è morto all’ospedale e Donato sta male. Gioco di parole per rispondere negativamente ad una richiesta di denaro.
Dunén, stiuptén e cavalén: totta rôba da pôch quatrén = Donnine, fucilini e cavallini: tutta roba da pochi quattrini.
Dûr con dûr, a’n’fé mai ban mûr = Duro con duro, non fecero mai buon muro. Due caratteri forti, messi insieme, non possono combinare nulla di buono.
Duréss tant la mèla’vsénna, quant dûra la nàiv marzulénna = Durasse tanto la cattiva vicina, quanto dura la neve di marzo.
Durmîr co’i ànzel = Dormire con gli angeli. Lo si diceva dei bambini piccoli quando sorridevano nel sonno.
Durmîr cumpâgn a un zôch = Dormire come un ciocco: dormire profondamente.
Dutaur piètaus, fa la pièga verminausa = Il medico pietoso, fa la piaga coi vermi (puzzolente).
E brîsa ban ed balèr = E non capace di ballare. Considerata la grande importanza che aveva il ballo per i contadini, era questa l’offesa più sanguinosa che si poteva rivolgere ad un giovane.
Ed bèl tàimp e d’pan frasch inción é stóff = Di bel tempo e di pane fresco, nessuno e mai stanco.
Ed mèrz, al cuntadén al va schèlz = In marzo il contadino va scalzo. I contadini usavano togliere le scarpe per il giorno di San Giuseppe (19 marzo) e rimetterle, poi, il giorno di Santa Caterina di Alessandria (25 novembre), o prima, se la stagione era sfavorevole.
Ed mèrz tóta l’êrba l’é insalè = In marzo tutta l’erba è insalata (commestibile). Si faceva, allora, la famosa “armisdânza” di erbe condite con sale, aceto e lardo fuso.
Èlia d’pulaster, côsa d’capan, spâla d’castran = Ala di pollo, coscia di cappone, spalla di castrato (I bocconi migliori).
Èlta o bâsa la vén la Pasqua = Alta o bassa, la Pasqua viene.
Èl vgnó a ca Piran da la fójja? = E’ tornato a casa Pierone dalla foglia? Fèr la fójja era l’operazione agricola di raccolta delle foglie di gelso per i bachi da seta e di olmo per il bestiame. La frase veniva usta quando qualcuno dopo essersi assentato per un permale, tornava in compagnia facendo finta di niente.
E ón, gèva quall ch’al castrèva = E uno diceva quello che castrava. Frase scherzosa che veniva pronunciata all’inizio della “conta”.
E qui dla cónna = E quelli della culla. Si dice a chi dichiara un’età manifestamente inferiore a quella reale.
Êrba crass e cavâl aspèta = Campa cavallo che l’era cresce.
Èser a l’ôca = Essere all’oscuro di un argomento di cui si parla.
Èser al sparglén dl’âqua santa = Il “sparglén” è quella piccola sfera metallica col manico di cui si servono i preti per benedire i fedeli. Nei modi di dire delle nostre campagne “al sparglén dl’âqua santa” è persona che vuole apparire buona e devota senza esserlo.
Èser ardótt cón al pèz in’t’al cûl = Essere ridotti con le pezze nel sedere (pantaloni rattoppati) vuol dire essere alla miseria.
Èser a spâs = Essere senza lavoro.
Èser ban da cûl e da pônta = Essere buono (capace) ad ogni gioco, ad ogni cosa.
Èser cómm un stamp da castagnâz = Essere come uno stampo da castagnaccio, vuol dire essere quasi inutile; essere tenuto in scarsa considerazione. Uno stampo da castagnaccio ha poco valore.
Èser culaur d’scurazza ed tôca= Letteralmente: Essere colore di una scoreggia di tacchino. Di persona molto pallida e certamente un colore indefinibile.
Èser cûl e camîsa = Essere culo e camicia, essere in grande amicizia. Lo stesso per :
Èser cûl e patâja. La patâja è la parte della camicia da uomo che si mette sotto i pantaloni ed è quindi anche più vicina al sedere.
Èser d’bacca bôna = Essere di bocca buona, accontentarsi facilmente.
Èser d’bâla = Essere d’accordo.
Èser da ôv e da lât = Essere da uova e da latte. Il modo di dire derivava dal commercio delle aringhe che potevano essere femmine con una massa di uova in formazione e maschi con sacca spermatica (latte). Il bottegaio usava chiedere al cliente quale preferiva. Se il cliente era indifferente rispondeva: Mé a san da ôv e da lât. Il detto è divenuto proverbiale per significare disponibilità ad ogni decisione.
Èser dsgraziè cómm “Dan Dindalla” ch’al sunèva Massa cón un capp = Prete miserrimo che, per chiamare i fedeli alla Messa, era costretto a battere il bastone su una tegola.
Èser ed’lónna = Essere in vena.
Èser ed picâja tandra = Essere facile alla commozione.
Èser ed ‘sèt côt e una buîda = Essere di sette cotte e di una bollita: essere adatto ad ogni cosa.
Èser furtunè cómm un can in cîsa = Essere fortunato come un cane in chiesa. I cani in chiesa non ricevevano un buon trattamento, venivano cacciati (forse anche adesso).
Èser furtunè cómm un buvinèl = Essere fortunati come un imbuto. Perché un imbuto deve essere fortunato? Forse perché beve vino? Quando uno aveva un colpo di fortuna, gli si diceva: Buvinèl (Imbuto).
Èser in bóst ed’ mândg = Essere senza giacca, con la sola camicia. Lett.: essere in busto di manica.
Èser in brègh ed tàila = Essere in braghe di tela. Essere in condizioni di indigenza.
Èser in chéccra = Essere in chicchera. Essere vestito elegantemente.
Èser in dû can a pluchèr un ôs = Lett.: Essere in due cani a piluccare un osso. Essere in due a contendersi la stessa cosa.
Èser int’la mérda insénn ai ôc’ = Essere nella merda fino agli occhi. Essere proprio nei guai.
Èser intrighè cumpâgn un pipién int’la stappa = Essere impacciato come un pulcino nella stoppa. Le massaie usavano porre i pulcini appena nati in un cestino contenente della stoppa di canapa (simulando un nido), dove i pulcini si muovevano con impaccio.
Èser la rôca e al fûs = Essere la rocca e il fuso. Di due persone che sono in grande amicizia e si fanno vedere sempre insieme. Anche di una coppia fatta di un uomo alto e di una donna piccola.
Èser l’istassa farénna = Essere la stessa farina. Essere della stessa razza.
Èser lóngh cómm al dé d’la fâm = Essere lungo (lento) come il giorno della fame. Di persona molto lenta.
Èser lóngh cómm la mèsna ed’satta = Essere lungo (lento) come la macina di sotto. Nei vecchi mulini a palmenti, la macina inferiore girava in senso inverso a quella superiore e molto lentamente.
Èser l’ûltma rôda dal câr = Essere l’ultima ruota del carro. Non avere alcun potere o godere di poca reputazione.
Èser nèd con la camîsa dla Madôna = Essere nati con la camicia della Madonna = Essere fortunati.
Èser nèd la nôt dal squassadén = Essere nati nella notte di breve e poca pioggia. Di persona sciocca, sprovveduta.
Èser nèd la nôt di nuvantanôv mamalócch = Essere nati la notte dei novantanove mammalucchi. Essere stupido.
Èser pén ed bdûc’ e in man a i avuchèt = Essere pieni di pidocchi e in mano agli avvocati. Peggio di così!
Èser pèra con tótt = Essere pari con tutti. Non avere debiti.
Èser pió vec’ dal cócch = Essere più vecchio del cuculo. Il cuculo godeva fama di grande longevità.
Èser pîz d’na gâta surièna = Essere peggio di una gatta soriana. Di ragazza facile ad innamorarsi.
Èsers magnè insèn a l’ûltum pan = Essersi mangiato insieme all’ultimo pane. Aver consumato tutto il patrimonio.
Èser tacch int’al “nomine patris” = Essere tocco nel “nomine patris” (la fronte). Non avere la testa a posto.
Èser un “fia mia” = Essere una “figlia mia”. Espressione forse di origine veneta: vale per essere astutissimo, difficile da imbrogliare.
Èser un fîgh da la gazza = Essere in fico dalla goccia. Essere molto furbo.
Èsri dal nuvité = Ci sono novità. Essere incinta.
Èt magnè al mél? Chèga la brasca = Hai mangiato il miele? Defeca il favo.
Èt magnè la candàila? Chèga al stupén = Hai mangiato la candela? Fai lo stoppino.
Èt vindó la langua al pchèr? = Hai venduto la lingua al macellaio? Si chiedeva a chi, stando in compagnia, non apriva mai bocca.
Fa dal bàin al vilàn: at spûda in man = Fai del bene ad un villano: ti sputa in mano. I contadini non sono riconoscenti.
Fammnèla dl’anzinél = Anellino dove entra l’uncino per affibbiare gli abiti.
Fâm fataur un an, sa staró mel, mi dân = Fammi fattore un anno, se starò male, mio danno.
Fa quall ch’a déggh e brîsa quall ch’a fâgh = Fa quello che dico e non quello che faccio.
Fataur nôv, ban trî dé = Fattore nuovo, buono per tre giorni.
Fat bôna nomina e péssa a lèt: i diràn t’è sudè = Fatti una buona nomina e piscia a letto: diranno che hai sudato.
Febrèr cûrt, mó catîv cómm un tûrch = Febbraio corto, ma cattivo come un turco.
Febrèr cûrt, mó pîz ed tótt= Febbraio corto, ma peggio di tutti.
Febrèr cûrt e maladàtt = Febbraio corto e maledetto.
Febrèr giazè, mèrz arscaldè = Febbraio ghiacciato, marzo caldo. Previsione di primavera.
Felîz quall ch’n’ha parént = Felice colui che non ha parenti.
Fèls cmôd una bajôca dal côl lóngh = Falso come una baiocca dal collo lungo. Dopo l’Unità d’Italia, vennero coniate monete da 10 centesimi note come Bajôca. Ne vennero fatte delle false che, ad un occhio attento, si distinguevano perché il collo di Vittorio Emanuele II era, nelle false, alquanto più lungo.
Fén ch’a ‘i é fiè a i é vétta = Finché c’è fiato, c’è vita.
Fén ch’a i é vétta a i é speranza = Finché c’è vita c’è speranza.
Fèr agl’ôsa = Fare le ossa. Vale per poltrire, dormire a lungo, avere poca voglia di lavorare.
Fèr al bâl dal piantàn = Fare il ballo del piantone: abbandonare il moroso, o la morosa, all’improvviso.
Fèr al bâl dal sgamber = Fare il ballo dello sgombero: fare piazza pulita, risolvere in modo brusco una situazione.
Fèr al cariôl = Lett.: fare il cariolo. Del giovane che, uscendo da messa o da vespro, si affiancava alla ragazza desiderata fino alla casa di lei, senza osare di rivolgerle la parola. Dopo qualche volta, se la ragazza intendeva accogliere il corteggiamento, gli rivolgeva la parola (Dèr ciâcra).
Fèr al côs a musgût = Fare le cose a morsi, fare lo cose a stento, poco alla volta.
Fèr al dièvel a quâtr = Farel il diavolo a quattro.
Fèr al faléster = Fare scintille.
Fèr al gnôch = Gesto offensivo e scurrile che si fa mettendo la mano nell’incavo dell’altro braccio piegato. Quello che oggi viene chiamato il gesto dell’ombrello.
Fèr bacca da rédder = Fare bocca da ridere. Il sorridere dei bambini.
Fèr blén-blén = Fare bello-bello. Accarezzare, cercare di compiacere uno.
Fèr buchènna = Fare boccuccia: smorfia.
Fèr caruzén = Fare carrozzino: essere vicini a morire. Si diceva, in particolare, dei polli e dei volatili.
Fèr cialla = Fare cilecca. Il mancare dell’uomo nell’atto sessuale.
Fèr cmôd i lèder d’Pîsa, che ed’dé i litighen e pó ed nôt i van a rubèr insamm = Fare come i ladri di Pisa, che di giorno litigano e di notte vanno a rubare insieme.
Fèr crèst = Fare cilecca. Di fucile ed altro.
Fèr dal natt = Fare piazza pulita.
Fèr da savairén = Fare il saputello.
Fèr da zâgn e buratén = Fare da ruffiano e da burattino. Fare due parti. Prestarsi ad ogni richiesta.
Fèr dèr indrÎ al lât = Quando le donne, per svezzare il poppante si adoperano perché le loro mammelle non diano più latte.
Fèr di arôsti = Fare degli arrosti, cioè fare imbrogli. Fare la “cresta” sulla spesa.
Fèr di dsnómm = Fare delle moine.
Fèr di mutâz = Fare dei musi. Fare degli sberleffi.
Fèr di ragiunamént che n’arîven gnanch a l’âsa dal pan = Fare ragionamenti che non arrivano neppure all’asse del pane. Fare gli schiocchi. L’asse del pane era sul muro in cucina, sostenuta da due pioli di legno murati all’altezza, circa, di un uomo. Era coperta da carta oleata con un bordino ritagliato ed il pane veniva ricoperto con un burâz (canovaccio) di bucato.
Fèr dirindénna = Essere malfermo sulle gambe.
Fèr di sdûz = Abortire volontariamente.
Fèr e dsfèr, l’é tótt un lavurèr = Fare e disfare è tutto un lavorare.
Fèr economî col cucîèr, e trèr vi la mascla = Fare economia col cucchiaio e buttare col mestolo. Badare alle piccole economie e non curarsi delle grandi.
Fèr gabanèla = Riposo pomeridiano, spesso all’aperto.
Fères tôr in cîsa = Farsi prendere in chiesa. Cerimonia cui doveva sottoporsi la puerpera per rientrare a far parte della comunione dei fedeli. La donna si presentava al sagrato della chiesa ed attendeva in ginocchio che il Parroco le porgesse una candela accesa e l’accompagnasse all’altare ove le veniva impartita l’assoluzione. Dopo di ciò poteva frequentare di nuovo la Messa e riprendere i rapporti sessuali col marito. Ciò non poteva avvenire prima della ricomparsa del flusso mestruale. Per evitare inganni, il Concilio di Elvira del 305, aveva stabilito che la moratoria fosse, in ogni caso, di 33 giorni se il nato era un maschio e di 56 se femmina.
Fèr fâs e fassulén = Fare di ogni erba un fascio.
Fèr i bî ucén = Fare occhi belli. Corteggiare.
Fèr i gatén = Vomitare.
Fèr i pî ai muscén = Fare i piedi ai moscerini. Avere grandi abilità nel lavoro.
Fèr i pî róss = Fare i piedi rossi. Rimanere nubile.
Fèr i ûc’ dal purzèl = Fare gli occhi del porcello: guardare di malocchio.
Fèr la gazatta = Atto di spregio che si fa spingendo con un dito il naso verso l’alto.
Fèr la mascla = Fare il mestolo. Il caratteristico atteggiamento del viso dei bambini quando stanno per scoppiare in pianto.
Fèr la môrt di ànzel = Fare la morte dell’angelo. Morire durante un amplesso sessuale.
Fèr l’amstîr ed Miclâz: magnèr, bavver e andèr a spâs = Fare il mestiere di Michelaccio: mangiare, bere e andare a spasso.
Fèr la pîga al lèt = Rimboccare le lenzuola.
Fèr la sóppa int’al panîr = Fare la zuppa nel paniere: fare una cosa che non può riuscire.
Fèr l’ésen e al bôja = Fare l’asino e il boia per accontentare qualcuno. Anticamente l’asino trainava il carretto che portava il condannato al luogo del supplizio e il boia faceva il resto. Vale per fare due mestieri; prestarsi ad ogni richiesta.
Fèr l’imbezél pr’an paghèr al dâzi = Fare l’imbecille per non pagare il dazio. Fare lo gnorri. Fingersi stupido.
Fèr l’interès ed’Cazatt: brusèr la laggna par fèr la zander = Fare gli interessi di Cazzetti: bruciare la legna per fare le cenere.
Fèr lómm = Portare il lume; favorire una tresca.
Fèr agl’i ôs in quèl = Abituarsi a una cosa.
Fèr l’uciàtt = Fare l’occhiolino.
Fèr pàir = Fare pero. Dei bambini quando muovevano i primi passi. Gli adulti li invitavano dicendo: Fa pàir = Fa pero.
Fèr pérder al murbén a ón = Fare mettere la testa a posto.
Fèr starlénna = Passare la notte in bianco.
Fèr stèr ón = Ingannare una persona.
Fèr una côsa in fugatón = Fare una cosa alla carlona, tirata via.
Fèr un fât e dû servézzi = Fare un fatto e due servizi, prendere due piccioni con una fava.
Fèr un gran slavâc = Fare grande sciupio.
Fèrs’ gôder = Farsi ridere dietro.
Fèr squézz = Il mancare dell’uomo nell’atto sessuale.
Fèr só quelcdòn = Imbrogliare una persona.
Fèr stèr a padran = Lett: Fare stare a padrone. Tenere sottoposti i dipendenti.
Fèr un minuàtt int’al spâl a ón = Fare un minuetto sulle spalle di una persona. Il modo di dire risale a quando, dopo l’unità, come condanna capitale era in uso l’impiccagione. Il boia saliva sulla forca ed appoggiava i piedi sulle spalle del condannato, premendo con forza. A sua volta l’assistente (Al tirapî = il tirapiedi) afferrava il disgraziato per i piedi e tirava forte.
Fèr un quèl in camôffa = Fare una cosa di nascosto.
Fèr vgnîr un quèl par sfurzén = Forzare la verità per dimostrare o ottenere una cosa.
Fèr zèrla = Andare ad aiutare altra famiglia di contadini nei lavori agricoli. La Zèrla era un trave ferrato alle estremità che serviva per aggiungere un paio di buoi o vacche alle bestie che trainavano l’aratro. Difficilmente una famiglia possedeva il numero di capi necessari per arare (10, 12 e anche 14). Usava, quindi, che i contadini si aiutassero tra loro col rispettivo bestiame.
Fèva e fasû, ognón bèda ai fât sû = Fava e fagioli, ciascuno bada ai fatti suoi.
Fidèrs ed tótt e an’s’ fidèr d’inción = Fidarsi di tutti e non fidarsi di nessuno.
Fidèrs l’é bain, an’s’fidèr l’é méi = Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
Fiubèrs al schèrp = Allacciarsi le scarpe = fare molta attenzione a ciò che avviene.
Fiû cén, mèl al zócch; fiû grand, mèl al côr = Figli piccoli, male di testa; figli grandi, male al cuore.
Fiû cinén, guâi cinén; fiû grand, guâi grand = Figli piccoli, guai piccoli; figli grandi, guai grandi.
Fôra chi can = Fuori quei cani. Lo gridava il prete che si era accorto della presenza di alcuni cani durante la Messa. Checcone (Chican) un povero sciocco credette che l’invito fosse rivolto a lui ed uscì.
Fôra mèrz, ch’al vén avréll = Fuori marzo che viene aprile. Ma Mèrz vuol dire “marzo” oppure “marcio”. Lo si diceva a chi tossiva con molto catarro.
Fôra vàird = Sempreverde (bosso). Gioco degli adolescenti. Per Quaresima due ragazzi, spesso di sesso diverso, raccoglievano un ramoscello di sempreverde (in genere bosso). Quando si incontravano, uno dei due gridava: Fôra vàird, esibendo la sua parte di ramoscello, l’altro rispondeva: Métt fôra al tô, che al mî l’é vàird (Metti fuori il tuo, che il mio è ancora verde). Se uno dei due ne era privo, se di sesso diverso, un casto bacio, presagio di futuri baci più consistenti.
Frâch ed bôt; Frâch ed bastunè = Carico di botte.
Fradî, curtî; Surèl, quadrèl = Fratelli, coltelli; sorelle, quadrelli (forse bastoni di sezione quadrangolare).
Fra nôra e madôna, an’cûrs mai parôla bôna = Fra nuora e suocera non vi furono mai parole gentili. Nelle nostre campagne chiamavano Nôra e madôna le viole del pensiero perché, proprio come suocera e nuora, tali fiori non si guardano mai in faccia.
Frant spaziè, nès livè, in ca’ mî t’an vgnarè = Fronte spaziosa, naso all’insù, in casa mia non verrai. Secondo le credenze popolari la fronte spaziosa e il naso all’insù erano segno di carattere bisbetico.
Frarîs mâgna zócca = Ferraresi mangia zucca, dicevano i bolognesi ai ferraresi e i ferraresi rispondevano: Bulgnîs magna gûssa = Bolognesi mangia buccia.
Frézzer int’al sô grâs = Friggere nel proprio grasso.
Ftéss una cuntadénna, la pèr una regénna = Vesti una contadina, sembra una regina. L’abito fa il monaco. Si diceva anche: Ftéss un pèl, ch’al pèr un Cfardinèl = Vesti un palo, sembra un Cardinale.
Fûgh ch’al rûga, furastir par strè = Quando il fuoco brontola è in arrivo qualche forestiero.
Galén e ragazû, inspôrche la ca’ = Galline e bambini sporcano la casa. Le galline lordano, i bambini parlano a sproposito davanti ad estranei.
Galénna ch’va par cà, s’lan bèca, la bcarà = Gallina che gira per casa, se non becca, beccherà.
Galénna vècia fa ban brôd = Gallina vecchia fa buon brodo. Detta di donna non più giovane, ma ancora attraente.
Garôfel a zéing dida = Garofano a cinque dita, ovvero schiaffo.
Gât e león, fôra dai quaión = Gatti e leoni fuori dai coglioni (dai piedi). Scatto d’ira della reggitrice quando si trovava i gatti tra i piedi.
Ghèbia avèrta, usèl môrt = Gabbia aperta, uccello morto.
Gesó Crést, padran dla laggna, al mûrs dal fradd = Gesù Cristo, padrone della legna, morì dal freddo. Il detto non ha alcun riferimento preciso con Nostro Signore. Viene usato per dire che possono succedere le cose più impensabili, che anche chi è ricco, può trovarsi in difficoltà.
Gnént é diffézil a chi vôl = Nulla è difficile a chi vuole.
Gnént fa bàin pr’i ûc’ = Per i mali agli occhi non ci vogliono medicine.
Gnûch e carsàint, i mànden la famàjja in stàint = Grocchi e crescenti, mandano la famiglia in stento (erano considerati, un tempo, cibi che solo i ricchi potevano permettersi).
Granè nôva bàin spâza: la vècia la râza = Scopa nuova spazza bene; la vecchia raspa.
Grand e grȏs e pistulán = Grande e grosso e sciocco.
Gratèr la panza a la zighéla = Grattare la pancia alla cicala. Fare una cosa inutile.
Gratèr la raggna a ón, anch’s’al n’ha scadaur = Grattare la scabbia ad uno anche se non ha prurito. Volere rendersi gradito a tutti i costi. Fare un piacere non richiesto.
Grèna par grèna a s’rimpéss al stèr = Chicco dopo chicco si riempie lo staio. Lo staio era un’antica misura bolognese pari a mezza Corba, cioè a litri 39,3224. Considerato un peso specifico del grano di kg 75 per ettolitro, uno staio di grano pesava circa kg 29,500.
Guadagnèrs al pan con al sau brâza = Guadagnarsi il pane con le proprie braccia (col proprio lavoro).
Guarnèr al bîsti = Governare il bestiame: ripulire la lettiera e somministrare il foraggio. L’operazione veniva fatta almeno due volte al giorno.
Guâi al maré, ch’da brègh a la mujèr = Guai al marito che dà i calzoni alla moglie.
Guérda che blazza: un sumâr sàinza cavazza = Guarda che bellezza: un somaro senza la briglia (alla vista di persone di poco merito).
Guérdet da chi é sgnè da Dio = Guardati da chi è sagnato da Dio. Si riteneva, con poca carità cristiana, che le malformazioni fossero un avvertimento della natura malvagia.
Guèrdet da dau côs: ôst nôv e vén spinè = Guardati da due cose: oste nuovo e vino appena spillato.
Guèrdet dagl’impruméss dal dôn, da la cunsénzia di prît, dai guazabói di spzièl, e dai “cétera” di nudèr = Guardati dalle promesse delle donne, dalla coscienza dei preti, dagli intrugli dei farmacisti e dagli “eccetera” dei notai.
Guèrdet dal gât, quand al nèsa la spartûra = Fai attenzione al gatto quando annusa la madia.
Guèrdet dai magnasant a dai chegadièvel = Guardati dai mangiasanti e dai cacadiavoli.
Guèrdet da un ban znér = Guardati da un buon gennaio. È in contrasto con Znèr pulvrèr, rimpéss al granèr = Gennaio polveroso, riempie il granaio.
Guèrdet da un gôb, da un zôp e da un guêrz = Guardati da un gobbo, da uno zoppo (storpio) e da un guercio. Si credeva che il Signore desse un segno di riconoscimento agli uomini malvagi.
Guida al sumâr indóvv al vôl al padran: s’al s’accappa, sû dan = Conduci l’asino dove vuole il padrone: se muore, suo il danno.
I afèri luntan i n’an mai dè né vén né pan = Gli affari lontani non hanno mai dato né vino né pane. Esortazione ai figli perché non abbandonino la famiglia per cercare fortuna lontano.
I bajûch én cumpâgn ai guâi: chi i ha a si tén: I baiocchi (denari) sono come i guai: chi li ha se li tiene.
I bajûch satta al pajan i én magnè dai pôndgh = I baiocchi (soldi) sotto il materasso (pajan = pagliericcio, sacco imbottito di foglie di granturco) vengono divorati dai topi.
I bigât i én n’intrèda da quaión = I bigatti sono un’entrata (affare) da minchioni. Bigât = Baco da seta. L’allevamento esigeva molta manodopera con un reddito modesto, che, tuttavia, era comodo perché era la prima rendita dell’anno e veniva in primavera, quando la famiglia era sulla spesa. Quando si incontrava un contadino vestito a nuovo gli si chiedeva: Et vindó la sàida? = Hai venduto la seta?
I âlber i pôlen crasser dimóndi, mó in’arîven mai in zîl = Gli alberi possono crescere molto, ma non arrivano mai in cielo. Saggio proverbio.
I bû a la buarî, e me cà mî= I buoi alla boaria ed io a casa mia.
I Bulgnîs i én lûv, bécch e curiûs = I Bolognesi (cittadini) sono ghiotti, cornuti e curiosi.
I can e i vilàn, in’séren mai l’óss col man = I cani e i villani, non chiudono mai la porta con le mani.
I cazadûr, indóvv i n’arîven con la balénna, i arîven col bâl = I cacciatori dove non arrivano con il piombo (pallini), arrivano con le bugie.
I dèbit i crassen cómm la gramaggna = I debiti crescono come la gramigna.
I dît Giólia con chi bâfi? = La chiami Giulia con quei baffi? Il marito doveva assentarsi per qualche giorno, la moglie gli chiese se poteva prendere a dormire con sé l’amica Giulia per non rimanere da sola. Rientrando anticipatamente, lo sposo ebbe la sorpresa di vedere sporgere dai lenzuoli una testa baffuta.
I fât l’én mâsti e al ciâcher én fammen = I fatti sono maschi e le chiacchiere femmine. Vecchio maschilismo.
I én sàimper i strâz, chi van a l’âria = Sono sempre gli stracci a volare (sono sempre i poveri a rimetterci).
I fiû di gât i’ciàpn’i póndgh = I figli dei gatti, catturano i topi.
I gât i zîghen dal góst = I gatti piangono dal piacere. Anche di persone che si lamentano senza motivo.
I marón di can e i bajûch di puvrétt i’én sàimper in mastra = I testicoli dei cani ed i soldi dei poveri sono sempre visibili a tutti.
I mât e i ragazû, al zîl i ajûta = Il cielo aiuta i matti e i bambini (cioè coloro che più ne hanno bisogno).
I mât i fân rédder tótt, fôra che qui ed ca’ = I matti fanno ridere tutti, tranne quelli di casa (i famigliari). Molto triste.
I Mûrt = I Morti. Commemorazione dei defunti (2 Novembre). Il culto dei morti era molto sentito dalle popolazioni contadine. Le donne, ed anche molti uomini, si recavano al Cimitero ove mettevano in ordine le tombe e portavano fiori. Le donne erano ostili ai cambi di podere che comportassero un allontanamento dal Cimitero perché, con i mezzi di trasporto di un tempo, ciò rendeva più difficile compiere visite ai defunti.
I Mudnîs i han al cûl zâl = I Modenesi hanno il culo giallo. Trae origine dal fatto che l’antica razza bovina modenese aveva le mucose di colore giallognolo a differenza di quella bolognese che le aveva nere.
Impèra l’èrt e méttla da pèrt = Impara l’arte e mettila da parte.
Impruméss e dzón, cumpanâdg da quaión = Promesse e digiuni sono il companatico degli sciocchi.
I mûrt in tèra, i vîv a la scudèla = I morti in terra, i vivi a la scodella (chi muore giace, chi vive si dà pace).
I póndgh dal spzièl i plócchen i bilén par d’fóra dal vès = I topi del farmacista leccano le caramelle fuori dal vaso.
I prît i i frè ed caritè i én prîv, i prèghen i môrt par freghèr i vîv = I preti e i frati di carità sono privi, pregano i morti per fregare i vivi.
In ca’ dal galantômen, prémma la dôna e po’ l’ômen = In casa del galantuomo, prima la donna e poi l’uomo. Era credenza diffusa. Vedi: La dôna d’bóna râza, la fa prémma la ragâza = La donna di buona razza, prima fa la ragazza.
Incû a s’é fât ôvra: avàin fât al pan, avàin mazè al ninén e avàin suplé al nôn = Oggi si è lavorato: abbiamo fatto il pane, abbiamo ucciso il maiale e abbiamo sepolto il nonno (diceva soddisfatto il reggitore).
Indóvv a i é chèld, vèn adaquè; indóvv a i é fradd, vèn stièt = Dove c’è caldo, vino allungato (con acqua); dove c’è freddo, vino schietto. Può valere anche con riferimento all’età: vino allungato per i giovani, vino schietto per i vecchi.
Indóvv a i é dal dôn e dagl’ôch, l’armaur al’n’é mai pôch = Dove ci sono donne e oche, il rumore non è mai poco.
Indóv al dièvel an’pôl métter la tèsta, ai métt la cô= Dove il diavolo non può mettere la testa, ci mette la coda.
Indóvv a n’i é al saul, a i é spass al dutaur = Dove non c’è il sole, spesso c’è il dottore (nelle case buie e malsane è facile ammalarsi).
Ingarbuièrs dal tàimp = Il rannuvolarsi del cielo.
I ninén e i fiû di cuntadén i én bî quand i én cén = I maiali e i figli dei contadini sono belli quando sono piccoli.
In Paradîs a i é una scrâna preparè par la prémma nôra e madôna ch’én andè d’acôrd = In Paradiso c’è una seggiola per la prima nuora e suocera che sono andate d’accordo.
Insénn che ón l’ha i dént in bacca, an’sa quall ch’al tacca = Finché uno ha i denti in bocca, non sa che cosa gli tocca (Finché uno è in vita, non conosce il destino).
Insènn ch’ai n’é, viva mé, quand an’é pió, viva Gesó = Finché ce n’è, viva me, quando non ce n’è più, viva Gesù. Le cose vadano pure come debbono andare. Fatalismo.
Insènn ch’i é vètta, i é speranza = Finché c’è vita, c’è speranza.
Int’al màis ch’al canta al cócch, la sîra l’é mói, la maténna l’é sótt = Nel mese in cui canta il cuculo, la sera è bagnato e la mattina è asciutto (Aprile-Maggio).
Insénn par l’Asensiàn, tén só al gabân = Fino all’Ascensione tieni ancora il gabbano.
Intarès ed prît, pruvidanza ed’Dio, fâm ed can da cuntadén, a gl’én cós ch’el n’han mai fén = Interessi dei preti, provvidenza di Dio e fame di cane da contadino, sono cose che non hanno mai fine.
Int’al paîs di èter al vâch al péccen ‘i bû = Nei paesi degli altri, le vacche picchiano i buoi.
Int’al batt cénna, si sta al vén fén = Nella botte piccola c’è il vino buono. Il vino migliore, infatti, perché è buono, viene messo nelle botti piccole.
Int’la panzatta a i é anch la cadga = Nella pancetta c’è anche la cotica (non vi è rosa senza spine, in forma più prosaica).
Int’un’aura, al zîl lavaura = In un’ora il cielo lavora (il cielo può risolvere una situazione in pochissimo tempo).
Int’un Gesó = In un attimo
In zàint ân e zàint mîs, l’âqua taurna ai sû paîs = In cento anni e cento mesi, l’acqua ritorna ai suoi paesi.
Inzariôla ed suladèl, a i n’avàn pr’un msarèl = Candelora (2 febbraio) col sole, ne abbiamo per un mese.
I ômen gîren, e al muntâgn stan fàirmi = Gli uomini girano, e le montagne stanno ferme.
I ômen i én cumpàgn i mlón: pió i én vîc’ pió i én quajón = Gli uomini sono come i meloni: più son vecchi, più son minchioni.
I ômen in s’misûren a pêrdgh = Gli uomini non si misurano a pertiche. La pertica era una misura agrimensoria locale pari a m 3,80 circa. Una pertica quadrata faceva la tavola di mq 14,444. 144 tavole facevano la tornatura di mq 2.080, 44 circa.
I pàver i mànden a bavver agli ôch = I paperi mandano a bere le oche. I meno esperti danno ordini a chi ne sa di più.
I péss grûs, stan in fand al masnadûr = I pesci grossi stanno in fondo al macero.
I pipién ai’âcgnóss la ciôza = I pulcini li conosce la chioccia. La chioccia conosce i suoi pulcini (gli altri no).
I prémm in fónn mai sàinza = I primi non rimasero mai senza.
I prémm pipién chi nasen i én i prémm a métter la crasta = I primi pulcini che nascono sono i primi a mettere la cresta.
I puvrétt d’atàis i pózzen = I poveri, da vicino, puzzano.
I puvrétt, o mazêri o mantgnîri = I poveri, o ucciderli o mantenerli. Proverbio cinico. Nelle nostre campagne i puvrétt non erano i contadini, bensì i braccianti che lavoravano a giornata, quando ne trovavano, e per salari da miseria.
I récch i an al Paradîs in tèra, e anch in cl’èter mand, si vôlen = I ricchi hanno il Paradiso in terra, ed anche nell’altro mondo, se lo vogliono.
I regâl di cuntadén i câsten chèr = I regali dei contadini costano cari. Un contadino non fa nulla se non spera in un compenso.
I Sant = Ognissanti (1° Novembre). In certi Comuni facevano trasloco i contadini. I lavori grossi erano finiti e chi non traslocava poteva godersi la festa in pace.
I Sant ch’i mâgnen, i can chi dôrmen, i mlón ch’i péssen, an in é gnanch ón di bón s’in’s’arabéssen = Dei Santi che mangiano, dei cani che dormono e dei meloni che pisciano (cioè acquosi) non ce n’è uno dei buoni se non si arrabbiano.
I Sant vîc in fân pió mirâcuel = I Santi vecchi non fanno più miracoli. (Anche i santi si esauriscono).
I turtlén i én la bièva di prît = I tortellini sono la biada dei preti.
I sturnî a branch in’s’ingrasén brîsa = Gli storni a branco non si ingrassano. Quando si è in troppi c’è poco da godere.
I urbén d’Bulaggna i vôlen un bajôch par sunèr e dû par smétter = Gli orbini di Bologna vogliono un baiocco per suonare e due per smettere.
I vîc i’n’an pès s’i n’an atàis al brès = I vecchi non hanno pace se non hanno vicino le braci (se non sono vicino al fuoco).
La bacca s’pôl lighèr al sâch, mo brîsa a la zaint = Si può legare la bocca al sacco, ma non alla gente.
La batt cla pózza la trà al vén trést = La botte maleodorante, produce vino scadente.
La bendziàn pâsa sèt murâja = La benedizione passa sette muri.
La bèrba an’fa al rumétta = La barba non fa l’eremita. L’abito non fa il monaco.
La biastamma gîra, gîra e pó la taurna a chi la tîra = La bestemmia gira, gira e poi torna a chi l’ha detta.
La bîstia ch’an bavv, l’é una bîstia trésta = Il bovino che beve poco, ha poco valore.
La bîstia l’é una caraggna dapp môrta; l’ômen l’é caraggna anch da vîv = La bestia è una carogna da morta: l’uomo è una carogna anche da vivo.
La blazza dl’èsen = La bellezza dell’asino. Bellezza di gioventù. Bellezza che non dura.
La blazza e la buntè al zîl ‘i ajûta = Il cielo aiuta la bellezza e la bontà. Era generale la credenza che la bellezza fosse segno della benevolenza divina.
La blazza e la buntè han al prèmi meritè = La bellezza e la bontà hanno il premio meritato.
La bôna dôna fa la ca, ma mâta a la dsfa = La buona donna fa la casa, la matta la disfa.
La bôna grappia fa la bôna bîstia = La buona alimentazione, fa il buon bovino.
La bôna mèder dîs “tû”, brîsa “vût” = La buona madre dice “prendi”, non “vuoi”.
La bôna pâpa, fa la bèla fâza = La buona pappa fa la bella faccia.
La bôna smàint, dà al ban arcôlt = Il buon seme, dà il buon raccolto.
La brèva dunénna la fa al lèt a la maténna; la dôna acsé, acsé, al le fa int’al mezdé; la brótta dunâza al le fa quand la s’azâca = La brava donnina fa il letto alla mattina; la donna così, così, lo fa nel mezzodì; la brutta donnaccia lo fa quando si sdraia.
La burâsca ed’ San Jusèf, l’ha da vgnîr, o tèrd o prèst = La burrasca di San Giuseppe, deve venire, o tardi o presto.
La bûra trî dé la dûra = Il vento grecale (bûra) soffia per tre giorni consecutivi.
La camîsa a n’i tacca al cûl = La camicia non gli tocca il culo. Si dice di chi dimostra troppa allegrezza per il buon esito di un affare.
La caunta pió’na fatta ed pulàint in pès ch’n’é un arôst ed capan bruntlè = Giova di più una fetta di polenta (mangiata) in pace, che un arrosto di cappone di malumore.
La chèren di cristiàn l’é dûra da cgnósser = La carne (sostanza) dei cristiani (uomini) è difficile da conoscere.
La chèren di sumâr l’é avviè al bastàn = La carne del somaro è abituata al bastone.
La chèren pió catîva l’é qualla dla langua = La carne più cattiva è quella della lingua (perché può ferire).
La cô é la pió catîva da dscurghèr = La coda è la più cattiva da scorticare (In cauda venenum).
La cusénna cénna, fa granda la ca = La cucina piccola fa grande la casa. Chi mangia poco, risparmia.
La dôna, al fûgh e al mèr, i fân l’ômen priglèr = La donna, il fuoco e il mare sono gli infortuni dell’uomo.
La dôna é al fûgh, l’ômen la stappia: al vén al dièvel e pó al sóppia = La donna è il fuoco, l’uomo è la stoppia: viene il diavolo e poi ci soffia sopra.
La dôna è cumpâgn è la castâgna: bèla par d’fôra, dàinter la magâgna = La donna è come la castagna, bella di fuori, dentro la magagna.
La dôna l’é l’uréggin ed tótt i mèl = La donna è l’origine di tutti i mali. Concetto Paolino, ripreso da fra’ Salimbene de Adam da Parma: Donna, origine del peccato, causa della cacciata dal Paradiso terrestre… Probabilmente non ne aveva mai conosciute.
La dôna la n’é sicûra dal sô ragazôl s’al n’avó la fêrsa e al varôl = La donna non è sicura del suo bambino sino a quando non ha avuto il morbillo ed il vaiolo. Erano le malattie che causavano grande mortalità fra i bambini.
La dôna l’é pió custanta int’l’ôdi che int’l’amaur = La donna è più costante nell’odio che nell’amore.
La dôna l’in sa ónna chèrta ed tótt i zûgh = La donna conosce una carta di tutti i giochi.
La dôna sàinza l’ômen tant vèl quant la mnèstra sàinza sèl = La donna senza l’uomo, tanto vale quanto la minestra senza sale.
La dspraziàn l’è la mèder di sumâr = La disperazione è la madre dei somari.
La dûra pió ’na pgnâta ratta che ónna bôna = Dura di più una pignatta rotta che una buona. Campa di più una persona malaticcia che una sana.
La fâm fa vgnîr fôra al lauv da la tèna = La fame fa uscire fuori il lupo dalla tana.
La farénna dal dièvel la va tótta in ràmmel = La farina del diavolo, va tutta in crusca.
La fîvra di spunción = La febbre degli adolescenti. Gli “spunción” sono le prime piume che mettono gli uccelli quando cominciano a crescere.
La fîvra terzèna, al zauven a l’arsèna e al vèc’ fa sunèr la campèna = La febbre terzana (malarica), risana il giovane, mentre fa morire il vecchio (fa suonare la campana a morto).
La furnès prôva l’ôr, l’ôr prôva la dôna = La fornace prova l’oro e l’oro prova la donna. È difficile per una donna resistere a regali preziosi.
La furtónna di puvrétt, l’é int’la vójja d’lavurèr = La fortuna dei poveri è la voglia di lavorare.
L’agaccia e la pzôla la mantén la famjôla = L’ago e la pezzuola, mantengono la famigliola. (Vecchio proverbio della povertà d’un tempo).
La galénna dagli ôv d’ôr = La gallina dalle uova d’oro. La moglie del povero che aveva un amante ricco.
La galénna ed Cranvél, s’l’an s’mâgna la va da mèl = La gallina di Carnevale, se non si mangia va a male.
Laggna da gréll, fûgh e favéll = Legna da grilli, fuoco e faville.
La guâza ed San Zvân, la guaréss ôgni malân = La rugiada di San Giovanni guarisce ogni male. La notte di San Giovanni era la notte delle streghe e dei miracoli.
La guèra, la n’é fâta pr’i pultrón, ma pr’i quaión = La guerra, non è fatta per i poltroni, ma per i coglioni. Si diceva anche: Din dón, din dón, la guèra i la fân i cuntadèn e i quaión = Din don, Din don, la guerra la fanno i contadini e i coglioni. Era spesso vero.
La famàjja di magâra = La famiglia numerosa.
La fâm l’as sént anch sàinza uràcc’ = La fame si sente anche senza orecchie.
La lazz l’é fâta pr’i minción = La legge è fatta per i minchioni.
La limôsna é fâta bàin anch al dièvel = L’elemosina è ben fatta anche al diavolo.
La limôsna fa dvintèr puvrétt = L’elemosina fa diventare poveri (a farla).
La limôsna s’fa con la bisâca e non cun al buslôt = L’elemosina si fa con la tasca e non col bussolotto. Non è di facile interpretazione. Si dovrebbe ritenere che l’elemosina si deve fare, ma con moderazione. Infatti nella tasca si tenevano gli spiccioli e nel bussolotto i risparmi.
La lónna chl’a al zàirc’ acôst, ha la piôva dcôst = La luna che ha l’alone vicino, ha la pioggia lontana.
La lónna l’an bèda al can ch’al bâia = La luna non fa caso al cane che abbaia.
La luntananza sèna tótti al piègh = La lontananza risana tutte le piaghe.
L’âqua ed febrèr, rimpéss la canténna e al granèr = L’acqua di febbraio riempie la cantina ed il granaio.
La mascla la tîra i chèlz ch’la pôl = La mosca tira i calci che può. I poveri si difendono come possono.
L’amaur al vén da l’intarès = L’amore viene dall’interesse. Tipicamente contadino.
L’amaur an cgnóss misûra = L’amore non conosce misura. L’unica misura d’amare, è amare senza misura.
L’amaur e la tass in s’pólen tgnîr cuêrt = L’amore e la tosse non si possono nascondere.
L’amaur as’pèga con l’amaur = L’amore si ricambia con l’amore.
L’amaur e la vciâia, l’é na brótta bagâia = Due le interpretazioni: Innamorarsi da vecchi è una cosa dolorosa; L’amore e la vecchiaia sono cose dolorose.
L’amaur sta int’al sèl = L’amore sta nel sale. Ogni amore ha le sue pene.
L’amaur pâsa i guant e l’âqua i stivèl = L’amore passa i guanti e l’acqua gli stivali.
L’ha sughè una bughè = Ha asciugato un bucato. Si diceva di persona pallida per esiti di una malattia.
La medsénna di sumâr l’è al stangatt = La medicina per gli asini è il bastone.
La mêrda la s’arvôlta al granadèl = La merda si ribella allo scopino. Espressione, volgare, ma efficace, di stupore.
Lamintères ch’al brôd l’é grâs = Lamentarsi del brodo grasso (del benessere).
La misêria l’in fa zinquantanôv = La miseria ne fa cinquantanove (punti). Nel gioco della briscola chi fa sessantuno punti vince, chi ne fa sessanta pareggia e chi ne fa cinquantanove perde. Morale: la povertà perde sempre.
La misêria vèn in bèrca = La miseria viene in barca. I nostri contadini ritenevano, a ragione, che la stagione troppo piovosa portasse scarsi raccolti.
La mlarânza è d’ôr a la maténna, d’arzant a mezdé, ed piàmb a la sîra = L’arancio è d’oro al mattino, d’argento a mezzogiorno e di piombo alla sera. Norma d’igiene alimentare.
La môrt dal piguer, l’è la vétta di can = La morte delle pecore, è la vita dei cani.
La môrt métt tótt dal pèr = La morte metti tutti dal pari. L’egualiatrice numera le fosse… (Gozzano).
La mujèr dal lèder l’an rédd sàimper = La moglie del ladro non sempre ride.
La mnêstra arscaldè la sa’d fómm = La minestra riscaldata ha sapore di fumo. Un amore interrotto e ripreso non è mai buono. Si dice anche: La mnêstra arscaldè la n’è mai bôna = La ministra riscaldata non è mai buona.
La mûsica la va a l’èlta e l’âqua la va a la bâsa = La musica sale e l’acqua scende.
La nabbia an fa córrer i fûs = La nebbia rende poco scorrevoli i fusi.
La nàiv marzulénna la dûra da sîra a maténna = La neve di marzo (marzolina) dura da sera a mattina.
L’ân di madón, lè l’ân di sacadón = Negli anni in cui si semina dopo una stagione asciutta, si raccoglie molto grano. (I madón sono le zolle di terra che si formano quando si ara col il secco).
La nôt dla Pasquatta, i dscarrèn al ciû e la zvatta = La notte dell’Epifania, parlano l’assiolo e la civetta.
La nôt é fâta pr’i ciû = La notte è fatta per gli assioli (rapaci notturni) (e non per gli uomini).
La nôt é fâta pr’i lugón = La notte è fatta per gli allocchi.
La nôt é mèder di pinsîr = La notte è la madre dei pensieri.
La nôt é mèder dla pôra = La notte è la madre della paura.
La nôt pôrta cunséi = La notta porta consiglio.
La padèla dîs al parôl: fât in là, t’ûm ténz = La padella dice al paiolo: Fatti in là che mi tingi. È una lamentela ridicola perché entrambi sono sporchi di fuliggine.
La padèla e la gradèla fan l’arvénna d’la famajja = La padella e la graticola sono la rovina della famiglia. I cibi da friggere e quelli da mettere sulla brace, sono cibi costosi.
La pâja avsén al fûgh la brûsa = La paglia vicino al fuoco brucia. Mettere un uomo vicino ad una donna è pericoloso.
La Pasquatta, métt al fêst int’na cassatta = La Pasquetta (6 gennaio) mette le feste in una cassetta.
La pêlma bandatta la vôl la ca’ natta = La palma benedetta, vuole la casa pulita. Prima della domenica delle Palme, la casa deve essere ripulita (Le pulizie di Pasqua).
La pèr c’la n’in vójja = Sembra che non ne voglia. Di ragazza solo apparentemente schiva.
La pèr ‘na madunénna infilzè = Sembra una madonnina infilzata. Di ragazza molto timida e modesta (all’apparenza).
La pèr ‘na rôca vsté = Sembra una rocca (canocchia) vestita. Di donna magra e allampanata.
La pèr un lât e un mél = Sembra latte e miele. Di donna giovane, aggraziata e riservata.
La pèr un mazacrôch = Sembra un girino di rana. Di donna piccola e grassa.
La pèr un pèl vsté = Sembra un palo vestito. Di donna alta e molto magra.
La pió bôna dal rassi la fichè sô mèder in’t’al pazz = La migliore delle rosse, gettò sua madre nel pozzo. Ai rossi di pelo, veniva attribuito animo malvagio. Si dice anche: Al pió ban di róss, al mazé sô pèder = Il migliore dei rossi, uccise suo padre.
La pió dûra da dscurghèr l’é la cô = La più dura da scorticare è la coda.
La pôra la fa nuvanta = La paura fa novanta. Dalla cabala del lotto.
La prémma âqua ch’vén, lê qualla ch’immójja = La prima acqua che viene, è quella che bagna.
La prémma âqua d’agast, pôrta al frasch al bôsch = La prima acqua d’agosto, porta il fresco al bosco.
La prémma galénna ch’canta, l’é qualla ch’a fât l’ôv = La prima gallina che canta. È quella che ha fatto l’uovo.
La prémma la s’pardauna, la secanda la s’bastauna = La prima si perdona, la seconda si bastona.
La prémma l’è di trèst = La prima (partita) è degli incapaci (la vincono coloro che non sanno giocare).
La prémma l’è di tûs, la secanda di virtuûs = La prima è degli inesperti, la seconda dei bravi giocatori.
La prémma mujèr l’è ‘na sframbla, la secanda l’é ‘na clamba = La prima moglie è un sasso lanciato, la seconda una colomba. L’affetto per la seconda moglie fa dimenticare la prima.
La pulaint con al butîr, l’é un magnèr da cavalîr, la pulaint con al furmâi, l’é un magnèr da sunâi = La polenta col burro è un cibo da signori, la polenta col formaggio è un cibo da gran minchioni.
La pulaint n’ha fôrza = La polenta non ha forza. Anche in senso figurato: “La voce dei poveri non trova ascolto”.
L’âqua ed febrèr, rimpéss la canténna e al granèr = L’acqua di febbraio riempie la cantina ed il granaio. Si riteneva che un febbraio piovoso avrebbe portato raccolto abbondante di uva e di grano.
L’âqua ed Sant’Âna l’è méi dla mâna = L’acqua (la pioggia) di Sant’Anna (26 luglio) è meglio della manna.
L’âqua la fa marzîr al budèl = L’acqua fa marcire le budella (giustificazione dei beoni).
L’âqua la fa mèl e al vén al fa cantèr = L’acqua fa male e il vino fa cantare.
L’âqua quàida, l’é qualla ch’bâgna = L’acqua cheta è quella che bagna.
L’âqua smôrza al fûgh, ma la fûgh an fàirma l’âqua = Lacqua spegne il fuoco, ma il fuoco non ferma l’acqua. Acqua e fuoco sono elementi indispensabili, ma, in certe circostanze, anche molto pericolosi. I contadini vivevano nel continuo timore degli incendi (della casa, della stalla, dei raccolti) o, quelli della bassa, delle alluvioni, l’acqua era spesso più temuta del fuoco stesso perché più difficile da fermare.
L’arlój ed San Pasquèl o un gran bàin o un gran mèl = L’orologio di San Pasquale o un gran bene o un gran male. L’orologio di San Pasquale è quel ticchettio che fanno i tarli di notte.
L’argój dûra pôch = La boria dura poco.
L’âria ed satta fa rimpîr la pazza = L’aria di sotto (quella proveniente dai quadranti di Nord ed Est) fa riempire la pozza (porta acqua).
La rôba ch’é int’i camp, lè di Dio e di Sant = La roba che è nei campi è di Dio e dei Santi. Giustificazione pretestuosa di chi rubava frutta ed altri prodotti dei campi.
La rôba cl’é in t’al bôsch, l’é dal prémm ch’a i sèlta adôs = La roba che è nel bosco è del primo che ci salta addosso.
La rôba córr drî a la rôba = La roba corre dietro alla roba. Il denaro va a chi già ne ha.
La rôba crûv la gôba = La roba copre la gobba. Il denaro rende attraente anche una brutta donna.
La rôba la rûba l’ânma = La roba ruba l’anima.
La rôba rubè, l’ha fa né prò, né parè = La roba rubata non rende.
La rôda pió trèsta dal câr l’é qualla cla zîrla = La ruota peggiore del carro è quella che cigola. Di solito, chi si lamenta è colui che vale meno degli altri.
La salût an’i é quattrén ch’la pèga = La salute non ci sono quattrini che la paghi. Non vi è tesoro che possa valere la salute.
Lâsa stèr al can ch’al dórum = Lascia stare il cane che dorme.
Lasèr frézzer int’al sô grâs = Lasciare friggere nel proprio grasso. Lasciare che uno cuocia nel suo brodo.
Lasèr l’óss in sbadâc’; Lasèr l’óss in sfassa = Lasciare l’uscio socchiuso.
Lasèr i ûc’ int’na côsa = Lasciare gli occhi in una cosa (per desiderio di possederla).
Lasèrs amachèr al nûs in tèsta = Lasciarsi schiacciare le noci in testa. Non avere carattere. Lasciarsi sopraffare.
La speranza l’é al pan di dsprè = La speranza è il pane dei disperati.
La squâtla cmôd ‘na cavâla in bràjja = Donna che nel camminare scuote l’anca (si dimena) dome una cavalla sotto le briglie.
La stézza di fradî, la pâsa sóbbit = La stizza dei fratelli, passa subito.
La strè d’l’inféren l’é léssa = La strada dell’inferno è liscia, (è facile)
La tèsta an’dôl, quand al stamgh an vôl = La testa non duole, quando lo stomaco non vuole. Le emicranie dipendono da cattiva digestione.
La tèvla e la côrda fa slunghèr al brâza = La tavola e la corda allungano le braccia. Forse proverbio di origine antica quando nella tortura si usavano il cavalletto (tèvla) ed i tratti di corda per le confessioni.
Lauv an magna lauv = Lupo non mangia lupo. Come cane non mangia cane.
La vaulp la s’arcnóss da la cô = La volpe la si riconosce dalla coda.
La vaulp mûda al pàil, mo brîsa al vézzi = La volpe cambia il pelo, ma non il vizio.
La vècia per pôch la bâla, ma par trôp la s’astóffa = La vecchia per un poco balla, ma per troppo si stanca. Non bisogna tirare troppo la corda.
La véggna la dîs al cuntadén: fâm pôvra, ch’at faró récch = La vigna dice al contadino: fammi povera che ti farò ricco. Si deve leggere: potami energicamente che produrrò molto.
Lavèr la chèren, adaquèr al vén e batzèr un cuntadén, agl’en trài côs da cretén = Lavare la carne, annaffiare il vino e battezzare un contadino sono tre cose da cretino.
Lavèrs la bacca = Lavarsi la bocca. Dire tutto ciò che si pensa senza riguardi.
La vètta ed Miclâz: magnèr, bavver e andèr a spâs = La vita di Michelaccio: mangiare, bere e andare a spasso.
Lavurèr da dièvel = Lavorare molto.
Lavurîr fât, quatrén aspèta = Lavoro fatto, aspetta compenso.
La zôbia magna l’âlas, al vèner dal pass = Il giovedì mangia bollito, il venerdì del pesce. Un tempo le famiglie abbienti di città e di campagna mangiavano carne bollita (métter sô la pgnâta) il giovedì e la domenica.
La zoventó dla dôna, l’é cómm la frascazza di fónz: la dûra un dé = La gioventù della donna è come la freschezza dei funghi: dura un giorno.
La zoventó vôl al sô sfûgh = La gioventù vuole il suo sfogo.
L’é al fûgh ch’prôva l’ór e l’ór la dôna = E’ il fuoco che prova l’oro e l’oro la donna.
L’é catîv cumpâgn al lói = E’ Cattivo come loglio. Il loglio (Lolium temulentum) è una pianta erbacea delle Graminacee, infestante dei seminati ed altamente velenosa. Se i semi vengono mescolati al grano, il pane piò dare a chi lo mangia vertigini e vomiti. Da non confondere con altre specie foraggere ed innocue come il Lolium italicum, il Lolium perenne ed il Lolium tenue.
L’è caschè al furmâi int’al lasâgn = E’ caduto il cacio sui maccheroni.
L’é cómm al cavâl ad’scâja, ch’l’aveva trantasî mèl satta la cô = E’ come il cavallo di Scaglia che aveva tretasei mali sotto la coda. Di persona sempre malaticcia.
L’é cómm’ San Tmès: an i cradd s’al ni métt al nès = E’ come San Tommaso, non ci crede se non ci mette il naso.
L’é cómm insfilzèr un’agaccia al bûr = E come infilare un ago nel buio.
L’é cumpâgn al cócch ch’al métt agl’ôv int’al nîd ed chi èter = E’ come il cuculo che depone le uova nel nido degli altri. Di donnaiolo impenitente.
L’é cumpâgn invidèr un tudàsch a bavver = E come invitare un tedesco a bere. Invitare uno a fare una cosa che fa volentieri.
L’é dûra l’aràinga = E’ dura l’aringa. E’ difficile vivere.
L’é imbruiè saul chi as’fîda = E’ ingannato solo chi si fida (degli altri).
L’é làint cómm la mèsna ed’satta = E’ lento come la macina di sotto. Di persona lenta e pigra. Si riferisce alla macina inferiore dei vecchi mulini a palmenti che girava più lentamente di quella superiore.
L’é l’istàss che dscàrrer a ‘na murâja = E lo stesso che parlare a un muro.
L’é méi al vén féss, che l’âqua cièra = E’ meglio il vino torbido che l’acqua limpida.
L’é méi avàir in bisâca un pizân, che d’côd’un âlber un pavân = E’ meglio avere in tasca un piccione, che un pavone in cima a un albero.
L’é méi avàir un pipién in sain che na galénna tra la zèda = Meglio avere un pulcino in seno che una gallina nella siepe. Meglio un uovo oggi che la gallina domani.
L’é mèi campèr mègher che murî grâs = E’ meglio vivere magri che morire grassi.
L’é mèi caschèr da la fnèstra che dai cópp = E’ meglio cadere dalla finestra che dal tetto. E’ male minore.
L’é mèi dèr la lèna che la pîgra = E’ meglio dare la lana che la pecora. E’ meglio perdere una mano che un braccio.
L’é mèi dîr puvràtt mé che puvrétt nó = E’ meglio dire povero me che poveri noi.
L’é mèi èser arpzè che strazè = E’ meglio essere rattoppato che stracciato
L’é mèi èser gelaus, che bacch’ = E’ meglio essere geloso che cornuto
L’é méi èser invidiè che cumpaté = E’ meglio essere invidiato che compassionato
L’é méi èser un ban garzân che un trést padrân = E meglio essere un bravo servitore che un cattivo padrone.
L’é méi èser usèl d’campâgna che d’ghèbia = E’ meglio essere uccello di campagna, che di gabbia.
L’é méi fèrla da zauvén, che da vèc’ = E meglio sposarsi da giovane che da vecchio.
L’é méi fèr invidia che cumpassiàn = E’ meglio fare invidia che compassione.
L’é méi fîgh che fiûr = E’ meglio fichi che fiori. E’ meglio essere frutti che fiori.
L’é méi pan brón, che pan inción = E’ meglio pane nero che pane “nessuno”.
L’é méi pèrder un’oc’ che la tèsta = E’ meglio perdere un occhio che la testa.
L’é méi pluchèr un ôs che un bastan = E’ meglio leccare un osso che un bastone. Chi si contenta gode.
L’é méi pôch e ban, purassé e catîv = E’ meglio poco e buono, che molto e cattivo.
L’é méi stasîra una galénna, che un ôv dmaténna = E’ meglio una gallina stasera che un uovo domattina.
L’é méi sudèr che spudèr = E’ meglio sudare (per il cavallo) che sputare (per il catarro conseguente al freddo).
L’é méi sudèr che tarmèr = E’ meglio sudare che tremare. E’ meglio il caldo che il freddo.
L’é méi un fringuèl in man, che un taurd in frâsca = E’ meglio un fringuello in mano, che un tordo tra la frasca.
L’é méi un sgnauri catîv che zàint puvrétt bón = E meglio un signore cattivo che cento poveri buoni.
L’é méi sudèr che tàsser = E’ meglio sudare che tossire.
L’é méi un sumâr vîv, che un dutaur môrt = E’ meglio un asino vivo che un dottore morto.
L’Epifanî tótti al fèst la pôrta vî; la i asèra int’na scâtla e a l’avérra po’ par Pasqua = L’Epifania (6 gennaio), tutte le feste porta via. Le chiude in una scatola che apre, poi per Pasqua.
L’é méi ‘na bôna durmîda che una bôna magnèda = E’ meglio una buona dormita che una buona mangiata.
L’é méi un trèst maré ch’an fa un ban fradèl = Meglio un marito da poco che un buon fratello.
L’é méi ‘na vizèllia che una quarèisma = E’ meglio una vigilia che una quaresima.
L’é méi ‘na zivalla in libartè, che in sudizian una grustè = E’ meglio una cipolla in libertà, che una crostata in soggezione.
L’é ón ch’as fa dèr dal ló = E’ uno che si fa dare del lei. Uno che si fa rispettare.
L’é pió d’là che ed dzà = E’ più di là che di qua = Di persona moribonda.
L’é pió fazîl tgnîr avèrta ‘na spôrta, che drètt un pèl = E’ più facile tenere aperta una sporta, che dritto un palo.
L’é pió la zónta che la chèren = E’ più l’aggiunta che la carne. La zónta era la parte di ossa e di tagli scadenti che il macellaio aggiungeva alla carne da brodo. Usato anche in senso figurato. Una battuta della fine del secolo diciannovesimo diceva: Al caulum pr’un séndich? Metter só al brôd con la zónta. Il colmo per un Sindaco mettere su il brodo con la giunta. E’ detta zónta anche la “Giunta comunale”.
L’é pîz ón ch’an vójja, che ón ch’an pôsa = E meglio uno che non voglia, che uno che non possa.
L’êrba bîga, tótt i mèl nudrîga = L’erba biga, cura tutti i mali. Sotto il nome di êrba bîga passavano diverse piante del genere Ajuga: A. reptans, A. chamaepitys, A. piramidalis, tutte della famiglia delle Labiate. Venivano usate come cicatrizzanti, aromatiche e per amari.
L’êrba catîva la crass in fûria = L’erba cattiva cresce in fretta.
L’êrba catîva l’é dûra da murîr = L’erba cattiva non muore mai.
Lèrga é la pôrta e drétta la strè ch’ai pôrten all’arvénna = Larga è la porta e dritta la strada che portano alla rovina.
L’èsen di capuzén, bavv âqua e pôrta vèn = L’asino dei Cappuccini, beve acqua e porta vino.
L’estèd l’é pèder di puvrétt = L’estate è il padre dei poveri. Non ci sono problemi di riscaldamento e trova sempre qualcosa da mangiare.
L’é pruvèrbi antîgh, che al vilan an fó mai amîgh = E’ proverbio antico, che il villano non fu mai amico.
L’é sô pèder caghè e spudè = Assomiglia in tutto a suo padre.
L’é tan brótt, ch’al fa pôra al cantunè = E’ tanto brutto che fa paura agli angoli delle case. (Probabilmente perché vedendolo sbucare all’improvviso da un angolo, potrebbe realmente fare paura).
L’é tant grécc’ ch’al dscugarévv un bdôc’ par vander la pèl = E’ tanto avaro che scorticherebbe un pidocchio per venderne la pelle.
L’é una côsa ch’pâsa al saggn’ = E’ una cosa che va oltre il limite.
L’é un catîv imparèr a sô cast = E’ un cattivo imparare a sue spese.
L’é un catîv stuflèr quand i bû i n’an sàid = Non vale fischiare quando i buoi non hanno sete. I contadini usavano fischiare per indurre i buoi a bere.
L’é un catîv andèr a rubèr a ca’ di lèder = E’ una cosa poco conveniente, andare a rubare a casa dei ladri.
L’é un diavlâz = E’ un povero diavolo.
L’é un Dio mandé = Di una cosa che viene a proposito.
L’é un èter pèr ed mandgh = E’ un altro paio di maniche. E’ una cosa diversa.
L’é un gran mât quall ch’al cuntrâsta col zîl = E’ un gran pazzo colui che si oppone alla volontà di Dio.
L’é un gran dièvel = E’ un uomo molto potente.
L’é un quèl ch’al dûra da Nadèl a San Stèven = E’ una cosa che dura da Natale a Santo Stefano. E’ una cosa che dura poco. Tra Natale e Santo Stefano c’è un giorno.
L’é un mustâz da quadarlétt = E’ una faccia da travicelli. E’ una faccia tosta.
L’é un ômen trèst quall c’al biastàmmia cànter Crést = E’ un uomo tristo, colui che bestemmia contro Cristo.
L’é un pan ónt = E’ un pane unto. Una cosa che giunge a proposito.
L’é un pôver dièvel; L’è un pôver zavài = E’ un povero diavolo; E’ un povero “zavaglio” (cosa che non conta o che non serve a niente).
L’é un vézzi cl’ha in’tal’ôsa = E’ un vizio che ha nelle ossa. Un vizio innato.
Léttra fâta, arspôsta aspèta = Lettera scritta, aspetta risposta.
L’ha al curâg’ ed qual c’al magnè al prémm buratèl = Ha il coraggio di quello che mangiò la prima anguilla.
L’ha fât bugadén = Ha fatto il bucatino. Di persona pallida e dimagrita in conseguenza di una malattia.
L’ha la fôrza d’Mavrén ch’al strazèva la chèrta mójja coi dént = Ha la forza di Maurino che stracciava la carta bagnata coi denti.
L’ha musghè al tatt a sô mèder = Ha morsicato le tette a sua madre. Essere molto sfortunato.
L’ha un chèld ch’ai sûda la langua in bacca = Ha un caldo che gli suda la lingua in bocca.
Liberté, fraternité, egalité: Va vî té, ch’a végn lé mé = Va via tu, che vengo io. Proverbio risalente, forse, all’epoca dell’arrivo dei Francesi a Bologna (1796).
Lighèr i can con dla susézza = Legare i cani con la salciccia (segno di grande abbondanza).
Lighèrsla al nès = Legarsela al naso. Ricordarsi di un torto ricevuto.
L’Immaculè (La Madôna Fiurè) = Immacolata Concezione di Maria. Il culto di Maria “sine labe concepta” è antico, nonostante il dogma sia abbastanza recente (8 dicembre 1854, Pio IX). Sul piano dottrinale era stato definito nella seconda metà del ‘200 dal Francescano Giovanni Duns Scoto, il “Doctor subtilis”.
L’intenziàn, an guâsta vizèllia = Non basta l’intenzione a guastare la vigilia.
L’invêren, in zîl, an’i avânza brîsa = L’inverno non rimane in cielo. Presto o tardi viene la cattiva stagione.
L’invidia fa la bûsa a i èter e pó la i câsca dàinter lî = L’invidia scava la fossa agli altri e poi ci casca dentro lei.
Lît intrighè, mèza guadagnè = Lite complicata, mezza guadagnata.
L’istassa mnèstra la stóffa = Mangiare sempre la stessa minestra stanca. Era la giustificazione dei mariti che si permettevano qualche libertà coniugale.
Livèr al gambd = Alzare il gomito. Bere troppo.
Livèr la pèdga = Prendere l’impronta di persona per fare un sortilegio. Consisteva nel raccogliere la zolla con l’impronta e nasconderla in un luogo segreto. Il nemico sarebbe morto lentamente.
Livèrs una spénna da un ôc’ = Togliersi una spina da un occhio. Togliersi un pensiero. Liberarsi di una cosa o di una persona molesta.
L’ôc’ dal padràn, guérna al cavâl = L’occhio del padrone, ingrassa il cavallo.
Lôda al mât e fâl saltèr, s’al n’é mât t’al fè dvintèr = Elogia il matto e fallo saltare, se non è matto lo fai diventare.
Lôda al mèr, ma tént a la tèra = Loda il mare, ma tieniti alla terra.
Lôda la lôdla, ma tént al parmadézz = Elogia l’allodola, ma tieniti il primaticcio (di vegetali). Non attendere il passaggio delle allodole per seminare.
Lôda la pulàint e magna al pan = Loda la polenta e mangia il pane. La polenta godeva di scarso credito presso i contadini.
Lói, as’mèd e as’ cói = Luglio, si miete e si raccoglie.
L’ôli d’la lantêrna, tótt i mèl ‘ai guêrna = L’olio della lanterna guarisce tutti i mali.
L’ômen al n’é bèl, s’al n’ha al danièl; la dôna la n’é bèla, s’la n’ha la péccia e la burêla = L’uomo non è bello se non ha il danièl (ciuffo di peli arricciati che si facevano crescere sopra un neo della guancia). Era prerogativa dl’azdaur (reggitore della casa). La donna non è bella se non ha la péccia (un neo) e la burèla (la fossetta sul mento).
L’ômen al’s’ha da vantèr ed quâter côs: d’avàir dal ban vén, d’avàir un ban cavâl, d’avàir una bèla mujêr e d’avàir di bajûch dimóndi = L’uomo deve vantarsi di quattro cose: d’avere un buon vino, d’avere un buon cavallo, d’avere una bella moglie e di essere molto ricco. Si noti l’ordine d’importanza crescente.
L’ômen as’vargaggna dau vôlt in’tla só vètta: la prémma quand al n’è brîsa ban ed fèr la secanda; la secanda quand al n’è brîsa ban ed fèr la prèmma = (Di facile intuizione). L’uomo si vergogna di due cose nella vita: La prima quando non è capace di fare la seconda. La seconda quando non è capace di fare la prima.
L’ômen é cazadaur = L’uomo è cacciatore.
L’ômen imbariègh dîs anch quall ch’al s’ha brîsa da dîr = L’uomo ubriaco dice anche ciò che non si deve dire.
L’ômen insénn a ssanta, la dôna insèn cla campa = L’uomo fino a sessanta, la donna finché campa.
L’ômen propón e Dio dispón = L’uomo propone e Dio dispone.
L’ômen pruvàdd e la dôna cunsérva = L’uomo provvede e la donna conserva (risparmia).
L’ômen quand manc a’i pàinsa, ai piôv dal zîl la ricumpàinsa = L’uomo quando meno ci pensa, gli piove dal cielo la ricompensa. La ricompensa del cielo raggiunge l’uomo quando meno se l’aspetta.
L’ômen san péssa spass, cmôd fa un can = L’uomo sano piscia spesso, come fa il cane.
Lonedé a pèrs la racca, martedé an’fé’ngatta, mêrcuel a la zarché, zôbia a la truvé, vèner a l’incruché, sâbet am’pné la tèsta parché dmandga l’èra fèsta = Lunedì smarrii la rocca, martedì non feci nulla, mercoledì la cercai, giovedì la trovai, venerdì la preparai, sabato mi pettinai perché domenica era festa. Filastrocca della filatrice poco volonterosa.
Lóngh cómm la mèsna ed’satta = Lungo come la macina inferiore. Di persona lenta nel lavoro. La macina inferiore girava più lentamente di quella superiore.
Lóngh cómm una quaràisma = Lento come una Quaresima: Di persona lenta e pigra.
Lóngh cumpâgn a la cîsa d’Mascarén = Lungo come la chiesa di Mascarino. La grande e bella chiesa di Mascarino (Santa Maria di Venazzano – Località Castel D’Argile), nella pianura bolognese, richiese molti anni per essere costruita, forse per mancanza di fondi. Si dice anche che venne costruita da un solo muratore che vi impiegò tutta la vita. (Molto bella, per chi la vuole visitare – http://www.orizzontidipianura.it/interno.php?ID_MENU=2770&ID_PAGE=3019).
Lónna d’fèbrèr, lónna da garavî= Luna di febbraio, luna da piccoli grappoli.
Lónna sabadénna, ó la sóppia ó cla spissaiénna = Luna di sabato o soffia (tira vento) o pioggia. Si credeva che la luna nuova di sabato portasse o vento o pioggia.
Lónna setembrénna, sêt lónn s’inchénna = A luna settembrina si inchinano sette lune. Si riteneva che la luna di settembre influisse sull’andamento delle sette lune successive.
L’ôra d’estèd, fa mèl a la panza d’învèren = L’ombra d’estate fa male alla pancia d’inverno. Se uno ozia all’ombra d’estate, non ha da magiare nell’inverno.
L’ôr an’ciâpa mâcia = L’oro non prende macchia. Detto anche in senso figurato.
L’ûltma a murîr l’è la speranza = L’ultima a morire è la speranza.
Luntan da’i ûc’, luntan dal côr = Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
Madâma Niclézzia = Madama Liquerizia. Donna che si dà delle arie.
Mâgna a tô môd e ftéss a môd di èter = Mangia a modo tuo e vesti come vogliono gli altri.
Mâgna bàin e chèga fôrt, e an’avàir pôra dla môrt = Mangia bene e defeca molto e non aver paura della morte.
Mâgna, bavv e dôrum e an’pinsèr a chi at’fa al côren = Mangia, bevi e dormi e non pensare a chi ti fa le corna.
Mâgna da san e bavv da malè = Mangia da sano e bevi da malato. Cioè mangia abbondantemente e bevi (vino) con moderazione.
Mâgna dla pulàint e bavv dl’aqua, èlza la gamba e la pulàint scâpa = Mangia la polenta e bevi dell’acqua, alza la gamba e la polenta scappa. La polenta non nutre.
Magnè d’gróggn = Rimprovero.
Magnèr adôs a ón = Vivere a spese degli altri.
Magnèr agl’ôs dla pulàint = Mangiare le ossa della polenta, cioè nulla.
Magnèr agl’ôv prémma d’la galénna = Mangiare le uova prima che la gallina nasca.
Magnèr a livadént = Mangiare controvoglia.
Magnèr al pan a tradimàint = Mangiare il pane a tradimento.
Magnèr al pan pinté = Pentirsi.
Magnèr a quâter ganâs = Mangiare a quattro palmenti.
Magnèr a stracaganâs = Mangiare fino a stancare la mascella.
Magnèr co’i dént dnanz = Mangiare con i denti davanti. Mangiare con svogliatezza.
Magnèr la fâza a ón = Dare una mangiata di faccia a qualcuno.
Magnèr la fójja = Mangiare la foglia. Accorgersi di qualche malizia, di qualche tranello.
Magnèr, ma n’s’imbisachèr = Mangiare, ma non mettersene in tasca. Norma di buona educazione per chi andava a un pranzo di nozze.
Magnèr ónna co’i ûc’ = Mangiare una donna con gli occhi. Guardare una donna con desiderio.
Magnèr pan e spudâc’ = Mangiare pane e saliva. Mangiare pane senza companatico.
Magnèrs al fégghet = Mangiarsi il fegato Consumarsi dalla rabbia.
Magnèrs al fégghet e la curatèla = Rodersi dentro.
Magnèrs la pâja satta = Mangiarsi la paglia sotto. Mangiarsi il capitale.
Màila côta, câca fâta = Mela cotta, cacca fatta. La mela cotta godeva fama di lassativo.
Manchèr la tèra d’satta a i pî= Mancare la terra sotto i piedi. Riferito a chi non sa destreggiarsi, non sa come comportarsi in circostanze impreviste.
Mandèr da mèl = Lasciare deteriorare una cosa.
Mandèr da mèl al sâch e la farénna = Sciupare il pane e la farina. Perdere tutto.
Man fraddi, côr chèld = Mani fredde, cuore caldo.
Marcant da vén, sàimper puvrén = Mercante da vino sempre poverino. Il commercio del vino rende poco.
Marcatt pécc’ ch’al muré pr’i guai ed chi èter = Marchetto Pecci che morì per i guai degli altri. Di chi si preoccupa dei guai altrui.
Mâz, tótt i dé un tinâz = Maggio, tutti i giorni un tino (di pioggia).
Mâz sótt, furmàint par tótt = Maggio asciutto (senza pioggia), grano per tutti.
Mâz in fiaur, in côr l’amaur = Maggio in fiore, in cuore l’amore.
Mâz in fiaur, i sumâr i vân in amaur = Nel mese di maggio gli asini vanno in amore.
Mâz, màis di mât e di sumâr = Maggio mese dei matti e degli asini.
Mâz urtlan, dimóndi pàjja e pôch gran = Maggio ortolano (piovoso), molta paglia e poco grano.
Maré vèc’, méi che gnénte = Marito vecchio, meglio di niente. Meglio un marito vecchio che nessun marito.
Massa cûrta e tajadèl lónghi = Messa corta e tagliatelle lunghe.
Master Stampécc che da una zôca a’i chèva un cavécc = Un artigiano poco abile, Mastro Tampiccio che da un ciocco ricava un cavicchio.
Matrimôni cuntrastè, matrimôni tribulè = Matrimonio contrastato (dai parenti), matrimonio tribolato (non fa buona riuscita).
Mèder rufièna, fiôla putèna = Se la madre si comporta da mezzana, la figlia agisce di conseguenza.
Mêd sacch e tâja vàird = Mieti secco e taglia verde. Raccogli il grano ben maturo ed anticipa un po’ il taglio della canapa.
Mègher cmôd un óss = Magro come un uscio. Molto magro.
Méi dôna inbalzè, che dôna inzaclè = E’ meglio una donna impacciata, che una donna trasandata.
Mèl an fèr, pôra n’avàir = Male non fare, paura non avere.
Mèl dla pèl, salût dal budèl = Malattia della pelle, salute dell’intestino.
Mèl d’Santa Mèrta = Male di Santa Marta. Emorragia uterina.
Mèl da maré, mèl dal gambd = Dolore del marito, dolore del gomito (il dolore del marito morto dura poco e la vedova si consola).
Mèrz al ténz e avréll al dpénz = Marzo tinge e aprile dipinge (la pelle).
Mèrz dal vàint, avréll dal mèl tàimp, mâz di trón e zóggn di quajón = Marzo del vento, aprile del maltempo, maggio dei tuoni e giugno dei minchioni.
Mèrz, marzàn, cûsum al cûl e brîsa al mustâz = Marzo, marzaccio, cucimi il culo e non i baffi (il volto). Pare che anticamente i contadini, non solo i nostri, usassero salire sui tetti all’arrivo della primavera e, scoperto il didietro verso il sole, pronunciassero lo scongiuro.
Mèrz, marzàn, pôrta al gabàn e anch al zibàn = Marzo, marzaccio porta il gabbano ed anche il giubbotto.
Mèrz, marzàn, trî dé catîv e ón ban = Marzo, marzaccio: tre giorni cattivi ed uno buono.
Mèrz, marzôt, lóngh al dé quanté la nôt = Marzo, marzotto, lungo il giorno quanto la notte. Si riferisce all’Equinozio di primavera.
Mèrz s’al câta al fôs vûd, a l’impéss = Marzo, se trova il fosso vuoto, lo riempie.
Mèrz, schèlz = Marzo, scalzo. Un tempo, i contadini si toglievano le scarpe il giorno di San Giuseppe (19 marzo) e se le rimettevano il giorno di Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre).
Mèrz sótt, avréll mój = Marzo asciutto, aprile bagnato.
Mèrz sótt, mó brîsa par tótt = Marzo asciutto, ma non per tutto.
Mèrz sràin e sótt, pôca pàja e furmàint par tótt = Marzo sereno e asciutto, poca paglia a grano per tutti.
Mèrz urtlàn, purasè pàja e pôch gran = Marzo ortolano (piovoso), molta paglia e poco grano.
Métter a la lûs dal mand = Rendere di pubblico dominio una cosa.
Métt dla laggna, st’vû scaldèr quand l’é fradd = Riponi della legna, se vuoi scaldarti quando è freddo.
Métter al sô côr in pès = Mettere il cuore in pace.
Métter fôra la cadàina = Mettere fuori la catena. Antica usanza. Per evitare pericoli di usucapioni, quando una famiglia colona compiva il secolo di permanenza sullo stesso fondo, il concedente voleva che la catena del focolare venisse staccata e portata fuori di casa. Con questo gesto simbolico, si interrompeva il contratto e se ne iniziava un altro.
Métter insamm al magátt = Arricchire.
Métters’ al gamb in spâla = Mettersi le gambe in spalla. Camminare con lena.
Métters i bâfi = Mostrare i denti, fare la faccia feroce.
Métters in ghirigàia = Vestirsi accuratamente.
Métter la schénna al mûr = Mettere la schiena al muro. Apprestarsi a combattere.
Métter só= Istigare.
Métter só la pgnâta (la caldarénna, la chèren, ecc.) = Mettere la pentola sul fuoco.
Métter una côsa a durmîr = Mettere da parte; lasciare l’esame di una cosa.
Métt un mât da par sé: al pàinsa la nôt a quall ch’l’ha da fèr al dé = Metti un matto da solo: pensa alla notte a quello che deve fare di giorno.
Mèz pan a Nadèl, mèz vén a Pasqua = Le riserve di grano per la famiglia, dovevano essere a metà per Natale – per il grano – e quelle di vino a Pasqua.
Miclâz, par vander la zander, al brusé i cavâz = Michelaccio, per vendere la cenere, bruciò la legna grossa.
Misêria, mûda bûs = Miseria, cambia buco. Scongiuro.
Mném, mnén = Voce colla quale si chiama il gatto.
Mnèr dla pôzza = Fare cattivo odore.
Mnèstra féssa e prèdica cèra = Minestra fitta e predica chiara.
Mó ch’al mâgna bàin: tant nó qual ch’a i avânza al dân ai ninén = Mangi senza riguardi: tanto noi quello che rimane lo diamo ai maiali. Così il contadino invitava l’ospite a non fare complimenti.
Môrt mé, mûrt tótt = Morto io, morti tutti.
Môrt un Pèpa, fât un èter = Morto un Papa, fatto un altro.
Mó va bàin a radécc’ (o bachétt) = Ma va a radicchi (o a bacchetti). Andare a radicchi o a bacchetti era l’attività dei vecchi e dei bambini. Come dire ma va al diavolo e lasciami stare.
Mubéllia fâta, maré n’acâta = Mobilia fatta, non trova marito. Si riteneva che provvedere troppo presto a dotare la ragazza di corredo, fosse di cattivo auspicio per il matrimonio.
Muntàn, l’ha l’âqua int’al gabàn = Il vento di Ostro porta l’acqua.
Murîr e parturîr, an i é aura = Per morire e partorire non c’è orario.
Musghèr al tatt a só mèder = Morsicare le tette della propria mamma. Si riteneva che i bambini nel succhiare il latte mordessero i capezzoli alla madre. Avrebbero avuto anche una vita sfortunata. Quindi di uno particolarmente sfortunato si diceva. Lu-lé l’ha musghè al tatt a sô mèder. (Quello lì ha mordicato le tette a sua madre).
Mustâz d’impuné = Faccia da impunito. Faccia da delinquente.
Mustrèr una côsa cómm sla fóss una reléquia = Mostrare una cosa come se fosse una reliquia. Fare cadere una cosa dall’alto.
Nadèl al saul, Pasqua al fûgh = Natale col sole, Pasqua col fuoco. Se per Natale farà bel tempo, per Pasqua sarà brutto tempo.
Nadèl al vén saul una vôlta l’ân = Natale viene una sola volta all’anno.
Nadèl coi tû, Pasqua st’vû = Natale coi tuoi, Pasqua se lo vuoi.
Nadèl satta al camén, e Pasqua al suladén = Natale sotto il camino e Pasqua al sole.
Nâser con al cavécc’ = Nascere col cavicchio. Nascere fortunati.
Nâser con la camîsa dla Madôna = Nascere con la camicia della Madonna. Nascere fortunati.
Natt cumpâgn al bastan dal pulèr = Pulito come l’appoggiatoio del pollaio. Di persona molto sporca.
N’avàir lûgh fàirum = Non avere luogo dove stare. Non avere pace.
N’avàir ne lûgh ne fûgh = Non avere né luogo né fuoco (camino). Vivere da vagabondo.
N’avàir un Dio d’un quatrén = Non avere un becco di un quattrino.
Né can, né vilan né râza stôrta, n’asèran mai óss’ né pôrta = Cani, villani e gente malnata non chiudono mai uscio o porta.
Né móll, ne mulén, ne cumpèr cuntadén = I muli, sono animali testardi, i mugnai godevano fama di ladri e i contadini erano testardi e ladri. Almeno così si diceva.
N’èser farénna stièta = Non essere farina pura. Di persona di moralità discutibile.
N’èser gnanch ban ed spazèr al schèrp a ón = Non essere degno di pulire le scarpe ad una persona.
Nès livè, zéi atachè, in cà mî t’an vgnarè = Naso all’insù e sopracciglie attaccate non verranno in casa mia. Il naso all’insù e le sopracciglie unite erano segno di cattivo carattere.
Nèssm’al stàcch, zia Margarétta = Annusami lo stecco, zia Margherita. Triviale. Espressione impertinente.
Nezesitè n’ha lazz = La necessità non ha legge.
Né zói, né dôna, né tàila, an’tôr mai a lûs d’candàila = Non prendere mai gioielli, donna o tela alla luce della candela.
Nôv, nuvàint, anch da spianèr = Nuovo, nuovissimo, ancora da “spianare”. Di cosa appena acquistata e non ancora adoperata.
Ôc’ ai spîguel = Attenzione agli spigoli. Si dice che tale espressione sia nata in occasione dei funerali di una donna: mentre la cassa scendeva le scale portata a spalla dai necrofori, urtò contro lo spigolo del ballatoio e cadde sfasciandosi. Ne uscì la donna, viva e vegeta. Quando, dopo qualche anno, morì nuovamente, il marito raccomandava ai necrofori: A m’arcmând, ragâz, ôc’ al spîguel. (Attenzione, ragazzi, allo spigolo). Pare tuttavia che il detto, in forma diversa, sia molto antico. Il giorno di San Giovanni Battista del 1443, Annibale Bentivoglio tenne a battesimo un figlioletto di Francesco Ghisleri, antenato da Papa Pio V, Santo ed autore del Messale Tridentino. Nel tornare dalla Metropolitana di San Pietro verso la casa dei Ghisleri, Annibale venne aggredito e ucciso da Baldassarre Canetoli, suo nemico. Era un complotto ordito dal Canetoli e dal Ghisleri, la cui abitazione sorgeva circa dove c’era il Cinema Imperiale (Via Indipendenza). Il luogo ove venne ucciso era detto Blîguel (Ombelico) perché era il centro topografico di Bologna, equidistante dalle Porte San Mamolo e Galliera e da quelle di San Felice e di Strada Maggiore.
Ôc’ al blîguel = Attenzione all’ombelico.
Ôc’ an vadd, côr an dôl = Occhio non vede, cuore non duole.
Ôc’ drétt, côr aflétt, ôc’ stanch, côr spasimant = Occhio destro, cuore afflitto, occhio sinistro cuore che spasima (quando batte).
Ôgni ca’ l’ha al césso, al stièr e la ciâvga = Ogni casa ha il gabinetto, il secchiaio e la chiavica. Ogni famiglia ha le sue miserie, anche morali.
O dàint o ganâsa, o bavvér o andghèr = O dente o guancia, o bere o annegare.
Ôgni ca’ un usanza, ôgni blîguel la sô panza = Ogni casa la sua usanza, ogni ombelico la sua pancia.
O che al pazz l’è fand, o che la côrda l’é cûrta = O che il pozzo è fondo o che la corda è corta. Malizioso modo di dire riferito a due sposi che non riescono ad avere figli.
Ôgni chèlz in’tal cûl, pèra inànz un pâs = Ogni calcio nel sedere, spinge avanti un passo.
Ôgni cumié l’é una timpèsta = Ogni commiato è una tempesta. Il cambio di colonia comportava disagi e spese. (Ogni anno i contadini potevano ricevere il commiato ed essere costretti a cambiare terre e padroni).
Ôgni dé, vén sîra = Ogni giorno vien la sera.
Ôgni drétt l’ha al sô arvèrs = Ogni dritto ha il suo rovescio.
Ôgni êrba l’ha la sô virtô = Ogni erba ha la sua virtù. I nostri contadini usavano molto curarsi con presidi di origine vegetale. Alcune di tali piante divennero tristemente famose perché provocavano la morte a chi le ingeriva come infusi, decotti o tinture. Il “prezzemolo” ed il “tasso”, usati come abortivi, furono fra queste.
Ôgni fadîga mèrita prêmi = Ogni fatica merita premio.
Ôgni frût ha la sô stasàn = Ogni frutto ha la sua stagione.
Ôgni lavè l’é una frusté = Ogni lavata è una frustata. A lavare la biancheria troppo spesso, si consuma.
Ôgni maravàjja dûra trî dé = Ogni meraviglia dura tre giorni (dura poco).
Ôgni pacièna la vôl bàin al sô butarén = Ogni ranocchia (grossa rana) vuole bene al suo ranocchio. L’amore materno non si cura della bellezza.
Ôgni stiôp ha la sô mîra = Ogni schioppo ha il suo bersaglio.
Ôli, fèr e sèl, mercanzî reèl = Olio, ferro e sale, mercanzia reale. Erano merci non prodotte nel bolognese e, quindi, ricercate e di elevato valore mercantile. In verità esisteva una piccola terriera a Porchia, vicino a Lizzano in Belvedere.
Ognón tîra l’âqua al sô mulén = Ognuno tira l’acqua al suo mulino.
O magnèr sta mnèstra, o saltèr la fnèstra = O mangiare questa minestra, o saltare dalla finestra.
Ômen a cavâl, fôsa avèrta = Uomo a cavallo, sepoltura aperta.
Ômen alîgher, al zîl l’ajûta = Uomo allegro, il cielo l’aiuta.
Ômen ch’sbadâcia, dôna zàirca = Uomo che sbadiglia, donna cerca.
Ômen làint an ha maj tàimp = Uomo lento non ha mai tempo.
Ômen maridè, usèl in ghèbia = Uomo sposato, uccello in gabbia.
Ômen mèz alass e mèz arôst = Uomo mezzo lesso e mezzo arrosto. Uomo né carne né pesce.
Ômen plaus, o mât o virtuaus = Uomo peloso o matto o virtuoso.
O mói o sótt, par San Lócca as’sammna tótt = Bagnato o asciutto, per San Luca (18 ottobre) si semina tutto.
Ón ch’al tamm al ghéttel = Uno che teme il solletico.
Ón ladén d’bacca = Uno che ha la parola facile.
Ón ladén d’man = Un tipo manesco.
Ónna l’é a la pôrta e cl’ètra a la gabèla = Una è alla porta, l’altra al dazio. Di due persone una peggio dell’altra.
Ónna li pèga tótti = Si paga una volta per tutte.
Ón scavva la lîvra e cl’èter la ciâpa = Uno scova la lepre e l’altro la prende.
Ónzers i bâfi = Ungersi i baffi. Mangiare avidamente (di chi, si solito, mangia poco).
Óra té par mé, e par chi èter s’ai n’é = Prega tu per me e per gli altri se ce n’è.
O sâs o pan: bisaggna avàir quèl pr’i can = O sassi, o pane, bisogna avere qualcosa per i cani.
Óss avèrt, bèda ed ca’ = Uscio aperto, guardia di casa. Gli eventuali malintenzionati, vedendo l’uscio aperto, possono pensare che qualcuno sia in casa.
Ôv’d’un’aura, pan d’un dé, vén d’un ân, mujèr d’queng’an e amîga ed tràinta = Uovo di un’ora, pane di un giorno, vino di un anno, moglie di quindici anni e amante di trenta. Una variante: Ôv’d’un’aura, pan d’un dé, vén d’un ân, mujèr ed quéng, amîga ed tràinta e prît ed’ssanta = Per prudenza il prete vuole di sessanta.
Pàinsa ed’tè, e pó dscarr ed mé = Pensa di te, e poi parla di me. Rifletti prima di parlare male degli altri.
Paghèr sauvra l’óngia = Pagare sull’unghia. Forma di pagamento immediato e in contanti che si usava per le vendite di bestiame senza garanzia. Anche: Paghèr in stadîra = La “Stadîra” era un tipo di bilancia a leva oggi non più in uso).
Pâja e stappa, luntàn dal fûgh = Paglia e stoppa lontano dal fuoco.
Pan bûs e furmâi ciûs = Pane poroso (lievitato bene) e formaggio senza vuoti.
Pan co’i ûc’, furmâi sàinz’ûc’ e vén ch’sèlta a i ûc’ = Pane con gli occhi, formaggio senz’occhi e vino che salta agli occhi.
Pan côt e pan bujé, tîra una vassa e tl’è padé = Pancotto e pan bollito, fai una scoreggia e l’hai digerito. Sono due cibi che non nutrono.
Pan crass, fa quali che Dio at déss, vén èlt cómm una muntâgna, savuré cómm una castâgna = Pane cresci, fa quello che Dio ti disse, diventa alto come una montagna e saporito come una castagna. Era la formula di rito. Il pane, impastato con acqua tiepida e lievito, veniva riposto nella “Spartûra” (Madia) e la “Zdâura”(La reggitrice della casa) toltasi la “Vargatta” (Anello nunziale, fede) lo segnava con una croce tenendo la fede stessa tra il pollice e l’indice della mano destra. Il mattino dopo l’impasto veniva cotto nel forno a legna del cortile.
Pan e nûs, magnèr da spûs: nûs e pan, magnèr da can = Pane e noci, mangiare da sposi (cibo da sposi), noci e pane cibo da cane.
Pan e ragazû i an da èser fât in ca’ = Pane e bambini debbono essere fatti in casa.
Pan e turtî, quand i én cût i én tótt bî = Pane e tortellini, quando sono cotti sono tutti belli.
Pan frasch, carsàint e vén daulz: trai côs ch’al dûren pôch = Pane fresco, crescente e vino dolce, sono tre cose che durano poco (perché molto graditi).
Pan furmâi e vén, magnè da cuntadén = Pane, formaggio e vino, cibo da contadino.
Pan, unbrèla e gabàn, tûi con tè in viâz = Pane, ombrello e gabbano, porta con te in viaggio.
Panirénna, panirénna, qualla é vûda e qualla é pénna? = Gioco che si faceva ai bambini piccoli nascondendo una chicca in uno dei pugni chiusi e lasciando indovinare al bambino.
Pan sótt fa bel pótt; pan con quèl a’le fa pió bèl = Pane asciutto (senza companatico) fa il bel ragazzo; pane con qualcosa (companatico) lo fa ancora più bello.
Panza agózza, an pôrta scóffia = Ventre appuntito, non porta cuffia. Si riteneva che la gestante di una femmina dovesse avere il ventre tondo, mentre quella di un maschio piuttosto appuntito.
Panza tanda l’é una fammna, panza agózza, l’é un mâsti = Pancia tonda è una femmina, pancia appuntita è un maschio. Quando in casa vi era una gestante, si faceva un gioco con lo sterno di un pollo. Due commensali prendevano l’osso per le estremità ed uno dei due teneva per la gestante. Si tirava, quindi, l’osso fino a romperlo. Se la testa dell’osso (Scóffia) rimaneva dalla parte di chi teneva per la gestante, il neonato sarebbe stato una femmina, altrimenti, un maschio.
Paràir la lónna d’agast = Sembrare la luna d’agosto. Avere la faccia larga e paffuta.
Par cgnósser un Bulgnàis, ai vôl un ân e un màis: pó, quand tl’é bàin cgnussó, l’é un gran baran futó = Per conosce un Bolognese, ci vuole un anno e un mese; poi quando l’hai conosciuto, è un gran barone fottuto. La gente verso la Romagna non aveva simpatia per i Bolognesi.
Paràir un bégh int’una zócca. Altra forma: Paràir un burdigàn int’un fiâsch = Sembrare un bigatto (maggiolino) in una zucca. Sembrare uno scarafaggio in un fiasco. Col nome “Burdigàn” i contadini indicavano diversi insetti forniti di elitre o semi elitre come blatte, maggiolini, ecce. I bambini di campagna si divertivano a mettere gli insetti dentro a un fiasco o altro recipiente di vetro per ascoltare il forte brusio che facevano nel tentare di uscire.
Par caminèr ai vôl dal bôni gamb = Per camminare ci vogliono delle buone gambe.
Par Caranvèl, ôgni schêrnia vèl = Per Carnevale ogni beffa vale.
Par cgnósser ón, bisaggna magnèr insamm una côrba ed sèl = Per conoscere una persona si deve mangiare insieme una corba di sale (per mangiare una corba di sale ci vogliono anni).
Par cunzèr l’insalè, ai vôl quâter ômen: un sèvi’ch’cl la sèla, un strasinàn ch’ai métta l’ôli, un grécc’ ch’ai métta l’asà e un mât ch’al l’armâsda = Per condire l’insalata ci vogliono quattro uomini: un savio che metta il sale, uno sciupone che metta l’olio, un avaro che metta l’aceto e un matto per mescolarla.
Par dîs e dû dagg’ = Per dieci e due dodici. Imprecazione detta per evitare di bestemmiare.
Parént, serpént = Parenti, serpenti.
Par fèr un provérbi a’i vôl zàint ân = Per fare un proverbio ci vogliono cento anni.
Par fôrza as’fa l’asà = Per forza si fa l’aceto.
Par la bacca se schèlda al faurén = Per la bocca si scalda il forno. È vero le fascine per scaldare il forno, si introducono dalla bocca dello stesso. Così il cibo, introdotto per bocca, fornisce calorie all’uomo.
Par l’ân nôv, tótti al galén fan l’ôv = Per l’anno nuovo tutte le galline fanno l’uovo.
Par l’ân nôv, sèlt ed bôv. Par l’Epifàgna, sélt ed càgna. Par Sant’Antôni, mezàura bôna = Per l’anno nuovo (Capodanno), un salto di bue. Per l’Epifania, un salto di cagna. Per Sant’Antonio (17 gennaio) mezzora buona. Riguarda l’allungarsi delle giornate dopo il solstizio d’inverno.
Par la Pasquatta, al Caranvèl al sbacatta = Per Pasquetta (Epifania), il Carnevale impazza. Il Carnevale inizia proprio il giorno dell’Epifania.
Par la Vciatta un’uratta; pr’al Vcian un’aura natta = Per la vecchietta (l’Epifania – 6 gennaio) il giorno si allunga di un’ora scarsa; per il vecchione (Sant’Antonio – 17 gennaio) di un’ora abbondante.
Par l’Inzariôla, o ch’al nàiva o ch’al piôva da l’invéren a san fôra; e s’a i é al suladèl a i n’avan anch pr’un msarèl = Per la Candelora (2 febbraio), se nevica o se piove, siamo fuori dall’inverno; ma se c’è il sole, ne abbiamo ancora per un mesetto.
Par l’Inzariôla, màina al can a l’ôra e se al saul al da in’tal zèd, d’inverén a san a mèz = Per Candelora (2 febbraio) conduci il cane all’ombra (il sole comincia a scottare), se il sole batte sulle siepi, siamo a metà dell’inverno.
Parnîs settembrénna, ónna par maténna = Pernice settembrina, una per mattina. Nel mese di settembre le pernici (starne) sono già completamente sviluppate e già smaliziate e, quindi, più difficili da cacciare.
Par San Barnabà, al furmàint pèrd al pa = Per San Barnaba (11 giugno) il grano prede il piede, cioè la radice.
Par San Barnabà, l’û vèn e al fiaur va = Per san Barnaba (11 giugno), l’uva viene e il fiore se ne va. Cadono i fiori della vite e inizia la granigione degli acini.
Par San Bandatt as’agnóss al vàird dal sacch = Per San Benedetto (21 marzo) si conosce il verde dal secco. Le piante vive cominciano a vegetare.
Par râbia ed fâm, un can al magné una zavâta = Per rabbia di fame, un cane mangiò una ciabatta.
Par Pasqua e par Nadèl, gâl e galén al sô pulèr = Per Pasqua e per Natale, galli e galline al loro pollaio.
Par Pasqua e par Nadèl, zàint e galén al sô pulèr = Per Pasqua e per Natale, gente e galline al proprio pollaio.
Pa mé l’é pèra anch tragg’ = Per me è pari anche tredici.
Par San Bartlâz, fa busèr al tinâz = Per San Bartolomeo (Apostolo – 24 agosto) prepara il tino (per il mosto). Preparare il tino voleva dire riempirlo d’acqua in modo che le doghe, rigonfiandosi, tenevano bene i liquidi del mosto.
Par San Bastiàn, la tramma la cô al can = Per San Bastiano (da Roma – 20 gennaio) trema la coda ai cani (per il freddo).
Par San Gâl, as’sammna anch int’la vâl = Per San Gallo (16 ottobre), si semina anche nella valle. Bisogna affrettarsi a seminare.
Par San Gâl, a summnèren un stèr a s’in cói un car = Per San Gallo (16 ottobre) a seminarne uno staio, se ne raccoglie un carro. Era considerato giorno molto propizio alla semina del grano.
Par San Jàcum e Sant’Âna, la lîga la castâgna = Per San Giacomo (25 luglio) e Sant’Anna (26 luglio), allegano le castagne.
Par San Jusèf, a zanna e a lèt = Per San Giuseppe (19 marzo), a cena e poi a letto. Le giornate lavorative si allungano e non resta tempo per le veglie nelle stalle, quindi, a cena e poi a letto.
Par San Lócca as’sammna tótt, mói o sótt = Per San Luca (18 ottobre) si semina tutto, bagnato o asciutto (che sia il tempo). La stagione della semina volge alla fine.
Par San Lócca chi ha di marón al plócca e chi n’ha brîsa a se splócca la camîsa = Per San Luca (18 ottobre) chi ha dei marroni se li lecca e chi non ne ha si strappa la camicia.
Par San Lócca, chi n’ha summnè a se splócca = Per San Luca (18 ottobre) chi non ha seminato si dispera (si strappa i capelli).
Par San Luràinz, l’inverén ha méss un dàint = Per San Lorenzo (10 agosto), l’inverno ha messo un dente.
Par San Martén, al furmàint sta méi int’al câmp che al mulèn = Per San Martino (11 novembre) il grano sta meglio nel campo (cioè seminato) che al mulino.
Par San Martén, al mast é vén = Per San Martino (11 novembre) il mosto (diventa) vino.
Par San Martén a se ftéss grand e cén = Per San Martino (11 novembre) si coprono i grandi e i piccoli.
Par San Martén a s’imbarièga grand e cén = Per San Martino si ubriacano adulti e bambini.
Par San Martén as’manda vî i cuntadén = Per San Martino si mandano via i contadini. L’11 novembre era il giorno dei cambi di colonia.
Par San Martén, as métt al schèrp ai grand e ai cén = Per San Martino, si mettono le scarpe agli adulti e ai bambini. Spesso, prima di mettersi le scarpe, i contadini arrivavano al giorno di Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre).
Par San Martén, as’trâ al ban vén = Per San Martino si spina il vino buono.
Par San Martén as tramûda i bón vén = Per San Martino si travasano i buoni vini.
Par San Martén avérra la batt e sént al vén = Per San Martino, apri la botte e assaggia il vino.
Par San Martén i bavvn al vén i grand e i cén = Per San Martino, bevono il vino gli adulti e i bambini.
Par San Martén, marón e vén = Per San Martino, marroni e vino.
Par San Matî, nàiv par strè o par vî = Per San Mattia (24 febbraio), la neve è per strada o per la via.
Par San Michîl, al zîzel int’al panîr = Per San Michele (29 settembre) la giuggiole nel paniere. Si raccolgono le giuggiole.
Par San Pîr, i fîgh int’al panîr = Per San Pietro (29 giugno) i fichi nel paniere. Maturano i primi fichi, i “fioroni” e si raccolgono.
Par San Ptrôni e San Franzàsch, chi n’ha la panîra, adrôva al zàst = Per San Petronio e San Francesco, chi non ha il paniere, usi il cesto. (4 ottobre – E’ tempo di affrettare la vendemmia).
Par San Siman, stâca i bû d’int’al timan = Per San Simone (28 ottobre) stacca i buoi dal timone. Sono finiti i lavori dei campi.
Par Santa Catarénna, la nàiv int’la culénna = Per Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre), la neve sulla collina.
Par Santa Catarénna, o ch’al nàiva, o ch’al brénna, o ch’a i é la paciarénna = Per Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre), o neve, o brina o fanghiglia.
Par Santa Catarénna, rimpéss al sâch dla farénna = Per Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre), riempi il sacco della farina. Cioè porta il grano a macinare perché potrebbe cadere la neve ed impedire il trasporto del grano al mulino.
Par Santa Catarénna, tîra fôra la fasénna, parché al nàiva o al brénna = Per Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre), prepara la fascina perché o nevica o brina.
Par Santa Cràus, furmàint spigàus = Per Santa Croce (3 maggio) il grano fa la spiga.
Par Santa Cràus, o moj o tàus = Per Santa Croce (3 maggio) o bagnata o tosata. Si riferisce alla tosatura delle pecore che veniva fatta nei primi giorni di maggio. Pertanto il 3 maggio le pecore o erano bagnate per la tosatura o erano già tosate.
Par Santa Cràus, as pôrta la mranda al taus = Per Santa Croce (3 maggio) si comincia a portare la colazione a chi lavora nei campi.
Par Sant’Ermàn, s’an piôv incû, piôv edmàn = Per Sant’Ermanno (7 aprile) se non piove oggi, piove domani.
Par Santa Luzî, al dé al córr vî = Per Santa Lucia (13 dicembre), il giorno (la luce) corre via. Prima della riforma Gregoriana era il giorno più corto dell’anno.
Par Santa Madalàina, as’mèd l’avàina = Per Santa Maddalena (22 luglio), si miete l’avena.
Par San Tmès, la gazza al nès = Per San Tommaso, la goccia al naso. Di santi Tommaso è pieno il calendario. Nel caso di specie, si dovrebbe pensare a San Tommaso di Canterbury (29 dicembre) o a San Tommaso d’Aquino (28 gennaio), perché gli altri santi omonimi (San Tommaso Apostolo (3 luglio), San Tommaso da Cantalupo (9 agosto), San Tommaso da Villanova (22 settembre), San Tommaso Moro (22 giugno), non cadono in stagioni da goccia al naso. Escluderei S. Tommaso da Cori (11 gennaio) perché, pur cadendo in epoca adatta, era in pratica sconosciuto da noi.
Par San Tmès, tîra al tôch pr’al nès = Per San Tommaso tira il collo al tacchino. E’ difficile stabilire quando si dovesse tirare il collo al povero tacchino a causa della grande dovizia si santi con quel nome: Tommaso Apostolo (3 luglio), Tommaso d’Aquino (28 gennaio), Tommaso da Canterbury (29 dicembre), Tommaso da Cori (11 gennaio), Tommaso Moro (22 giugno). Opinerei per l’ultimo per analogia della morte: infatti a San Tommaso Moro fu tirato – anzi tagliato – il collo da Enrico Ottavo.
Par San Valentén, la premmavàira l’é avsén = Per San Valentino (14 febbraio) la primavera è vicina.
Par San Valentén, se stréccha i filarén = Per San Valentino (14 febbraio) festa degli innamorati, si abbracciano i filarini.
Par San Vinzinzén, sl’é un bèl dé, al sra ban al vén = Per San Vincenzo, se è un bel giorno (se è sereno), il vino sarà buono. Tra i numerosi santi che portano questo nome (S, V Gerosa (5 giugno), S.V. Diacono (22 gennaio), S.V. di Bevagna (14 novembre), S. V. Lérins (24 maggio), S.V. Ferreri (5 aprile) e S. V. de’ Paoli (27 settembre). Si dovrebbe ritenere che il proverbio si riferisca a quest’ultimo perché cade all’epoca della maturazione dell’uva.
Par stèr in cunpagnî, un frè al tûls mujèr = Per stare in compagnia, un frate prese moglie.
Par tótt i Sant, fora la caparèla e i guant = Per Ognissanti (1 novembre) fuori la capparella (un specie di mantello senza maniche e molto largo) e i guanti.
Patêr = Padrenostro. Biasèr di patêr = Lett. Masticare dei Pater. Recitare preghiere come se si masticasse.
Part tót i Sant, capot e guant = Per Ognissanti (1 novembre), cappotto e guanti.
Par trést ch’al séppa mèrz, i can i van a l’ôra = Per quanto sia cattivo marzo, i cani vanno all’ombra.
Pass côt e chèren crûda = Pesce cotto e carne cruda. Regola culinaria.
Pchè cunfsè, mêz pardunè = Peccato confessato, mezzo perdonato.
Péccia int’la fâza, bèla ragâza, péccia int’al côl, bèl ragazôl = Neo sulla faccia, bella ragazza, neo sul collo, bel ragazzo.
Pèdga ed bîstia e d’cristiàn, n’arvénnen brîsa al gran = Orme bovine ed umane non rovinano i seminati di grano.
Pén cmôd un ôv; vûd cmôd un clarinàtt = Pieno come un uovo; vuoto come un clarinetto. Di persona di molta apparenza e di poca sostanza.
Pén ed dèbit cumpâgn una lîvra = Pieno di debito come una lepre. Non si capisce perché una lepre debba essere piena di debiti. Forse perché fugge sempre come un debitore.
Perasó= Accompagnatore del bestiame al mercato.
Pêsga, fîgh e mlan a ni é gnént ed pió ban = Pesca, fico e melone, non c’è nulla di più buono.
Pèt pigrén, lât fén = Petto pecorino, latte fino.
Piantèr barâca e buratén = Piantare baracca e burattini. Lasciare perdere tutto e andarsene.
Pîgra bîsa, pîgra bianca, chi môr môr, chi campa campa = Pecora grigia, pecora bianca, chi muore muore e chi campa campa.
Pió che vîc’, an’s’campa = Più che vecchi non si campa. Oltre una certa età, non si può vivere.
Pió fómm che lasâgn = Più fumo che lasagne. Molto fumo e poco arrosto.
Pisèr d’fôra da l’urinèri = Fare pipì fuori dal vaso. Intervenire a sproposito. Dire cose inopportune.
Pisèr spass e caghèr dûr, al tén luntan i dutûr = Pisciare spesso e cagare duro, tiene lontano i dottori. Norma igienica quotidiana.
Pistèr l’âqua int’al murtèr = Pestare l’acqua nel mortaio. Fare una cosa inutile.
Pr’al mèl dla cagarèla, an’vèl tgnîr strécch al cûl = Per la diarrea, non vale stringere lo sfintere.
Pr’al sótt, tótt i én bón d’andèr = Sono tutti capaci di camminare all’asciutto.
Pr’andèr in Paradîs a’i’é la strè di spén = Per andare in Paradiso, bisogna percorrere la strada degli spini.
Preghèr i mûrt par freghèr i vîv = Pregare i morti per fregare i vivi.
Prezîsa al brègh ed Dèlmo = Uguale alle braghe di Delmo. Una cosa che torna a puntino. Una cosa uguale all’altra.
Pr’i dû e i trîd’avréll, al cócch l’é int’i bréll: s’al n’arîva tra al sêt l’ôt, al cócch l’é bèl e côt = Al due o al tre di aprile il cuculo è tra i salici: se non arriva tra il sette e l’otto, il cuculo è bello e cotto (cioè è stato ucciso e mangiato).
Pr’imbruièr un cuntadén, ai vôl un èter cuntadén = Per imbrogliare un contadino, ci vuole un altro contadino.
Prît e frê, sôr e galén, an sàimper fâm = Preti, frati, suore e galline hanno sempre fame.
Prît e frê, d’caritè i én prîv: i prèghen i môrt par freghèr i vîv = Preti e frati di carità sono privi: pregano i morti per fregare i vivi.
Pri vîc’ én brótt trî C: caschè, catâr, e cagarèla = Per i vecchi sono brutte tre C: cadute, catarro e cagarella (diarrea).
Pr’una bôna ustarî, ai vôl una bôna insaggna = Per una buona osteria, ci vuole una buona insegna.
Pr’una busî a n’é mai môrt inción = Per una bugia, non è mai morto nessuno.
Pr’una vôlta la s’fa a sô pèder = Per una volta si può imbrogliare anche il proprio padre.
Pr’un caulp ed manèra, an’câsca l’âlber = Per un colpo di accetta, non cade l’albero. Non basta un colpo di accetta per abbattere l’albero.
Pruvêrbi an fâla = Il proverbio non sbaglia.
Pruvidàinza ed Dio, intarès ed prît e fâm ed can da cuntadén, agl’én trai côs c’al n’ha mai fén = Provvidenza di Dio, interessi di preti e fame di cane da contadino, sono tre cose senza fine.
Pulàint e âqua ed fôs, lavaura tè, padran, che mé an pôs = Polenta e acqua di fosso, lavora tu, padrone, che io non posso. Come dire, polenta ed acqua sono poco sostanziosi.
Pulàint ed furmintàn, misdè con al bastàn, svultè so pr’al tulîr, l’é un magnèr da cavalîr = Polenta di mais, mescolata col bastone, rovesciata sul tagliere, è un cibo da cavaliere. I contadini però non erano d’accordo, ritenevano la polenta un cibo privo di sostanza. (Vedi il proverbio precedente).
Purtèr l’âqua con gli uràcc’ = Portare l’acqua con le orecchie. Essere molto servizievole.
Purtèr la lómm = Portare il lume.
Quall ch’al pèga l’ôli = Colui che paga l’olio, cioè chi mantiene la famiglia. In particolare si diceva: Ló, lî e cl’èter, quall ch’al pèga l’ôli = Lui, lei e l’altro, quello che paga l’olio, cioè l’amante danaroso della moglie.
Quall ch’an va in bóst, va in mandgh = Quello che non va nel busto, va nelle maniche. Quello che non si consuma da una parte, si consuma dall’altra.
Quall ch’as fa ai èter, al vén fât a nó = Quello che si fa agli altri, viene fatto a noi.
Quall ch’as fa al prémm dé dl’ân, as fa tótt l’ân = Quello che si fa il primo giorno dell’anno, si fa tutto l’anno.
Quall ch’bói int’la pgnâta al le sa al quêrc’ = Quello che bolle nella pentola, lo sa (solo) il coperchio.
Quall ch’é fât par fôrza, an vèl una scôrza = Ciò che si fa per forza, non vale una corteccia. Ciò che si è costretti a fare, non ha valore.
Quall ch’la dôna vôl, Dio al le pôl = Quello che la donna vuole, Dio lo può.
Quall ch’é in t’i camp, l’é ed Dio e di Sant = Quello che è nei campi, è di Dio e dei Santi. Giustificazione del furto rurale.
Quall ch’é int’al bôsch, l’é dal prémm ch’ai sèlta adôs = Quello che è nel bosco è del primo che gli salta addosso (del primo che raccoglie). Giustificazione del furto rurale. Il proverbio è di viva attualità. Spesso i cittadini si riversano nelle campagne (con la scusa della gita) e rubano, castagne, frutta, strappano fiori degli alberi da frutta, con grande costernazione dei legittimi proprietari che aspettano un anno per raccogliere il frutto delle loro fatiche.
Quall ch’l’armisdèva l’âqua int’al parôl sàinza avàir la farénna da méttri dàinter, an’fé brîsa la pulàint = Colui che mescolava l’acqua nel paiolo senza la farina da metterci dentro, non fece la polenta. Proverbio molto triste, purtroppo, vero in molti casi, se non per i contadini certo, ma per i braccianti.
Quall ch’tén al fradd, tén anch al chèld = Ciò che ripara dal freddo, ripara anche dal caldo. I contadini non usavano spogliarsi troppo per il caldo, specialmente le donne si coprivano, nei campi, con fazzoletto in testa e cappello di paglia a tesa larga, con gonne lunghe e portavano spesso anche i mezzi guanti, ciò anche perché l’essere abbronzati era considerato incivile e le donne desideravano avere: La pèl zentîla (La pelle gentile), cioè bianca.
Quall ed Munzón, che par fèr dspèt a la mujêr, as tajé i marón = Quello di Monzuno, che per fare dispetto alla moglie, si tagliò i testicoli. Fece il sacrificio di Origene.
Quand a’i câla i bajûch a i crass l’armaur = Quando calano i soldi, cresce il rumore. Nei periodi di miseria crescono i contrasti in famiglia.
Quand a’i é la salût a i é incôsa = Quando c’è la salute c’è ogni cosa.
Quand al nâs un Fraràis, ai nâs un móll al Marcàis = Quando nasce un Ferrarese, nasce un mulo al Marchese. Il proverbio è certamente molto antico. Il riferimento agli Estensi è molto evidente. Gli Este, infatti, ebbero il titolo di Marchesi sino alla metà del XV Sec, quando Borso nel 1451 ebbe il titolo di Duca di Modena e Reggio dall’Imperatore Federico III. Il titolo per Ferrara lo ebbe poi, nel 1491 da Papa Paolo II.
Quand al canta al mèrel, a san fôra dl’invèren = Quando canta il merlo, siamo fuori dall’inverno.
Quand al dôn i v’l’han zurè, stè pûr zèrt ch’an la scapè = Quando le donne ve l’hanno giurato, state pur certi che non riuscirete a scapparla.
Quand al fónz abânda, al furmàint afânda = Quando il fungo abbonda, il grano affonda. Il fungo abbonda negli anni piovosi, poco propizi alla produzione del grano. I vecchi agricoltore bolognesi temevano di più l’abbondanza di pioggia, che la siccità.
Quand al furmàint fa la spîga, sta luntan da l’amîga: al tàimp da l’û, fén t’in vû = Quando il grano fa la spiga, stai lontano dall’amica: al tempo dell’uva (vendemmia), fallo finché vuoi. Quando spiga il grano, in maggio, comincia il caldo e vi sono lavori faticosi da compiere; al tempo della vendemmia è meno caldo e i lavori sono meno faticosi. Norma di igiene sessuale.
Quand al furmàint l’é manch vàird dla spâgna, al cuntadén pôch pan al mâgna = Quando (in primavera) il grano è meno verde dell’erba medica, il contadino mangia poco pane. Infatti è sinonimo preciso che il grano seccherà presto con cariossidi poco nutrite.
Quand al gâl canta da galénna, al pulèr al va in arvénna = Quando il gallo canta da gallina, il pollaio va in rovina. Un gallo canta come una gallina, quando gli sono stati tolti i testicoli. Non ci saranno pulcini.
Quand al gât al dôrum int’la zander dla fûga, an’s’mâgna brîsa = Quando il gatto dorme nella cenere del focolare, vuol dire che non si mangia.
Quand al manca al gât, i póndgh i balén = Quando non c’è il gatto, i topi ballano.
Quand al mérel cantarà, alaura crèdit as’farà = Quando il merlo canterà, allora credito si farà. Certi osti e bottegai di campagna usavano esporre un cartello col ritratto di un merlo e la scritta riportata. Ciò per evitare risposte sgradevoli agli avventori e sorprese all’oste.
Quand al nàiva in’vatta a la fójja, d’invèren a s’in fa vójja = Quando nevica sulla foglia, dell’inverno si fa voglia. La neve precoce prelude ad un inverno mite.
Quand al nóvvel al van a l’insó, tû la scrâna e sédi só = Quando le nubi vanno verso Sud, prendi la sedia e mettiti a sedere.
Quand al nóvvel al van a l’inzà, tû i bû e mètti al za = Quando le nubi vanno verso Nord, prendi i buoi e aggiogali.
Quand al nóvvel al van ed travêrs, tû i bû e métti a cuêrt = Quando le nubi vanno di traverso, (cioè verso Est od Ovest) prendi i buoi e mettili al coperto (nella stalla).
Quand al nóvvel al van da sîra, tû la racca e fîla = Quando le nubi vanno verso sera (Ponente), prendi la rocca e fila.
Quand al nóvvel al van da maténna, tû al sâch dla farénna = Quando le nubi vanno verso mattina (Levante), prendi il sacco della farina.
Quand al nóvvel al van da dman, tû al sâch e fa pan = Quando le nubi vanno verso domani (?), prendi il sacco (della farina) e fai il pane.
Quand al nûs agl’én a castlàtt, la va mèl pr’al puvràtt = Quando le noci sono a castelletto, va male per il poveretto. Le noci, di solito, allegano sul ramo due a due. In certi anni allegano invece tre a tre ed anche quattro a quattro (a castelletto). Ciò era ritenuto presagio di annata agraria sfavorevole.
Quand al pâs afânda, al furmàint abânda = Quando il passo affonda (in primavera per il fango), il grano abbonda.
Quand al piôv al dé dl’Inzariôla, da l’invêren a sàin fôra = Quando piove il giorno della Candelora (2 febbraio) siamo fuori dall’inverno.
Quand al piôv, a s’fa l’ôvra a stèr a lèt = Quando piove è meglio stare a letto e riposare per le fatiche che verranno dopo.
Quand al piôv con al saul, tótt i vîc’ van in amaur = Quando piove col sole, tutti i vecchi vanno in amore. Vecchia credenza diffusissima.
Quand al piôv int’al manèl, as’armasda al matarèl = Quando piove nelle mannelle si rimescola il mattarello. L’interpretazione è discutibile. Probabilmente si riferisce al raccolto del grano, quando la pioggia sulle mannelle non ancora raccolte in covoni, provoca, o meglio provocava, un danno grave al raccolto. Se così è, l’interpretazione più logica pare la seguente: lo scarso raccolto di grano obbliga il contadino a mangiare polenta anziché pane. Con ciò la massaia deve rimescolare il mattarello nel paiolo per cuocere la polenta. Altra interpretazione è quella che si riferisce alla macerazione della canapa, quando i fasci, e quindi le mannelle, sono stati affondati nell’acqua del macero, il raccolto della canapa è al sicuro dalla grandine e dal vento e la massaia può tranquillamente preparare la polenta.
Quand al piôv la zôbia grâsa, dl’érba a in vén’na mâsa = Quando piove il giovedì grasso, verrà molto foraggio.
Quand al puvràtt regâla al sgnaur, al rédd al dièvel = Quando il povero regala al ricco, il diavolo ride.
Quand al saul as’vôlta indrî, una bèla maténna ai tén drî= Quando il sole si volta indietro (si fa vedere fino al tramonto) la mattina seguente sarà serena.
Quand al saul dà in t’la candàila, una bèla premmavàira = La candàila è il giorno di Candelora (2 febbraio). Se è sereno si prevede una bella primavera.
Quand al sbât l’ôc’ drétt, côr aflétt: quand al sbât l’ôc’ stanch, côr franch = Quando batte l’occhio destro, cuore afflitto; quando batte l’occhio sinistro, cuore franco.
Quand al Sgnaur sèra una fnèstra, l’avérra una pôrta = Quando il Signore chiude una finestra, apre una porta.
Quand al’s’innóvla saura la brénna, s’an nàiva incû, nàiva dmatténna = Quando si rannuvola sopra la brina, se non nevica oggi, nevica domani mattina.
Quand al trauna, l’é al dièvel ch’va in carôza = Quando tuona è il diavolo che va in carrozza. Lo dicevano le mamme ai bambini durante i temporali.
Quand al vilàn é int’al fîgh, an’cgnós nè parént né amîgh = Quando il villano è nel fico, non conosce né parenti né amici. Quando il contadino gode di benessere non conosce parenti o amici (diventa egoista).
Quand al zîl fa la lèna, s’an piôv incû, piôv in’t’la stmèna = Quando il cielo fa la lana, se non piove oggi, piove in settimana. Cielo a pecorelle, acqua a catinelle.
Quand a’n’é pió, tótt i’han avó la só pèrt = Quando non ce n’è più, tutti hanno avuto la loro parte.
Quand al zîzel al se vtéss, spóiett; quand al zîzel al se spója, vtésset = Quando il giuggiolo si veste (mette le foglie), spogliati; quando il giuggiolo si spoglia, vestiti.
Quand’a sàin stè al lighèr dal strôp = Lett.: Quando siamo giunti al momento di legare i salici, vale però per: quando siamo giunti alla fine del lavoro.
Quand a sàin in dû a ragagnèr, al vénz quall ch’al n’ha gnént da fèr = Quando siamo in due a litigare, vince quello che non ha niente da fare. Tra i due litiganti il terzo gode.
Quand a s’é mât a la sîra, a s’é mât anch a la maténna = Quando si è matti alla sera, lo si è anche al mattino dopo.
Quand a s’é sfraschè, as’vadd quall ch’i han fât i bigât = Quando si è tolto il “bosco”, si vede quello che hanno fatto i bachi. Al termine della loro vita larvale, i bachi da seta salivano al bosco (un complesso di frasche predisposto dalla massaia) per subire la metamorfosi, trasformarsi cioè in crisalidi dentro al bozzolo (dialetto: flusèl). Solo al termine della metamorfosi la massaia, togliendo la frasca, poteva constatare la buona o la cattiva riuscita della metamorfosi (il bozzolo era lo stadio commerciale del baco). Il proverbio vale come: solo al termine dell’opera, se ne vede l’esito.
Quand as’mèd con al zibàn, as’rimpéss al sacadàn = Quando si miete col giubbone (cioè col freddo), si riempiono dei grandi sacchi.
Quand canta al bôt, lóngh i dé quant’al nôt = Quando canta il rospo, il giorno è lungo quanto la notte (seconda metà di marzo).
Quand canta al cócch, a i é da fèr par tótt = Quando canta il cuculo, c’è da fare per tutti. Il cuculo arriva da noi ai primi di aprile, quando cominciano i lavori grossi dei campi.
Quand canta al cócch, la maténna mój, la sîra sótt = Quando canta il cuculo (aprile), la mattina bagnato (per la rugiada) e la sera asciutto.
Quand canta al gâl int’al pulèr, al tàimp as’vôl guastèr = Quando il gallo canta (stando) nel pollaio, si guasta il tempo.
Quand canta la garlûda, al tàimp al mûda = Quando canta tordela, il tempo cambia. Garlûda: Tordela (Turdus viscivorus). Grosso tordo, un tempo molto frequente nelle alberate ed ora quasi scomparso.
Quand dû i litîghen, al tèrz al gôd = Quando due litigano, il terzo gode.
Quand gôd al côrp, la bisâca la zîga = Quando gode il corpo, la tasca piange.
Quand i usî van a branch, al cambia al tàimp = Quando gli uccelli vanno a branchi, cambia il tempo. Gli uccelli volano di solito a branchi alle epoche delle migrazioni (col cambio delle stagioni).
Quand la bèrba la fa al stupén, lâsa al dôn e bavv dal vén = Quando la barba diviene brizzolata, lascia le donne e bevi del vino.
Quand la crass la bôria, cala la furtónna = Quando cresce la superbia, cala la fortuna.
Quand la galénna la zîga, l’é saggn ch’a i é al nébbi = Quando la gallina piange, il nibbio è in giro.
Quand la lómm la fa al stupén, l’âqua l’é avsén = Quando il lume fa lo stoppino, l’acqua è vicina. Si trattava del lume ad olio, quando l’aria era umida, fumava.
Quand la mèrda la manta in scân, la pózza e la fa dân = Quando la merda monta in scanno, puzza e fa danno. Gli scanni sono quelli dei parlamentari, dei giudici, dei canonici, ecc.
Quand la nóvvla fa la gratûsa, o cla bagna o cla brûsa = Quando la nuova diventa come una grattugia o piove o fa gran caldo. Quando il cielo è a pecorelle o piove o viene un gran caldo.
Quand la pàira é madûra, bisaggna cla crôda = Quando la pera è matura, deve cadere.
Quand la picàja la’s’frósta, l’ânma la s’ajósta = Col passare degli anni e col diminuire degli stimoli sessuali, l’uomo e le donna pensano più all’anima che al corpo.
Quand la pgnâta é al fûgh, al cûl n’è mai a lûgh = Quando la pentola è al fuoco, la massaia non può mai mettersi a sedere.
Quand l’âqua la fa i gargói, lâsum piôver insénn ch’a vój = Quando l’acqua fa i gorghi (piove molto forte), lasciami piovere fin che voglio.
Quand l’aria l’é rassa, o ch’la péssa o ch’la sappia = Quando l’aria è rossa, o piove o tira vento.
Quand l’arîva l’Epifanî, tótt al fèst ai pôrta vî; po’l’arîva San Bandatt, che al fèst al n’ha un sacatt = Quando arriva l’Epifania, tutte le feste porta via; poi arriva San Benedetto (23 marzo), che delle feste ne ha un sacchetto.
Quand la sauna l’Evmarî, chi ha dl’educaziàn al vaga vî = Quando suona l’Avemaria, chi ha educazione vada via. L’ospite educato deve andarsene al suono dell’Avemaria (sul far della sera).
Quand l’as’marîda una vaddva, al môrt l’é sàimper par ca’ = Quando si risposa una vedova, il morto è sempre in casa. Il matrimonio di una vedova era, in genere, malvisto. La sera delle nozze, la gente dei dintorni, munita di pentole, coperchi e simili strumenti, improvvisava una serenata di scherno sotto le finestre degli sposi. Si diceva Fèr la maitinè.
Quand la va bàin, tótt i san condûser = Quando va bene, tutti la sanno condurre.
Quand la zighèla zîga, gnént amîga = Quando la cicala piange (canta d’estate), niente amica. È uno dei tanti proverbi che raccomandavano di astenersi dall’attività sessuale nella stagione calda che è anche quella dei lavori più pesanti.
Quand l’é al tàimp dal massch, al sumâr al s’adà d’avàir pérs la cô = Quando arriva la stagione delle mosche, l’asino si accorge d’aver perduto la coda.
Quand l’é avêrt un bûs int’la zèda, tótt i vôlen pasèr = Quando è aperto un buco nella siepe, tutti vogliono passare. Quando si impara che una donna ha avuto un’avventura, tutti ci provano.
Quand l’é bèl al dé d’San Gâl, as’sammna anch int’la vâl = Quando è bello il giorno di San Gallo (16 ottobre), si semina anche nella valle. La stagione della semina è nel pieno.
Quand l’é pasè al “Barbuto”, al “Freciuto” e al “Ptnè”, côsa pôlel fèr ed mèl? = Quando è passato il “Barbuto” (Sant’Antonio Abate: 17 gennaio), il “Freciuto” (San Sebastiano: 20 gennaio) e il “Pettinato” (San Biagio: 3 febbraio), che cosa può ancora fare di male (l’inverno)?
Quand l’ômen fa la têra, la dôna la dvàinta bèla = Quando il marito muore, la moglie diventa bella.
Quand l’uràccia fa la spîga, bavv dal vén e lâsa stèr l’amîga = Quando l’orecchio fa la spiga, bevi del vino e lascia stare l’amica, (agli uomini anziani crescono spesso ciuffi di peli nelle orecchie).
Quand mâz va urtlàn, al vèl pió al sâch che al gràn = Quando maggio è ortolano (piovoso), vale più il sacco che il grano. Si raccoglie poco grano.
Quand nàiva int’la fójja, al fradd dà pôca nójja = Quando nevica sulle foglie (cioè molto presto) l’inverno è molto mite.
Quand nâs una dôna al zîghen anch al furmîgh = Quando nasce una donna, piangono anche le formiche. Due le interpretazioni: la prima, maschilista, ritiene che la nascita di una donna sia evento sciagurato degno di essere pianto da tutti, sin dalle formiche. La seconda, femminista, che le formiche piangono perché la naturale parsimonia delle donne è tale che alle formiche non restano nemmeno le briciole. La maggioranza degli autori propende per la prima interpretazione. (Nota personale: per la seconda interpretazione, in modo un po’ diverso, lo era tutta la zona della mia vallata: quando nasce una bambina, la famiglia è fortunata, perché la femmina è figlia per tutta la vita, il maschio lo è solo finché non si sposa).
Quand as’dvàinta vîc’, a i vôl la curanna in man = Quando si diventa vecchi, ci vuole la corona in mano. Si deve recitare il Rosario.
Quand Santa Catarénna vèn, métt la brèsa int’al scaldén = Quando viene Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre) metti la brace nello scaldino.
Quand’s’é fât dal mèl al zîl castîga = Quando si è fatto del male, il cielo castiga.
Quand tîra al muntan, s’an piôv incû, al piôv edman = Quando spira il “montano”, se non piove oggi, piove domani. “Montano” vento di Ostro (spira da Sud ed è caldo e secco).
Quand al cuntadén al vén in zitè, o ch’al dvàinta gióddiz o pudstè = Quando un contadino viene in citta, o diventa giudice o podestà.
Quand un puvràtt al mâgna una galénna, l’é malè ló, o l’é malè la galénna = Quando un povero mangia una gallina, o è malato lui o è ammalata la gallina. Il brodo di pollo era, un tempo, considerato ottimo per i malati. Nel secondo caso, se veniva la moria dei polli, un povero non poteva permettersi di buttarli.
Quand’znèr fa la palver, prepèra un grnèr d’rauver = Quando gennaio è asciutto, prepara un granaio di rovere (quercia). Si prevede un raccolto abbondante.
Quant mèl pôrta a n’pinsèr pr’al drétt = Quanto male deriva da non pensare rettamente.
Quasta la n’é farénna da sô sâch = Questa non è farina del suo sacco. Questa non è opera sua.
Quâter côs han sàimper fâm: la tèra trésta, la ca’ dal dièvel, la dôna putèna e al fûgh = Quattro cose hanno sempre fame (sono insaziabili): la terra sterile, la casa del diavolo, la donna puttana e il fuoco.
Quasta l’han pèga gabèla = Questa non paga dazio. Si diceva a chi aveva appena raccontato una frottola.
Quâter côs l’ha da fèr al maré a la mujêr: tgnîrla in sudizian, dèri da magnèr, vlàiri bàin e vstîrla al méi ch’al pôl = Quattro cose deve fare il marito alla moglie: tenerla in soggezione, nutrirla, amarla e vestirla meglio che può.
Qué as’vanga sàimper e an s’zâpa mai = Qui si vanga sempre e non si zappa mai. Un giovane contadino, durante l’ultima guerra, scrivendo dal fronte, voleva informare i familiari dell’avverso andamento delle operazioni. Per evitare l’intervento del censore scrisse questa frase. “Qui si vanga sempre e non si zappa mai”. L’operazione della vangatura si fa retrocedendo, mentre la zappatura si fa avanzando. I familiari furono così informati esattamente come stavano le cose, alla faccia dell’ignaro censore.
Ragâza madûra, an pérs sô ventûra = Ragazza matura, non ha perduto ogni occasione. Può ancora trovare marito.
Râgn pôrta guadâgn, furmîga brîga = Un ragno porta guadagno, una formica (porta) bega.
Rain al ramp in t’al pió dabbel = Il fiume Reno rompe sempre nel punto più debole. Anche in senso figurato.
Ràmper al giâz = Rompere il ghiaccio. Iniziare a parlare per fare cessare un situazione tesa.
Ràmper i bambûz = Buttare tutto all’aria. Interrompere una trattativa; adirarsi come fanno i bambini, quando, per rabbia, rompono bambole e giocattoli.
Ràmper i sunâi = Disturbare. Rompere le scatole.
Ràmper l’ôv in bacca a ón = Rompere l’uovo in bocca a qualcuno. Prevenire altri nel fare e nel dire.
Rang’d’èsen a’n’ va in zîl, e vaus ed mât a’n’va in capétol = Raglio d’asino non sale in cielo, e voce di matto non va in capitolo.
Rass ed maténna, bèl tàimp avsénna = Rosso di mattino, bel tempo si avvicina.
Rass ed sîra, bèl tàimp a la maténna = Rosso di sera, bel tempo alla mattina.
Rédder co’i ànzel = Ridere cogli angeli. Dei bambini quando ridono nel sonno.
Rédder satta sacàn = Ridere di soppiatto.
Rèr cmôd una massca bianca = Raro come una mosca bianca.
Rilevèr la stémma = Stimare un bene.
Rôba cénna, rôba fénna = Roba piccola, roba fina. Le persone di piccola statura hanno, in genere, buone qualità.
Rôba ch’farévv arsussitèr un môrt = Roba da far rivivere un morto.
Roma, caput mundi, Butrius secundi, Bulaggna la grâsa, l’ignuranza di Mudnîs, inción la pâsa = Roma capo del mondo, Budrio secondo, Bologna la grassa, l’ignoranza del Modenesi nessuno la passa. Tipico prodotto del vecchio campanilismo in latino maccheronico e in bolognese.
Sâch vûd an pôl stèr in pî = Sacco vuoto non può stare in piedi. Chi non ha mangiato non può lavorare.
S’a i é al saul par la Candàila, par San Biès al nàiva = Se c’è il sole per la Candelora (2 febbraio), nevica il giorno di San Biagio (3 febbraio).
S’a i è la palver ed znèr, la premmavàira la va mèl = Se non piove a gennaio, sarà una brutta primavera.
Sàimper bàin an’s’pôl stèr = Sempre bene non si può stare.
S’al nàiva ed znèr, as’rimpéss al granèr = Se nevica in gennaio, si riempie il granaio.
S’al piôv al dé dl’Ascensian, la va mèl la granisàn = Se piove il giorno dell’Ascensione, va male la granigione.
S’al piôv al dé dl’Inzariôla, da l’invèren a san fôra = Se piove il giorno della Candelora (2 febbraio), da l’inverno siamo fuori.
S’al piôv al dé d’San Gâl, al piôv quaranta dé sàinza fâl = Se piove il giorno di San Gallo (16 ottobre), piove quaranta giorni senza fallo.
S’al piôv al dé d’Santa Bibièna, al piôv quaranta dé e una stmèna = Se piove il giorno di Santa Bibbiana (2 dicembre) piove quaranta giorni e una settimana.
S’al piôv ed febrèr, a s’rimpéss al granér = Se piove in febbraio, si riempie il granaio. Il raccolto sarà abbondante.
S’al piôv in agast, al piôv mêl e mast = Se piove in agosto, piove miele e mosto. La pioggia agostana favorisce la produzione dei vigneti e degli alveari.
S’al piôv par San Michêl, anch l’invêren a i srà un mêl = Se piove per San Michele Arcangelo (29 novembre) anche l’iverno sarà come miele.
San Barnabà, la fèlz al prà = San Barnaba (11 giugno) è ora di falciare i prati.
San Barnabà, l’û vén a al fiaur và = San Barnaba (11 giugno) l’uva viene e il fiore va. E’ il periodo dell’allegagione dell’uva.
San Bastiàn, al pôrta la nàiv in man = San Sebastiano (20 gennaio) porta la neve in mano.
San Bastiàn da la nàis in man = San Sebastiano (20 gennaio) dalla neve in mano. Nevica facilmente. Con Sant’Antonio abate, San Geminiano e San Biagio è uno dei Santi della neve.
San Dunén, mèz smintén = San Donnino (9 ottobre) la semina deve essere a metà.
Sanguinèla, sanguinèla, fâmen vgnîr una canèla = Sanguinella, sanguinella, fammene venire una cannella. Vi è anche la forma … Fân vgnîr una cadinèla = Fanne venire una catinella. Sono diverse piante chiamate “Sanguinella”, Andropogon hischaenun (Graminacea), detto anche “Piè di pollo”; Cornus sanguinea (Cornacee); Phytolacca decandra (Fitolaccacee). Le prime due originarie delle nostre zone, la terza importata dall’America settentrionale: è la pianta che il Manzoni nei “Promessi Sposi” chiama “Uva Turca”. Le tre piante citate hanno tutte importanza in erboristeria.
Sangv d’mî lôla = Per Bacco. Diamine.
San Jusèf, al pôrta vî al scheldalèt = San Giuseppe (19 marzo) porta via lo scaldaletto. Gli scaldaletto delle nostre campagne erano i famosi: Prît e la sôra = I preti e le suore.
San Lócca, dal balûs in bacca = San Luca (18 0ttobre) dai balogi in bocca. I balogi sono le castagne bollite. Mentre le castagne arrostite sono i Frusè.
San Luigén spigazè = Di giovane molto timido. Non si sa a quale San Luigi si riferisca, se a San Luigi IX di Francia o a San Luigi Gonzaga.
San Lurànz in gradèla = San Lorenzo in graticola. Com’è noto San Lorenzo venne martorizzato col fuoco sopra una graticola. Il giorno di San Lorenzo (10 agosto) è molto caldo e, quindi, graticola vale per gran caldo.
San Pîr as’fé la bèrba prémma par sé = San Pietro si fece la barba per primo. Vedi anche: Zaschedón par sé e Dio par tótt = Ciascuno per sé e Dio per tutti.
San Martén l’é al protetaur di bécch = San Martino è il protettore dei cornuti. A Cento, ancora recentemente, per il giorno di San Martino (11 novembre) veniva eletto il “Becco dell’anno” ed il nome del fortunato veniva reso di pubblico dominio, mediante l’affissione di manifesti murali. Non si capisce perché il gravoso incarico debba toccare ad un Santo che, dapprima soldato e quindi vescovo, non ebbe mai moglie.
San Michèl l’é un gran turmàint = San Michele è un grande tormento. Si riferisce ai cambi di abitazione per i braccianti che, tuttavia, a Bologna e in certi Comuni della Provincia, avvenivano non nel giorno di San Michele (29 settembre), bensì l’8 maggio (San Desiderato e San Vittore).
San Michîl porta la mranda in zîl = San Michele Arcangelo (29 settembre) porta la merenda in cielo. Le giornate si accorciano, si cena presto e non si porta più la merenda nei campi a quelli che lavorano.
S’an s’fa fèsta al sô Sant, l’an s’fa pió = Se non si festeggia il Santo protettore nel giorno a lui destinato dal calendario, non lo si festeggia più. “Passata la festa, gabbato lo santo”.
Sant’Agnàis, la lusèrta pr’al paiàs = Sant’Agnese (21 gennaio) la lucertola per il paese. E’ un vecchio e noto proverbio. È tuttavia difficile che le lucertole escano dai loro rifugi invernali il 21 gennaio.
Santa Bèrbara bandatta, liberès dal tran e da la sajàtta = Santa Barbara benedetta liberaci dal tuono e dalla saetta. La Santa ha goduto per molti secoli di grande fama e devozione: ora è stata cancellata dal Calendario. Sic transit gloria mundi! Proteggeva dal fulmine, dalla morte improvvisa. Era la Patrona degli artificieri, cannonieri, pirotecnici, artiglieri, fochisti, vigili del fuoco, marinai, ecc. Ora non più. Per i vecchi artiglieri, però, lo è tuttora. I contadini, nella sera della Santa (4 dicembre) usavano prendere la “stiôpa” (fucile) e sparare due colpi in alto.
Santa Bèrbara e San Siman, tgnîs luntan da la sajàtta e dal tran, da la môrt sibitània, da la subitanea morte, liberanos Domine = Santa Barbara (4 dicembre) e San Simone Apostolo (28 ottobre) erano invocati contro il tuono e i fulmini e contro la morta improvvisa.
Santa Bibièna = Santa Bibiana. Di esistenza molto incerta è stata tolta dal Calendario universale della Chiesa. Sarebbe una fanciulla romana martirizzata sotto l’Imperatore Giuliano l’Apostata. Per i nostri campagnoli il giorno della sua ricorrenza (2 dicembre) era utile per le previsioni meteorologiche. Diceva il proverbio: Santa Bibièna, quaranta dé o una stmèna = Si andava così dai 7 ai 47 giorni validi. Viene alla mente la Sibilla Cumana: Ibis, redibis non morieris in bello, ove, spostando una virgola, si poteva vivere o morire.
San Ptrôni = San Petronio (4 ottobre). Ottavo Vescovo di Bologna e Patrono della città. In verità la vera Patrona della città e del contado era ed è, la Madonna di San Luca. Cittadini e contadini convenivano, il Lunedì Dell’Angelo, al Santuario della Guardia; mentre per i cittadini si trattava di fare pochi chilometri di portico, per i campagnoli era molto più gravoso perché dovevano affrontare viaggi di molti chilometri a piedi o con mezzi di fortuna. Era consuetudine che i diversi Comuni portassero in dono la cera per le candele.
Santa Craus, furmàint spigaus = Per Santa Croce (3 maggio) la spiga esce dalla botticella. I contadini usavano, in tal giorno, porre delle croci nei campi, fatte con l’ulivo benedetto.
Santa in cîsa e dièvel in ca’ = Santa in chiesa e diavolo in casa. Una bigotta, ma di cattivo carattere.
Sant’Alò, che prémma al muré e pó al s’amalò = Sant’Alò che prima morì e poi si ammalò.
Santa Luzî, la nôt pió lónga c’ha si sî = Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia. Proverbio antico. È noto, infatti, che la notte più lunga dell’anno è quella del 21 dicembre (Solstizio d’Inverno). Tuttavia, prima della riforma del Calendario di Papa Gregorio XIII (Ugo Boncompagni, Bolognese) resa esecutiva nel 1582, la notte più lunga dell’anno coincideva, circa, con Santa Lucia (13 dicembre). La riforma Gregoriana venne subito introdotta nei paesi Cattolici e solo oltre un secolo dopo in quelli Protestanti. La Chiesa Ortodossa sino a pochi anni fa non ne volle sapere, ed è per ciò che i Russi celebrano la Rivoluzione di Ottobre in novembre.
Sant’Âna = Sant’Anna (26 luglio). La festa di Sant’Anna cadeva tra la fine dei lavori di mietitura e quelli successivi del taglio della canapa e sua macerazione. I contadini ne approfittavano per prendersi un giorno di respiro. Protegge le partorienti.
Sant’Antôni al s’inamuré int’un purzèl = Sant’Antonio (Abate) (17 gennaio) si innamorò di un maiale. Forse perché nell’iconografia è sempre raffigurato con un maiale accanto. Pare che il Santo Eremita, vivendo nel deserto, fosse di continuo tentato dal Maligno che assumeva diverse forme, tra le quali quella del maiale. È perciò che la fantasia popolare gli ha attribuito la funzione di patrono dei maiali e, per estensione, di tutti gli animali.
Sant’Antôni da la bèrba bianca, s’an la câta, ai la métt = Sant’Antonio (Abate 17 gennaio) dalla barba bianca, se non la trova (le neve), gliela mette.
Sant’Antôni da la bèrba bianca, s’an piôv, la nàiv l’an manca = Per Sant’Antonio Abate, o neve o pioggia.
Sant’Antôni dal campanén; Sant’Antôni dal purzèl = Sant’Antonio Abate (17 gennaio) dal campanello, Sant’Antonio (Abate) col maiale. Uno dei santi più venerati dai contadini, la sua prerogativa di protettore del bestiame gli conferiva, anzi, il primo posto. Nessuno osava dormire nelle stalle durante la notte del 17 gennaio. Si diceva che le bestie parlassero tra loro – in bolognese – naturalmente – e che chi le avesse sentite sarebbe morto entro l’anno.
Sant’Antôni da la bèrba bianca, s’an l’ha, pôch ai manca = Sant’Antonio dalla barba bianca, se non l’ha (la neve) poco ci manca.
Sant’Antôni fa al pant e San Bièsi al le ramp = Sant’Antonio fa il ponte e San Biagio lo rompe. Sant’Antonio Abate: 17 gennaio, San Biagio 3 febbraio.
Sant’Antôni da la gran fardûra e San Luranz da la gran calûra, l’ón e l’èter pôch al dûra = Sant’Antonio Abate (17 gennaio) dal gran freddo e San Lorenzo (10 agosto) dal gran caldo, l’uno e l’altro durano poco.
Sant’Antôni da Pèdva = Sant’Antonio da Padova (13 giugno). Santo molto venerato, tuttavia non come Sant’Antonio Abate.
Sant’Ègata, la tèra arfièda = Sant’Agata (5 febbraio), la terra prende fiato, comincia a spuntare la prima erbetta.
San Grugnàn = San Musone. Il mercoledì delle Ceneri perché segnava la fine del Carnevale e la gente era immusonita e stanca per la veglia del martedì grasso.
S’an s’mâza al gâl par Caranvèl, al va da mèl = Se non si uccide il gallo per carnevale, va a male.
San Jusèf = San Giuseppe (19 marzo), veniva festeggiato mangiando le raviole con ripieno di marmellata, castagne passate al setaccio, uva passa, pinoli e rhum.
San Lócca = San Luca. Il giorno di San Luca Evangelista cadeva il 18 ottobre. Era un giorno molto importante e perciò è ricordato in molti proverbi. Dovevano essere terminate le semine (Par San Lócca, chi n’ha summnè al se splócca) e si raccoglievano le castagne (Par San Lócca, chi ha di marón al plócca e chi an’ha brîsa al se splócca la camîsa). La sera di San Luca, in città e in campagna, si mangiavano gli Arôst (caldarroste) e si beveva il vino nuovo.
San Luranz da la gran calûra = San Lorenzo Diacono (10 agosto), detto anche: San Luranz in gradèla (San Lorenzo in graticola), perché martirizzato sopra una graticola. Il suo giorno era un momento di riposo durante i grandi lavori dei campi, come quelli di San Giovanni, San Pietro e Sant’Anna. Nella notte di San Lorenzo tutti guardavano il cielo per osservare la caduta delle stelle.
Santa Luzî = Santa Lucia Martire di Siracusa (13 dicembre). Per Santa Lucia si macellava il primo maiale in modo da avere la carne pronta per le feste di Natale. Un proverbio, certamente molto antico dice: Santa Luzî, la nôt pió lónga c’ha si sî = Santa Lucia la notte più lunga che ci sia. È evidente che il proverbio è precedente alla riforma gregoriana del calendario (1582) perché allora il solstizio d’inverno coincideva più o meno, col giorno di Santa Lucia.
San Martén = San Martino (11 novembre). Era una delle ricorrenze più sentite. Nella sera le famiglie si riunivano, giocavano a carte, bevevano vino e mangiavano Arôst (caldarroste) e Balûs (castagne bollite). Era di rigore prendere la sbornia a forza di assaggiare i vini dell’uno e dell’altro podere.
San Nicôla = San Nicola da Bari (6 dicembre). Santo conosciuto da noi e anche venerato perché patrono dell’Opera Pia dei Poveri Vergognosi che ne aveva apposta l’immagine in terracotta su tutti i fabbricati di sua proprietà. Nel giorno del Santo i Padri Agostiniani di San Giacomo Maggiore, distribuivano dei piccoli pani devozionali detti: Pantén d’San Nicôla = Panetti di San Nicola.
San Pèvel di séggn = San Paolo dei segni. Conversione di San Paolo. L’Apostolo delle Genti non veniva festeggiato nel giorno dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno – quello era: Al dé d’San Pîr (il giorno di San Pietro), per tutti. Lo si festeggiava invece il 25 gennaio, festa della Conversione di San Paolo. Era detto, tale giorno, San Pèvel di séggn, perché, nella notte precedente, le ragazze da marito usavano esporre all’aperto un catino pieno d’acqua. Al mattino esaminavano i segni fatti dal ghiaccio per dedurne la professione del futuro sposo.
San Pîr = San Pietro Apostolo (29 giugno). Per la verità il giorno è dedicato anche a San Paolo, ma i nostri contadini preferivano festeggiare i due Santi separatamente. Fra San Giovanni (24 giugno) e San Pietro (29 giugno) iniziava il periodo dei lavori più faticosi e una festa in più, oltre alla domenica, faceva comodo, anche se non sempre era possibile riposarsi. Era detto anche San Pîr Amdàur = San Pietro Mietitore.
San Rôch = San Rocco (17 agosto). Confessore del XIV secolo. Protettore dei pellegrini (fu egli stesso un pellegrino per tutta la vita) taumaturgo contro la peste (anche lui la prese durante la terribile epidemia della metà del secolo) era invocato contro i colpi apoplettici. I contadini per dire che una persona era morta d’infarto o di qualcosa di simile, dicevano: A i é vgnó un rôch = Gli è venuto un “rocco”.
San Silvèster = San Silvestro Papa. Si diceva di persona tarda di mente: infatti il giorno di San Silvestro (31 dicembre) cade l’ultimo giorno dell’anno.
San Simàn = San Simone. Il 28 ottobre cade la festa dei Santi Simone e Giuda. Simone fu discepolo di Gesù e fu detto il “Cananeo” o lo “Zelota”. Giuda non ha nulla a che fare con l’Iscariota, ma era detto “Taddeo” ed era fratello di San Giacomo Minore. Era un giorno abbastanza sentito dai contadini che lo festeggiavano con un pranzo abbondante (se potevano). Dice il proverbio: Par San Simàn, o l’ôca o al capàn = Per San Simone (si mangia) o l’oca o il cappone.
San Stèven = Santo Stefano Diacono (26 dicembre). Il martire al cui linciaggio Paolo di Tarso “consentì”. Era un’appendice del Natale. In questo giorno si mangiavano gli “avanzi” di Natale e le donne si riposavano delle fatiche fatte per preparare il pranzo natalizio.
San Vinzànz = San Vincenzo Ferreri (5 aprile). Santo molto venerato perché ritenuto taumaturgo contro gli incendi e contro le avversità meteorologiche (fulmini, incendi, grandine).
San Zvân = San Giovanni Battista. Era molto più noto e venerato di San Giovanni Evangelista. Molte Parrocchie della nostra Diocesi erano dedicate al Precursore. Nell’occasione della sua festa si svolgevano riti forse di origine pagana: a parte i “fuochi” della notte, si raccoglievano gli agli, la lavanda e le noci per il nocino. Si riteneva che chi non raccoglieva o non comprava gli agli per San Giovanni (24 giugno) avrebbe avuto dinnanzi un anno di miseria. È l’unico Santo del Calendario del quale la Chiesa celebra la data della nascita (sei mesi prima di quella di Gesù) e non quella della morte.
San Zvân amdaur, San Pîr ligadaur = San Giovanni Battista (24 giugno) Santi Pietro e Paolo (29 giugno). Mietere per San Giovanni e legare i covoni per San Pietro.
San Zvân, métt al sûgh int’lû = San Giovanni Battista (24 giugno), mette il sugo nell’uva.
San Zvân an porta ingân = San Giovanni non porta inganni. Frase rituale dei bambini prima di iniziare il gioco, per impegnarsi a non fare imbrogli.
San Zvanén, pâs ed galtén = San Giovannino, passo di gallettino. Per San Giovanni Apostolo (27 dicembre) le giornate cominciano ad allungarsi. Si tratta di proverbio che, come altri – vedi Santa Lucia la notte più lunga che ci sia – è nato prima della riforma Gregoriana del calendario, cioè prima della metà del 1582.
S’an vèl la rasàn, a druvaró al bastàn = Se non vale la ragione, userò il bastone. Se non servono le buone, userò le cattive.
Sapiànza ed cuntadén e fôrza ed fachén, in véln un quatrén = Sapienza di un contadino e forza di un facchino, non valgono un quattrino.
Sarnèra o ch’al’s’avérra o c’la sèra = Il vento di maestrale può portare indifferentemente sereno o maltempo. (O che si apre o che si chiude).
Sarvîr ed bèrba e pirócca = Servire di barba e parrucca, conciare per le feste.
Sâs trât e parôla détta, in taurnen pió indrî = Sasso tirato e parola detta non tornano più indietro.
Satt’âqua la fâm, satta la nàiv al pan = Sotto l’acqua la fame, sotto la neve pane.
Satta i linzû, an i é miséria = Sotto le lenzuola non c’è miseria. I poveri godono come i ricchi.
Satta la brôza al sumâr, e i bû satta al câr = Sotto il barroccio il somaro, e i buoi sotto il carro. Ogni veicolo vuole il suo “tiro”. Brôza = Barroccio a due ruote e due stanghe trainato da un solo animale. Câr = Carro a quattro ruote e timone, trainato da due animali.
Saul a Nadèl, rustézz a Pasqua = Sole (bel tempo) a Natale, brutto tempo a Pasqua. Rustézz = Tizzone e brace nel camino, e quindi a Pasqua il brutto tempo avrebbe portato anche il freddo.
Sauvra l’óngia = Sopra l’unghia. Pagamento immediato, per contanti. Nel mercato dei bovini era la forma di pagamento per capi senza alcuna garanzia.
Savàir a quant’dé é San Biès = Sapere quanti giorni mancano per arrivare a San Biagio. Essere molto accorti.
Savàir ed mèl = Rammaricarsi, essere dispiaciuto.
Savàir ed scapén = Fare cattivo odore.
Savàiren ónna pió dal dièvel = Saperne una più del diavolo. Essere molto sveglio.
Savàir quanti pèra fân trî bû = Sapere quante paia fanno tre buoi. Essere avveduto (scherzoso).
Savàir una côsa a màina dîda = Sapere una cosa a menadito.
S’avlî vadder la bèla campâgna, andè a Bûdri in pianûra e a Scanèl in muntâgna = Se volete vedere la bella campagna, andate a Budrio in pianura e a Scanello in montagna. Emilio e Luigi Loup, mercanti svizzeri, si stabilirono a Bologna nell’800 ed acquistarono due grandi tenute al Trebbo di Budrio e a Scanello di Loiano. Forse furono essi stessi a divulgare il detto.
Sbâter agl’êli = Sbattere le ali. Vale per “morire”. Quando si tirava il collo a una gallina, questa, negli spasimi dell’agonia, batteva le ali.
Sbâter l’ôs barbén = Lett.: Sbattere l’osso barbino. Mangiare con grande avidità.
Scaduar al nès o póggn o bès = Prurito al naso o pugni o baci.
Schèlda la béssa in sàin, ch’la t’musgarà = Scalda la serpe in seno, che ti morderà.
Schèrpa granda e bichîr pén e tôr al mand cómm al vén = Scarpa grande e bicchiere pieno e prendere il mondo come viene.
Schèrpa grôsa, zarvèl sutîl = Scarpa grossa, cervello fino.
Schèrza coi fant e lâsa stèr i Sant = Scherza coi fanti e lascia stare i Santi.
Schèrza con la bacca, ma la man cl’an tacca = Scherza con la bocca, ma che la mano non tocchi.
Schèrz ed man, schèrz ed vilàn = Scherzo di mano, scherzi da villano.
Schèrz ed man, zûgh da vilàn = Scherzo di mano, gioco da villano.
Schiôch, ghignaus, bigataus, pén ed móffa e tarulè = Sciocco, antipatico, verminoso, pieno di muffa e tarlato. Insulto tra ragazzi, per questioni di gioco.
Scûrta al buratèl, che mé a smôrz al mi fanèl = Accorcia l’anguilla che io spengo il mio fanale (il mio lume). Due amici in vena di frottole: uno racconta di avere pescato un’anguilla lunga più di due metri (buratèl). L’altro, per risposta, di essere caduto nel canale con un lume ad olio in mano e che il lume, benché sommerso, era rimasto acceso. Alle rimostranze del primo, incredulo, rispose: Scûrta al buratèl…
Scusèr i zîrc = Scuotere i cerchioni (delle ruote). Andare malamente negli affari e nella salute.
Se al côs al’féssen dau vôlt, tótt i sarén sèvi = Se le cose si facessero due volte, sarebbero tutti savi.
Se al dé d’San Zôrz al pióv, al bigât an’fa al flusèl = Se il giorno di San Giorgio (23 aprile) piove, il baco non fa il bozzolo.
Secand al frê, as’fa al capôz = Il saio si fa su misura. Ci si deve regolare caso per caso.
Se dai parént t’vû èser arzvó bàin, bât a la pôrta coi pî e brîsa col man = Se dai parenti vuoi essere ricevuto bene, batti alla porta coi piedi e non con le mani. Vale l’antico detto di sant’Ivone: “Porta advocati pulsanda pede”. Alla porta dell’avvocato si deve battere col piede perché, naturalmente, la mani devono essere piene di doni.
Se ed’znèr al sóppia, ed febrèr al nàiva = Se a gennaio tira vento, a febbraio nevica.
Se i ranûc’ avéssen i dént, quanta zàint i musgarénn = Se i ranocchi avessero i denti, quanta gente morsicherebbero. Così i poveri e gli umili.
Se la nôt ed San Pèvel l’é bûra, dal calender an m’in dâgh cûra = Se la notte di San Paolo (25 gennaio) è buia, del Calendario non mi prendo cura. I contadini amavano fare le “calende”, previsioni del tempo per tutto l’anno, cominciando il primo di gennaio. Il primo di gennaio, il due di febbraio, il tre di marzo, il quattro di aprile e così via. Il giorno tredici ricominciavano alla rovescia, cioè il tredici era dicembre. Il quattordici novembre fino al 24 che era di nuovo gennaio. Tenevano grande conto di queste previsioni. Tuttavia se il giorno della Conversione di San Paolo (25 gennaio) il tempo era bruto o almeno nuvoloso, le calende non erano valide. Le calende erano compito esclusivamente maschile, riservato, anzi, al reggitore detto: L’azdaur.
Se l’âqua la fóss bôna, l’han currarév brîsa pr’i fûs = Se l’acqua fosse buona, non correrebbe per i fossi (dicevano i beoni).
Sê! L’âqua la va a Padêren! = Sì! L’acqua va a Paderno! Come dire: Sì, l’acqua va in salita. (Paderno è un paesino sui colli bolognesi). Espressione di chi ascolta una cosa inaudita.
Sèl arvarsè, ôli arvarsè, guai par la strè = Sale rovesciato, olio rovesciato, guai per la strada (guai in vista).
Sèna e da galantômen = Sana e da galantuomo. Era la battuta verbale di garanzia di sanità di un capo di bestiame, che il venditore prestava al compratore per capi venduti “da vita”.
Se San Matî l’appéja bàin, la cunsèrva a l’impiràn = Se per San Mattia (24 febbraio) gela forte, potremo riempire bene la “Conserva”. La “Conserva” era la ghiacciaia sotterrata che esisteva nei giardini delle ville padronali. Era coperta da una volta sulla quale veniva posto un alto strato di terra e piantati alberi. Sul fondo vi era uno strato di fascine che serviva da drenaggio. Nell’inverno i contadini provvedevano a riempirla col ghiaccio dei maceri e con neve. Nella stagione calda vi venivano conservate le vivande e le bevande. A Bologna vi era la ghiacciaia comunale in piazza San Domenico. Macellai e pescivendoli vi riponevano le loro merci durante la notte. Il verbo: apièr, nel nostro dialetto, significava “rapprendersi”, gelare, non accendere.
Se San Michèl as’bagna agl’êl, al pióv fén a Nadèl = Se San Michele (29 settembre) si bagna le ali, piove fino a Natale.
Se Santa Luzî at’cunsèrva la vésta! = Se Santa Lucia ti conserva la vista!. Detto a persona che mangia avidamente (l’appetito non manca).
Se tótt i bécch i purtèssen al lampiàn, Gesomarî che illuminaziàn = Se tutti i cornuti portassero il lampione, Gesù Maria, che illuminazione (quanta luce).
Se zoventó savéss e se vcâja pséss, an i sarévv côsa ch’an s’féss = Se la gioventù sapesse e la vecchiaia potesse, non ci sarebbe cosa che non si facesse.
Sgnaur padran ch’al végna a divîder la sô pèrt = Signor padrone venga a dividere la sua parte. Espressione, forse ironica, usata dai contadini per invitare il padrone e dividere i prodotti.
Sgranèr un âi = Sgranare un aglio. Sfogare l’ira repressa.
Spràn dl’arlói = Lancetta dell’orologio.
Sóppa in bacca = Zuppa in bocca. Invito a tacere a non riferire cosa appena appresa.
Sôra da la capèla, nuvité bèla = Suora dal cappellone, porta buona novità. Era una vecchia superstizione, ora scomparsa, perché quelle suore hanno cambiato modo di vestire.
Sôra ed San Martén, dau tèst int un cuscén = Suora di San Martino, due teste in un cuscino. A quanto pare queste suore di San Martino non erano in odore di santità.
Spadîr i dént = Raggrinzire i denti, quando, per esempio, si mangia un frutto acerbo.
Spausa bagnè, spausa furtunè = Sposa bagnata (dalla pioggia), sposa fortunata.
Spianèr un insónni = Realizzarsi di un sogno.
Spusèr la sô opiniàn = Sostenere con fortezza la propria opinione.
Squatlèr cómm’na cavâla ch’tîra in brajja = Scodinzolare (muovere il didietro) come una cavalla che tira le briglia. Di donna che cammina ancheggiando.
Sràin ed nôt e nóvvel ed dé, l’é la risuarsa di mèl fté = Sereno di notte e nuvoloso di giorno è la risorsa dei malvestiti.
Sta’ atàint ch’a i é al lauv stra la cânva = Sta attento che c’è il lupo tra la canapa. Lo dicevano le mamme perché i bambini non si allontanassero dalla corte colonica.
St’ân bruglausa, st’èter’ân spausa = Quest’anno coi bruffoli, quest’altr’anno sposa. Si riteneva che le manifestazioni cutanee (spesso presenti nel menarca), preludessero al matrimonio.
St’è di fâs ed cavâz, ténni par mâz = Se hai dei fasci (ceppi) grossi, serbali per maggio.
Stèr al pan di èter = Vivere a spese di altri.
Stèr cmôd ‘un can in cîsa = Stare come un cane in chiesa. Cioè male.
Stèr cmôd una gâza int’al mlôr = Stare come una gazza nell’alloro. Godere di tutti gli agi, di tutte le comodità. La gazza nell’alloro si trova bene. Le bacche le servono per cibo, le foglie la riparano dal sole e la nascondono ai nemici.
Stèr cmôd un pundghén int’la farénna = Stare come un topolino nella farina. Vivere bene, godere di ogni agio.
Stèr in gufflón = Stare accoccolato.
Stèr int’i sû quattrén = Stare sul proprio onore, garantire sul proprio onore.
Stèr int’la sô = Stare nel suo. Darsi importanza.
Stèr in uràccia = Stare in orecchio. Stare molto attento a quello che succede.
Stézza, râbia e magan, a’gl’én trai dôn ch’al vôlen sàimper rasan = Stizza, rabbia e dolore, sono tre donne che vogliono sempre ragione.
Stra al ciû e la zvatta a i é pôca diferàinza = Tra l’assiolo e la civetta, c’è poca differenza.
Stintèr a dscarrer = Stentare a parlare. Di chi parla molto stentato.
Stiupén, dunén e cavalén, tótta rôba da pôch quattrén = Fucilini, donnine e cavallini, tutta roba da pochi quattrini (di poco valore).
Stra arvénna e arvinè, a i é pô diferàainza = Tra rovina e rovinato, c’è poca differenza.
Stra l’óss e i dént dal can, an métter brîsa al man = Tra l’uscio e i denti del cane, non mettere la mano.
Strénzer int’al spâl = Fare spallucce.
St’vû psèr un marcant o un pôrz, aspèta c’al séppa môrt = Se vuoi pesare un mercante o un maiale, aspetta che sia morto.
St’vû una bôna fiôla, tûla da una bôna mèder = Se vuoi una buona figlia, prendila da una buona madre.
St’vû un catîv padràn, fa padràn un puvràtt = Se vuoi un cattivo padrone, fa padrone un povero.
Suldè ch’va a la guèra, mâgna mèl e dôrm in tèra = Soldato che va alla guerra, mangia male e dorme in terra.
Stra al dîr e al fèr, a i é un fôs da saltèr = Tra il dire e il fare c’è un fosso da saltare. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
Suldè dal Ra Pipén = Soldato del Re Pipino. Di giovane timido e pauroso.
Sunèr l’aràinga = Chiamare alla resa dei conti. Non ha nulla a che fare con l’aringa, il pesce, ma si riferisce all’Arengo, luogo nel quale si radunava il popolo in assemblea al suono delle campane.
Tacàggna a spenzér? = Cominciamo a spingere? Lo si dice per fare cessare una persona da un argomento spiacevole o provocatorio.
Tajèr i gabanén indôs a quelcdón = Parlare male degli altri.
Tajèr i pâgn indôs a ón = Parlare male di una determinata persona.
Tàimp ch’lûs, âqua prodûs = Tempo che luce, acqua produce. Si credeva che quando la luminosità atmosferica era molto elevata, ciò preludesse a pioggia.
Tàimp ed’spîga, gnént amîga = Al tempo della spiga (nel pieno dell’estate e dei lavori pesanti) niente donne. Massima igienica, anche se sgradita.
Tàimp ed nôt, s’al dûra un’aura, dûra trôp = Tempo di notte, se dura un’ora, dura troppo.
Tarmèr cmôd fa una fójja = Tremare come una foglia.
Tatt e turtlén i én la bièva di prit = Tette e tortellini, sono la biava dei preti. Proverbio venato di un anticlericalismo indulgente.
Téint in màint che l’âsa dal pan l’an’tén brîsa drî = Ricordati che l’asse del pane non ti viene dietro. Ammonimento del padre al figlio che manifestava l’intenzione di lasciare la famiglia per mettersi in proprio. L’âsa dal pan era il simbolo delle condizioni economiche della famiglia colonica. Era un ripiano murato a una parete della “ca” (cucina) e guarnito con ritagli di carta. Il pane vi era posto sopra ed era coperto da un burâz (canovaccio). Purtroppo non sempre vi era il pane: era allora la stagione triste della polenta.
Tèl sgnaura, tèl cagnôla = Tale la signora, tale la cagna.
Tèra nàigra, ban pan màina = La terra nera (in genere fertile) produce pane buono ed abbondante.
Tgnîr al vén pr’al tàimp dal mèder =Tenere il vino per la mietitura. Essere previdente.
Tgnîr la butàiga avérta = Lett.: Tenere la bottega aperta. Vale per la donna che notoriamente si prostituisce e per l’uomo quando non si abbottona la patta dei pantaloni.
Tgnîr in stanga = Tenere in forse. Tenere in sospeso.
Tgnîr i pî in dau pèra d’schèrp = Tenere i piedi in due paia di scarpe. Fare il doppio gioco.
Tgnîr ón int’la cunsideraziàn d’na vèra cla mâgna i sû latón = Tenere uno nella considerazione (che merita) una scrofa che mangia i propri nati. Per un contadino non vi era nulla di più riprovevole.
Tgnîv in màint i mî zuvnétt, che, s’avlî arèr pr’al drétt, stè luntan da la stanèla, tôch e dai la zirudèla = Ricordatevi miei giovanotti, che, se volete arare diritto, di stare lontano dalla sottane (donne).
Tirèr al caràtt con la rôda quèdra = Tirare il carretto con le ruote quadrate. Fare un lavoro reso più difficile dalla circostanze.
Tirèrs drî l’óss = Chidersi la porta alle spalle.
Tirèrs indrî al mandgh d’la camîsa = Rimboccarsi le maniche. Lavorare con lena.
Tirèrs’só al calzatt = Tirarsi su le calze. Fare da paraninfo; ruffianare.
Tôr a bâzel un quelcdón = Prendere in giro una persona.
Tôr la man = Prendere la mano. Del cavallo imbizzarrito. Anche della moglie, o del figlio, che non rispettano più l’autorità del capofamiglia.
Tôr ón a gôder = Prendersi in giro di una persona.
Tôr ón satta gamba = Non prendere sul serio una persona. Sottovalutare una persona.
Tôrla pr’al sô drétt = Prendere una cosa per il giusto verso.
Tôr la rôba d’int’i ûc’ = Prendere la roba dagli occhi. Si diceva quando la merce andava a ruba.
Tôr l’ôrb par vaddri = Prendere il cieco per vederci. Fare una cosa illogica.
Tôrt o rasàn, an t’fèr métter in parsàn = Torto o ragione, non farti mettere in prigione.
Tótti al schèrp al dvàintan zavât = Tutte le scarpe diventano ciabatte. Le scarpe vecchie, opportunamente tagliate nella parte posteriore, possono essere usate come pantofole. Oppure che la bellezza, col tempo, svanisce.
Tótti al strè al condûsen a Ramma = Tutte le strade portano a Roma.
Tótti al vaulp al s’câten dal plizèr = Tutte le volpi si ritrovano dal pellicciaio.
Tótt i can scósen la cô, tótt i quajón dîsen la sô = Tutti i cani scuotono la coda, tutti i coglioni dicono il proprio parere.
Tótt i dé n’é brîsa fèsta = Non tutti i giorni è festa.
Tótt i dé, s’impèra quèl = Tutti i giorni si impara qualcosa.
Tótt i mât i’n’én brîsa al manicômi = Tutti i matti non sono al manicomio.
Tótt i mîs cambia la lónna, tótti i dé as n’impèra ónna = Tutti i mesi cambia la luna, tutti i giorni se ne impara una.
Tótt i sèlum finéssen in glôria = Tutti i salmi finiscono in gloria.
Tótt i sumâr bartén, n’én brîsa fradî = Non tutti i somari grigi sono fratelli.
Tótt quall cl’ha, al sta in vatta a una fójja d’zanavver = Tutto quello che ha, sta sopra a una foglia di ginepro. Di chi non possiede nulla (la foglia di ginepro è piccola, sottile e stretta).
Tótt quall ch’as lâsa l’é pèrs = Tutto ciò che si lascia è perduto.
Tótt quall ch’lûs al n’é ôr = Tutto ciò che luccica non è oro.
Tótt quall ch’n’amâza, ingrâsa = Tutto ciò che non uccide, ingrassa.
Tótt s’ajósta fôra che l’ôs dal côl = Tutto si aggiusta tranne l’osso del collo.
Tra al ciû e la zvatta a i é pôca diferàinza = Tra l’assiolo e la civetta, c’è poca differenza.
Tra al dîr e al fèr a i é ’na fôsa da saltèr = Tra il dire e il fare, c’è un fosso da saltare. In italiano il proverbio dice “…c’è di mezzo il mare”, ma i contadini di un tempo il mare non l’avevano mai visto.
Tra arvénna e arviné, l’é l’istàssa côsa = Tra rovina e rovinato è la stessa cosa: chi è già in rovina può non badare a rovinarsi di più.
Trai aur un gâl, quâter un cavâl, zénq un viandant, sî un cavalcànt, sèt un côrp, ôt un pôrz = Durata normale del sonno: tre ore un gallo, quattro un cavallo, cinque un viandante, sei un cavalcante, sette un corpo (cioè un essere umano), otto un porco.
Trai côs fraddi: al nès di can, i pî di frè e al cûl dal dôn = Tre cose fredde; il naso dei cani, i piedi dei frati e il culo delle donne.
Trai nabbi fan la piôva, trai piôv una fiumèna, trai fèst da bâl una putèna = Tre nebbie fanno la pioggia, tre piogge fanno una fiume, tre feste da ballo una puttana. Giusti diceva: “Chi mena la su’moglie ad ogni festa e ferma il suo cavallo a ogni fontana, in capo a un anno il cavallo è bolso e la moglie puttana”.
Trèr al mandgh drî a la manèra = Tirare il manico dietro la mannaia. Lasciare che una cosa segua il suo destino, senza intervenire.
Trèr dal madôn = Bestemmiare.
Trèr fôra = Vomitare.
Trèr in’t’i ûc’ al magnèr = Tirare negli occhi il mangiare. Dare il cibo malvolentieri.
Trèr in’t’i ûc’ una côsa a ón = Tirare negli occhi una cosa a qualcuno. Rinfacciare.
Trést al cuntadén, ch’an sa arèr, e anch pió trést al dutaur ch’an sa curèr = Cattivo il contadino che non sa arare, e ancora più cattivo il medico che non sa curare.
Tri ân una zèda, trài zèd un can, tri can un cavâl, tri cavâl un ômen = Tre anni una siepe, tre siepi un cane, tre cani un cavallo, tre cavalli un uomo. Indica la durata normale delle vite rispettive. Tre anni una siepe, nove anni un cane, ventisette un cavallo, ottantuno un uomo. Scarsa per la siepe e il cane, abbondante per il cavallo e l’uomo.
Tri gûb e una gubénna, ‘na furtónna malandrénna = Tre gobbi e una gobbina, una fortuna malandrina. Non è facile, tuttavia, incontrare assieme quattro gobbi, tre dei quali maschi.
Truvèr al cô dla sgavatta = Trovare il bandolo della matassa.
Tri sumâr e un cuntadén, fân quâter bîsti = Tre somari e un contadino fanno quattro bestie.
Truvèr al dièvel int’al piât = Trovare il diavolo nel piatto (perché il cibo è stato mangiato da altri).
Truvèr al cûl a sô nès = Trovare il culo a suo naso. Trovare una cosa a proprio gradimento.
Truvèr da dîr in’t’al Patêr = Trovare da dire anche nel Padrenostro. Criticare ogni cosa.
Truvèr la pâpa bèl e fâta = Trovare la minestra già pronta.
Truvèr l’óss zlè = Trovare la porta chiusa.
T’um pèr San Pèvel di séggn = Mi sembri San Paolo dei segni (Conversione di San Paolo: 25 gennaio). Nella notte sul 25 gennaio, le ragazze da marito usavano esporre all’aperto un catino pieno d’acqua. Se durante la notte gelava, il che avveniva quasi sempre, dai segni formati dal ghiaccio cercavano di capire chi sarebbe stato lo sposo e quale il suo mestiere (questo era facile da indovinare: il contadino). Il proverbio si riferisce proprio alle diverse interpretazioni che si potevano dare ai segni del ghiaccio.
Tuscàn e pasarén trâj col stiuptén = Toscani e passeri tira (loro) con lo schioppo. Toscani e passeri, dove li vedi ammazzali. In realtà i rapporti tra i montanari bolognesi e quelli toscani, non sono mai stati molto buoni.
Tû só e métt là che la sô la gnarà = Prendi su e metti là, che la sua verrà. Prendi e riponi (qualsiasi cosa), che un giorno sarà utile.
Tû só e pôrta a ca’ = Prendi su e porta a casa.
Tû un pàir ch’al dâga màil = Prendi un pero che ti dia mele.
Û, furmâi e pan, vétta da villàn = Uva, formaggio e pane, vita (cibo) per i contadini.
Una bèla mujèr, l’ha da èser una bèla abrazè = Una bella moglie deve essere una bella abbracciata (deve essere formosa). Gusti arcaici che qualcuno, forse, in cuor suo ha ancora.
Una bajôca da par sé, l’an ciôca brîsa = Una moneta da sola non fa rumore. Con pochi soldi non si può fare nulla.
Una campèna sérv una cmónna = Una campana basta per un Comune.
Un albèr sàinza fójj l’è un ruvràn, un ômen sàinza dôna l’é un quajàn = Un albero senza foglie è un alberaccio, un uomo senza donna è un poveraccio.
Una bèla cavâla da sói = Una bella cavalla da fando. Di donna bella che incede con eleganza. I cavalli quando camminano nel fango alzano le ginocchia: ciò conferisce al loro incedere una certa eleganza.
Una côsa ch’an sta insàmm = Una cosa che non sta insieme. Una cosa che non ha senso.
Una côsa cla va da Pèpa = Una cosa che va da Papa. Una cosa che viaggia col vento in poppa.
Una cûga da brôd = Una cuoca da brodo. Una cuoca di poco merito. Sono tutte buone di cuocere la carne in brodo.
Una Madunénna insfilzé = Una Madonnina infilzata. Una ragazza dall’apparenza molto timida e riservata, ma che, ad un occhio attento lascia capire tante cose.
Una man lèva l’ètra e tótti dau lèven la fâza = Una mano lava l’altra e tutte e due lavano la faccia.
Una nûs saula int’un sâch, l’han fa brîsa armaur = Una noce sola in un sacco, non fa rumore. L’opinione, la protesta di uno solo non viene ascoltata.
Una parôla atâca l’ètra = Una parola tira l’altra.
Un’aura ed saul, l’asûga la strè = Un’ora di sole asciuga la strada. Basta poco per ridare serenità.
Un’aura saula d’algrazza, fa scurdèr zàint mîs ed guâi = Un’ora sola di allegria, fa dimenticare cento mesi di dispiaceri.
Un’aura un gâl, dau un cavâl, trai un studàint, quâter un viandàint, zénqv un côrp, sî un pôrz, sèt una trójja, ôt ón ch’an n’èva vójja = Un’ora un gallo, due un cavallo, tre uno studente, quattro un viandante, cinque un corpo, sei un porco, sette una scrofa, otto uno che non ne abbia voglia (durata del sonno).
Unaur ed bacca, purasè vèl e pôch casta = Onore di bocca, di per sé vale e costa poco. La parola d’onore vale molto e costa poco.
Una vôlta al córr al can, l’ètra la lîvra = Una volta corre il cane, l’altra la lepre.
Un ban cunséi vèl un tesôr = Un buon consiglio vale un tesoro.
Un bèl vadder, fa un bel cradder = Un bel vedere, fa un bel credere. L’aspetto gradevole, fa buona impressione.
Un ba saul al pôl tirèr al câr = Un bue da solo non può tirare il carro. Il carro aveva il timone e doveva essere trainato da due o più bovini in numero pari. Così al Brôz, mentre la Brôza, avendo le stanghe, veniva trainata da un solo animale. Proverbio usato anche in senso figurato.
Un bèl zûgh al dûra pôch = Un bel gioco dura poco.
Un câr ed pinsîr an’pèga gnanch un bajôch ed dèbit = Un carro di pensieri non paga nemmeno un soldo di debiti.
Un drétt ed trai côt e na buîda = Un dritto di tre cotte e una bollita. Un gran furbacchione.
Un fangén da méttri al didén in bacca = Un bambino da mettergli il ditino in bocca. Una persona che, pur già adulta, finge di fare il bambino. Un finto ingenuo che fa finta di esserlo.
Un frè par stèr in cumpagnî, al tôls mujèr = Un frate per stare in compagnia, prese moglie.
Un’imprudàinza saul causa méll dân = Un attimo di imprudenza causa mille danni.
Un’impruméssa da marinèr = Una promessa da marinaio. Pare che i marinai non mantenessero mai le promesse.
Un màis prémma ed’Nadèl, un màis dapp’al Nadèl, l’é l’invèren naturèl = Un mese prima di Natale ed un mese dopo Natale, è (la durata) naturale dell’inverno.
Un’ôc’ a la pgnâta e cl’èter a la gâta = Un occhio alla pignatta e l’altro alla gatta.
Un ômen a môd e vî = Un uomo a modo e discreto.
Un ômen atacadézz = Un tipo appiccicoso.
Un ômen dal brazén cûrt = Un uomo dal braccio corto. Un avaro.
Un ômen sàiza langua, an’vèl una patarlàinga = Un uomo che non parla non vale nulla. La Patarlàinga è il frutto delle rose selvatiche (Rosa canina e Rosa gallica).
Un pèr ed’schèrp cômdi, un bichîr ed vén e tôr al mand comm al vén = Un paio di scarpe comode, un bicchiere di vino e prendere il mondo come viene.
Un pôch ed zûgh l’é al pió bèl = Un bel gioco, duri poco.
Un quèl ch’dûra cmôd una canta d’Giovâni = Una cosa che dura come una canzone di Giovanni. Una cosa che dura poco.
Un quèl ch’al lîva al bàvver = Una cosa che fa venire sete.
Un schivagàzz = Una persona guardinga che cerca di evitare grane e responsabilità. Uno che evita anche le gocce d’acqua = schivagàzz.
Uràccia drètta, parôla mél détta: uràccia stanca, parôla franca = Orecchio destro, parola maledetta: orecchio sinistro, parola franca.
Un sâch d’ôsa = Un sacco d’ossa. Di persona molto magra o di casa dissestata.
Un Sammichèl arbaltè = Una cosa disordinata. I poveri traslocavano usando dei piccoli carri sui quali ammucchiavano le loro misere masserizie. Se, come avveniva spesso, il carretto si rovesciava l’effetto era quello di una cosa disordinatissima.
Un sumâr da brôza = Un somaro da carro a due stanghe e due ruote tirato da un solo animale. Un uomo grezzo.
Un suldè dal Pèpa (o dal Ra Pipén) = Un soldato del Papa (o del Re Pipino), si diceva di un giovane imbelle, con scerse attitudini militari.
Un vtièri ch’al pèr stè stra al gamb dal dièvel = Un vestito che sembra essere stato tra le gambe del diavolo. Un abito molto sgualcito.
Va a fèr di gróggn = Va a fare dei musi. Va all’inferno.
Va a l’infèren … e Sal Lócca tîgh = Va all’inferno. … e San Luca con te. Tipica imprecazione del genitore nei confronti del figlio seccatore. L’invito ad andarsene all’inferno, è subito bilanciato dalla invocazione dell’assistenza di San Luca (della Madonna).
Vaddar i falchétt par la schénna = Vedere i falchi dalla parte della schiena. Detto di coloro che vivono in montagna.
Vaddri cmôd una tôca pr’al cûl = Vederci come una tacchina per il culo. Essere molto miopi.
Vanda chi pôl, campra chi sa, e chi é quajàn ch’al staga a ca’ = Venda chi può, compri chi sa e chi è coglione se ne stia a casa. La legge del mercato.
Vander al mnûd = Vendere al dettaglio.
Vander al scrân par tgnîr in pî la famàjja = Vendere le sedie per tenere in piedi la famiglia. Evidente gioco di parole.
Vanga quant pû e sammna co’i bû = Vanga quando puoi e semina coi buoi. Norma di buona agricoltura.
Vèc’, bacócch, cumpâgn un cóch = Vecchio, bacucco, come un cuculo. Il cuculo godeva fama di grande longevità.
Vèc’ é chi mór = Vecchio è chi muore.
Vèl pió un pèr ed brègh che dîs stanèl = Vale più un paio di calzoni che dieci sottane. Vale più un uomo che dieci donne. Assai maschilista.
Vén amèr, ténel chèr = Vino amaro, tienilo caro.
Vén e lât, l’é un vlàin bèl e fât = Vino e latte, è un veleno bello e fatto. Nell’alimentazione non si possono mescolare il vino con il latte.
Vgnîr chèld = Svenire. (Venire caldo).
Vgnîr con al mulsénni = Contattare una persona con le buone.
Vgnîr in stóffa = Venire a noia. Venire in uggia.
Vgnîr int’i sfón = Venire a noia. (Gli scoffoni erano calzerotti fatti all’uncinetto).
Vgnîr l’âqua cèra in bacca = Avere la nausea.
Vgnîr za lànz e burdón = Grandinare fitto e con vento forte.
Vîc’ e tusétt, in stan mai zétt = Vecchi e bambini, non stanno mai zitti.
Vîva Pruspràn Baschîra, c’as sèlva da la mèsna e da la lîva = Viva Prospero Baschiera che ci salva dalla macina e dalla leva (militare). (La mèsna era la macina in pietra dei mulini ad acqua. Le macine erano due, una sopra e l’altra sotto e giravano in senso opposto, più velocemente quella superiore). Il proverbio si riferisce ad una leggenda, quella di Prospero Baschiera, contadino di Longara, nato però a Maddalena di Cazzano, disertore e brigante che durante gli anni 1809-1810 diede serissimi grattacapi alle autorità del Regno d’Italia. I contadini bolognesi ne fecero una specie di idolo perché speravano di essere da lui sottratti alla leva militare e alla tassa del macinato. Venne ucciso in un conflitto a fuoco nel marzo del 1810 nei pressi di Budrio.
Vlàir un fasulén vté da cûgh e po sóbbit = Volere un fagiolino vestito da cuoco e subito. Un proprietario di campagna, volendo dare una recita di burattini nella quale Fagiolino doveva fare la parte di un cuoco, mandò il fattore in città da un artigiano fabbricante di burattini per ordinarne uno in giornata perché la recita era per la sera stessa. Il burattinaio non poté ricusarsi per l’importanza del committente, ma mentre lavorava continuava a dire: Al vôl un Fasulén … La frase rimase proverbiale per indicare una pretesa assurda.
Vté cómm un sumâr intîr = Vestito come un somaro intero (di razza). Di persona che ostenta grande ed insolita eleganza.
Vtéss un pèl, c’al pèr un Cardinèl = Vesti un palo che sembra un Cardinale. L’abito fa il monaco.
Vudèrs al stamgh = Vuotare il sacco, dire tutto, anche ciò che per riguardo non si dovrebbe dire.
Vultèr d’satta in só = Voltare sottosopra.
Vultèr gabèna = Voltare gabbana. Cambiare opinione. Cambiare partito. La gabèna era una specie di casacca da lavoro.
Vultèr galàn = Cambiare fianco (nel decubito).
Zàint alîgra, al zîl l’ajûta = Gente allegra, il cielo l’aiuta.
Zàint ed cunfén, o lèder o asasén = Gente di confine, o ladri o assassini. Prima dell’unità nazionale la Legazione di Bologna confinava col Granducato di Toscana e col Ducato di Modena e Reggio. A causa delle elevate tariffe doganali imposte dallo Stato della Chiesa, prosperava un attivo contrabbando. Inoltre, dalla parte appenninica, vi era un continuo passaggio di ricercati che fuggivano dai domini papali per raggiungere il molto più liberale e tollerante Granducato di Toscana. Tutto questo movimento portava certamente anche persone poco raccomandabili.
Zàint indurmintè, cûl in libertè = Gente addormentata, culi in libertà. Chi dorme non può avere pudori.
Zàint minziunè, o par ca’ o par strè = gente nominata, o per casa o per la strada.
Zanàn sanza guâi = Lett.: Giovannone senza guai. Vale per menefreghista, persona che prende il mondo come viene.
Zander tavda e fumarôl in schèlden brîsa la ca’ = Cenere tiepida e tizzone fumante, non scaldano la casa.
Zarchèr i guai con al muclén = Cercare i guai con un mozzicone di candela, col lanternino.
Zaschedon bèda ai sû prasû = Ciascuno badi ai suoi prezzemoli. Il significato però è diverso. I prasû erano anche quelle sfilacciature che si formavano ai bordi dei vestiti per il lungo uso. Il significato è quindi: ciascuno guardi alle proprie sfilacciature. Infatti a una donna impicciona si diceva: Bèda ai prasû dla tô stanèla = Bada alla sfilacciature della tua sottana.
Zénq’côs én miauri vèci che nôvi: al vén, l’ôli, l’amîgh, al furmâi e la virtó = Cinque cose sono migliori vecchie che nuove: il vino, l’olio, l’amico, il formaggio e la virtù.
Zêrt padrón i’an tótt al dirétt d’andèr in misêria = Certi padroni hanno tutto il diritto di finire in miseria. Vi erano proprietari di terreni che non curavano i loro beni. Pareva quasi lo facessero apposta.
Zért prît i san lèzer saul int’al sô liber = Certi preti sanno leggere solo nel loro libro (il messale).
Zighèr a gaula avèrta = Piangere a più non posso.
Zîl a gratûsa, o ch’al bâgna o ch’al brûsa = Cielo a pecorelle, o piove o viene un gran caldo.
Znaràn dal côl lóngh, lóngh = Gennaio dal collo lungo, lungo. Gennaio, per il clima molto freddo è un mese lungo da passare.
Znèr an’lâsa galén al pulèr = Gennaio non lascia galline al pollaio. Ciò a causa dei numerosi giorni festivi del mese nei quali vengono sacrificati i polli.
Znèr, gatèr = Gennaio, gattaio. (In quel mese i gatti vanno in amore). Ne approfittavano i muratori per imitare gli strepiti delle gatte in amore e catturare così i maschi, che venivano mangiati. Il gatto era un cibo molto ricercato dai muratori, com’è testimoniato dai molti nomi che gli danno: Simàn, Cunén dagl’óng e Lîvra da cópp = Simone, coniglio con le unghie e lepre da tetti.
Znèr pulvrèr, rimpéss al granèr = Gennaio senza pioggia fa sperare in un buon raccolto. Gennaio asciutto favorevole alla produzione del grano.
Znèr sgambra lèt = Gennaio sgombera letti. È il mese con maggiore mortalità. Un tempo nelle case gelide gli ammalati morivano facilmente.
Zóggn da la fèlz in póggn = Giugno dalla falce in pugno. Pronti per la mietitura che iniziava, di solito, dopo il giorno di San Giovanni Battista (24 giugno) o dopo quello dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno).
Zûgh, dôn, lît e can, mànden in arvénna i cristian = Gioco, donne, liti e cani mandano in rovina gli uomini.
Zughèr a caplàtt = Giocare a testa o croce.
Zughèr a castlàtt (ed nûs, ed clûr) = Giocare a castelletto (con le noci o con le nocciole). Si mettevano tre noci o nocciole accostate ed una quarta sopra le altre. Si doveva fare cadere la noce di sopra tirandone contro un’altra.
Zughèr a l’agàccia dspuntè = Giocare all’ago spuntato. Giocare a mosca cieca.
Zughèr a ràmmel = Giocare a crusca. Si facevano diversi mucchietti di crusca in alcuni dei quali si mettevano delle monete. Chi trovava le monete, vinceva.
Zughèr a léttra o leàn = Giocare a testa o croce. Nelle antiche monete bolognesi, da una parte c’era la testa di un leone (leàn) e, nell’altra le cifre e le lettere (léttra) che ne indicavano il valore.
Zughèr a pèr o dspèr = Giocare a pari o dispari.
FEDE E SUPERSTIZIONE DEL CONTADINO BOLOGNESE
(di Gino Calari – Accademia Nazionale Agricoltura)
La vita a contatto continuo con la natura, con tutte le sue manifestazioni, buone e cattive, con le nascite, con le morti, col rinnovarsi continuo delle stagioni, con l’improvviso e temibile esplodere di fenomeni meteorologici e di epidemie, con lo sbocciare dei fiori ed il cadere delle foglie, con la speranza di un buon raccolto ed il terrore di una carestia, porta inevitabilmente l’uomo, anche il più semplice, a chiedersi la ragione di tutto ciò, ad invocare qualcosa, o qualcuno che lo protegga, che l’aiuti nel duro essere quotidiano, che possa dare un senso ai suoi sacrifici.
Era forse per ciò, più che per una tradizione lasciata dai padri, che il contadino era credente. La tradizione dei padri svolgeva un ruolo liturgico, dava all’uomo il modo di esprimere la fede nelle forme della tradizione, ma la fede vera nasceva dentro di lui. Come dentro di lui, col terrore dell’ignoto, del male, delle forze occulte, nasceva il senso superstizioso della vita. Fede e superstizione andavano insieme.
Abituato com’era, alla severità del padre terreno e alla benevolenza della madre, temeva il Padre celeste ed invocava la Madre di Dio.
Non c’era cucina che non avesse il suo “altaról” (altarino) dedicato alla Vergine. Sopra un ripiano decorato troneggiava l’immagine della Madonna (di San Luca, del Piratello, del Buon Consiglio, del Poggio, dell’Olmo, della Provvidenza, del Fiume, dell’Ospedale, del Rio, ecc.).
Nel mese mariano, ogni sera si recitava il Rosario davanti all’immagine della Vergine poste nel “Pilastrini” o sui tronchi potati a fioriera, lungo le strade. Davanti a queste immagini le ragazze disegnavano coi fiori e frasche, scritte con “Viva Maria” o “Ave Maria ora pro nobis”.
Le stesse ragazze facevano a gara nell’iscriversi alle “Figlie di Maria”. Potevano, così, andare alle funzioni con la veste bianca e con la sciarpa azzurra a tracolla, sciarpa per la quale l’umorista Giovanni Mosca le chiamava gli “ufficiali della Madonna”, non che per ciò le “Figlie di Maria” fossero diverse dalle altre. Capitava di vederne con la pancina rotonda, arra di un prossimo matrimonio.
Gli uomini, da parte loro, entravano nella Compagnia del Santissimo Sacramento (Cumpagnî dal Santéssum) che comportava il camice bianco ricamato ed il lampione e lo stendardo.
L’immagine più venerata nel Bolognese vero e proprio era, naturalmente, quella della Beata Vergine di San Luca. I laboratori di Imola e di Bologna ne sfornavano diverse tipologie in ceramica e in terracotta. In alcune di queste immagini la Madonna porta la corona sul capo. Si tratta, in tal caso, di stampi fatti dopo il 1857, perché proprio in quell’anno, nell’occasione del suo viaggio a Bologna, Papa Pio IX incoronò solennemente la sacra immagine.
La Madonna di San Luca era venerata in tutto il Bolognese vero e proprio, tanto in pianura, quanto in collina e in montagna.
“Cómm am ‘piasèva mai, fiôli d’Marî / Quand l’éra d’mâz e s’madurèva al gran / Sénter al vôstri vaus che da luntan / al cantèvén al Credo e l’Evmarî” (Quanto mi piaceva, figlie di Maria / quando era marzo e si maturava il grano / sentire le vostre voci che da lontano / cantavano il Credo e l’Avemaria).
In città, poi, era la vera e incontrastata Patrona, relegando nel dimenticatoio il Patrono nominale, San Petronio. È uno strano destino quello dell’ottavo Vescovo di Bologna: venerato dapprima, dimenticato e soppiantato, quindi, da quella Madonna che i Bolognesi tutti, credenti o meno, amano e venerano. Non mi è mai capitato di conoscere un bolognese di nome Petronio.
Il culto della B.V. di San Luca era vivo anche nella montagna dell’alto Pistoiese e nella bassa tra gli abitanti di Cento, Sant’Agostino e Poggio Renatico.
Il lunedì di Pasqua i Bolognesi usavano salire al Santuario lungo i portici o per i “Brigoli”, che partono dalla Chiesa di San Martino di Casalecchio. Dopo i riti in chiesa si faceva colazione sul prato a base di uova sode e di salame.
Anche se non ha nulla a che fare con i contadini, mi sovviene un gustoso episodio, occorso il mercoledì delle ceneri del 1857, ad un gruppo di bolognesi che erano saliti al Santuario per prendere “le ceneri” di rito. All’uscita dalla chiesa si presentò loro il “Maligno” sotto le spoglie di un oste del luogo. Questi propose loro di fare una buona “mangiata” con gli avanzi del cenone del martedì grasso. I poveretti erano tutti popolani e due sagrestani, afflitti da arretrati di fame. Non seppero resistere e mangiarono. La notizia arrivò a Bologna prima di loro e, al ritorno, trovarono gli sbirri che li portarono dritti in galera. Era allora Arcivescovo di Bologna il severissimo Viale-Prelà (già Nunzio a Monaco e a Vienna), che aveva come Inquisitore il non meno severo Padre Feletti, naturalmente O.P. (Domenicano).
Non solo i Bolognesi di città erano usi a salire al Santuario. I Comuni della Legazione facevano ogni anno pellegrinaggi a San Luca portando in omaggio la cera d’api per le candele. Il viaggio, che di viaggio si trattava perché dovevano percorrere decine e decine di chilometri coi carri, barrocci e, più spesso, a piedi, durava a volte, diversi giorni. Di giorno camminavano, salmodiando, e di notte trovavano ricovero sulla paglia dei fienili.
L’usanza dei pellegrinaggi a Santuari diversi perdurava anche ai tempi della mia infanzia. Partivamo da Bazzano, con il prete ed il crucifero davanti e camminando, camminando e dormendo nei fienili, dopo alcuni giorni arrivavamo al Santuario di San Pellegrino in Alpe, sul valico che, dalla testata della valle del Dragone del Modenese, porta in Garfagnana, i più portavano nella sporta, assieme ai ricambi e alle cibarie, un grosso sasso che, giunti alla meta, lanciavano a valle dal sagrato del Santuario.
I poveri e buoni contadini di Molinella, nell’andare al Santuario di San Luca, circa ottanta chilometri fra andata e ritorno, dicevano chiaramente alla Vergine, senza ipocrisie: “veniamo a visitare la tua Cella, perché ci vada ben il Pane e il Vino”. Non contenti, chiedevano. “buoni Padroni con pochi Patti e senza alcun inganno” e “buone Possessioni”. Ciò detto, rimandavano l’offerta della cera all’anno successivo, sotto la condizione, però: “se la tempesta non ci fa del danno”.
A me piace molto perché è un delizioso miscuglio di fede sincera, di ingenuità e di furberia contadina. Intanto “Vergine Benedetta, facci la grazia, poi si vedrà, se non grandina…”.
Povera gente che viveva, allora, in un paese paludoso e pieno di zanzare e di rane. Per l’abbondanza dei Batraci, i confinanti abitanti di Medicina e di Budrio, li chiamavano con disprezzo “i ranûc” (i ranocchi). Loro si vendicavano come potevano chiamando i medicinesi “Pîguer” (Pecore), per l’abbondanza di pastori nei loro territori e i budriesi “I pavar” (paperi) per l’abitudine che avevano di allevare oche.
Nella parte occidentale della Diocesi, Bazzano, Castelfranco, Piumazzo, era particolarmente venerata la Madonna della Provvidenza e nelle alte valli del Setta e del Reno era nota la “Madonna del Sasso”, dello scomparso santuario omonimo.
Nell’ex Circondario di Imola, a Levante del torrente Sillaro, primeggiavano la Madonna del Piratello di Imola, quella del Calanco di Dozza, la Madonna del Rio di Fontanelice, quella del Fiume di Castel del Rio e quella dell’Ospedale di Imola.
La B.V. del Piratello era anche oggetto di culto nelle valli dell’Idice e del Savena (Monterenzio, Loiano e Monghidoro).
In quest’ultima località esistevano ed esistono tuttora, i due Santuari di San Prospero di Campeggio e della Madonna dei Boschi, ove si venera un’immagine del tutto simile a quella di San Luca. Anche la Liturgia è uguale. Per le Rogazioni Minori, quando la B.V. di San Luca scende a Bologna, quella dei Boschi si trasferisce a Campeggio con processione solenne. Ritorna, poi, alla sua sede la Domenica successiva (prima dell’abolizione della festa dell’Ascensione era il giovedì), proprio come la Madonna di San Luca.
L’usanza di portare in città la Vergine del Colle della Guardia per propiziare la benevolenza divina sui raccolti, iniziò a Bologna nel 1433, sotto l’Episcopato di Beato Nicolò Albergati, Cardinale. In quell’anno caddero piogge torrenziali per tre mesi interi, aprile, maggio e giugno, mettendo a repentaglio il raccolto.
Il Beato Albergati era allora ad Auxerre ove dirigeva il congresso per la pace tra Francesi ed Inglesi. Per l’ostinazione di Parti fu costretto a sospendere il Congresso e ritornò a Bologna ove trovò una situazione terribile per le prolungate piogge. Accolse, allora, la proposta del giureconsulto Graziolo Accarisi di portare a Bologna la venerata immagine per impetrare la sua intercessione. Il sabato 4 luglio la Vergine venne trasportata dal Colle alla chiesa di Santa Maria Maddalena in via della Pietra (dove ora sorge la chiesa di San Giuseppe dei Cappuccini). La mattina dopo, mentre la Madonna veniva trasportata alla chiesa dell’Ospedale della Morte (sotto il Pavaglione) giunta che fu a Porta Saragozza, cessò improvvisamente la pioggia. Da allora ebbero inizio le annuali discese in città della Vergine. L’epoca venne poi anticipata al tempo delle Rogazioni Minori” quando nelle campagne si facevano processioni per invocare la protezione dei raccolti.
L’uso di fare processioni mariane per le “Rogazioni” venne, poi, esteso ad altre immagini, come la Madonna dei Boschi di Monghidoro e la Madonna dell’Olmo di Budrio.
Il mercoledì prima dell’Ascensione la Madonna di San Luca veniva portata dalla Metropolitana di San Pietro al sagrato di San Petronio ove impartiva la benedizione al popolo bolognese “ al mêrcuél dla benziän” (il mercoledì della benedizione). Dalle campagne giungevano, allora, schiere di contadini per presenziare al rito.
Tra le immagini mariane più venerate, dopo quella dell’Evangelista, viene quella del Piratello, un paio di chilometri a Ponente di Imola, il cui culto risale al 1483, quando un pellegrino, certo Stefano Mangelli, si fermò in preghiera davanti ad un pilastrino che portava, dipinta di fresco, un’immagine della Vergine. Era il marzo avanzato. Una candela accesa davanti all’immagine cadde a terra, si spense, e, quindi, ritornò al suo posto ove si riaccese da sola. Allo stesso tempo un roseto, posto davanti al pilastrino, fiorì. La voce della Madonna disse al Pellegrino di informare i reggitori del Comune che desiderava essere venerata in quel luogo.
Anche la Vergine del Piratello è rappresentata in diverse forme iconografiche. Le più complete portano la simbologia del miracolo: la conchiglia (simbolo del pellegrino), la candela accesa e il roseto.
Altro culto diffuso, anche se non di origine locale, è quello della Beata Vergine del Buon Consiglio che si venera nel Santuario di Genazzano presso Roma. Si diffuse da noi nel 1800. L’immagine è riconoscibile per il baldacchino stilizzato che sovrasta il capo della Madonna.
A Boccadirio, nell’alta valle del Setta, in un ricco santuario con un bel loggiato rinascimentale, vi è un’immagine di scuola robbiesca che ricorda l’apparizione della Vergine a due fanciulli. Vi affluiscono moltissimi pellegrini dall’alto Bolognese alla Toscana. L’afflusso di gente era tanto, che, più volte l’autorità religiosa fu costretta ad intervenire per disciplinare la devozione. Con un decreto dell’uno marzo 1823, il buon Arcivescovo Oppizzoni disciplinò tutto ciò che riguardava il Santuario, i preti ed i fedeli.
«Non si potrà confessare, anche nelle feste di maggior concorso, fuorché nella sola Chiesa di Bocca di Rio….Proibiamo severamente ai sacerdoti, che confessano nel ricordato Santuario, di prendere qualunque siasi offerta dalle mani dei fedeli, in occasione di confessione, per qualunque titolo venga essa fatta, come per esempio affine di essere più sollecitamente confessato e dimesso… Il Custode del Santuario non permetterà mai a verun Sacerdote di confessare se non è da lui pienamente conosciuto, e se prima non ha veduta la sua patente di Confessore… E’ assolutamente proibito di pernottare, anche nelle feste di grande concorso, né in Chiesa, né lungo il gran loggiato, che le sta intorno….E’ proibito alle persone del sesso femminino di oltrepassare il cancello, ossia balaustrata della cappella maggiore per introdursi nel Presbitero…Di più rimane soppressa l’antica usanza di introdurre nel Santuario il giumento portante due bariletti d’olio, solita offerta di una comunità di Toscana, in onore di Maria Vergine. Si dovrà, invece, scaricare la bestia alla porta della Chiesa e i Guardiani riceveranno il carico e lo trasporteranno nel Santuario».
Da questa lunga serie di prescrizioni e di proibizioni pare di dedurre che, in occasione di feste e pellegrinaggi, nel Santuario regnasse una gran confusione.
Non risulta che eguale confusione regnasse, invece, nel tranquillo ed appartato Santuario della Madonna dell’Acero, nell’alta valle del Dardagna, sopra Lizzano in Belvedere.
In certe famiglie contadine erano anche venerate immagini mariane non propriamente bolognesi, come la B.V. della Fratta, quella di Forlimpopoli, di Coraglia, del Bosco, del Monticino, della Commenda, del Fuoco, delle Grazie, importate da famiglie dalla Romagna, o la Madonna della Ghiara venuta dal Reggiano.
Altre immagini abbastanza diffuse erano quelle dell’Immacolata Concezione e dell’Addolorata , la “Madôna di sèt dulùr” (la Madonna dei sette dolori).
Tra i santi, il primato assoluto, indiscutibile, nella devozione spettava all’eremita del IV secolo, Sant’Antonio Abate. Così, come non vi era casa senza l’immagine della Madonna, non vi era stalla senza “Sant’Antôni dal purzèl” (Sant’Antonio dal maiale) detto anche “Sant’Antôni dal campanèn” (Sant’Antonio dal campanello).
Pare che questo antico culto, così radicato e tanto sentito, fosse nato da un equivoco. Il Santo, essendo un eremita, non desiderava vedere gente, né farsi vedere. Girava perciò con un campanello appeso al bordone affinché la gente, avvertita del suo passare, si allontanasse. Inoltre, nonostante la santità, e forse proprio per quella, il Demonio lo tentava di continuo, assumendo le forme più svariate. Pare, anzi, che il travestimento suino fosse quello preferito. Perciò il Santo nell’antica iconografia veniva rappresentato col campanello appeso al bordone e con il maialino accanto. Si ritenne perciò che il santo fosse il protettore del maiale. E perché non gli altri animali? Si cominciò con l’aggiungere un asinello, poi un bue, quindi un cavallo ed infine, galline, pecore, cani. Il Santo Abate divenne così il protettore di tutti, indistintamente, gli animali.
Nacquero leggende. Nella notte della festività del Santo (17 gennaio) nessuno poteva accedere alle stalle perché le bestie parlavano fra di loro il linguaggio degli uomini. Chiunque avesse ascoltato i loro discorsi, sarebbe morto subito. Per quanto mi risulta nessuno ha voluto correre il rischio. Tranne i garzoni, perché molti di loro dormivano nell’erbaiolo della stalla. Perché, allora, non morivano? Forse il Santo, al pari degli uomini, li considerava animali a tutti gli effetti e, quindi, sotto la sua protezione.
Altro Santo tenuto in particolare considerazione era San Vincenzo Ferreri, Domenicano, nato a Valencia (Spagna) nel 1350. Fu ordinato sacerdote proprio nel 1739, quando scoppiava il Grande scisma dell’Occidente. San Vincenzo partì male perché scelse subito il cavallo sbagliato, Papa Clemente VII, dichiarato, poi, antipapa. Anche la seconda scelta non fu felice perché si rivolse il Cardinale Pedro de Luna, divenuto papa Avignonese col nome di Benedetto XIII. Finalmente, visto che non ne azzeccava una, si mise a predicare, da quel grande oratore che era, perché si mettesse fine allo scisma, deponendo ciascuno dei papi le proprie ambizioni. Il motto era: “Timete Deum et date illi honorem”. Dopo un secolo dalla sua nascita, Papa Callisto III ne riconobbe le virtù in grado eroico.
Perché venne tanto venerato dai contadini? Per dare un’idea della sua “Vis” oratoria, veniva rappresentato con una fiammella sul capo. Si ritenne, allora, che proteggesse contro gli incendi, contro i fulmini e le tempeste, e i villici si rivolsero a lui per scongiurare quelle tremende sciagure. La sua santità e potenza taumaturgica fu propagandata dai confratelli Domenicani e, presto, dilagò.
Il suo culto sostituì gradualmente quello di santa Eurosia de’ Jaca, spagnola anche lei. Era, questa, una giovane principessa concupita da un principe arabo, il quale, indispettito dai fermi dinieghi della fanciulla, le fece mozzare le mani e la testa. Il martirio entrò nella iconografia con la sventurata, il boia ed il cielo pieno di lampi e fulmini. Questi accessori, fecero pensare ai temporali e alla protezione contro questi. Il suo culto, che era stato introdotto nell’Italia Settentrionale dalle soldataglie spagnole, venne gradualmente sostituito da quella del Santo Predicatore e la giovane Santa scomparve dalla devozione popolare.
San Vincenzo Ferreri è rimasto sino ai nostri giorni nelle formelle plasticate e in quelle scolpite nel legno dei carri agricoli. La sua festa cade il 5 di aprile.
La presenza Francescana nelle campagne tenne alto, presso di noi, il culto del “Santo” per antonomasia , Antonio da Padova. Anche la sua effigie era spesso presente nelle case col Divino Bambino in braccio. Meno frequente, invece, San Francesco d’Assisi.
San Giovanni Battista veniva festeggiato il 24 giugno con falò notturni, forse residui di antiche feste pagane. Per il suo giorno si raccoglievano gli agli, la lavanda e le noci acerbe per fare il nocino.
San Michele Arcangelo era molto popolare anche perché, nel giorno della sua festa in molti comuni avvenivano i cambi di pigione, in effetti, traslocare era detto, nel Bolognese, “Fèr Sanmichél” (Fare Sanmichele) (29 settembre).
Nel giorno dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno) si festeggiava il solo San Pietro perché a San Paolo, nella devozione contadina, era dedicato il giorno della sua Conversione (25 gennaio). Era nella notte della conversione di San Paolo che le ragazze da marito mettevano all’aperto un catino pieno d’acqua e, al mattino, successivo, studiavano i segni formati dal ghiaccio per trarne indicazioni sull’identità del futuro marito.
San Martino di Tours (11 novembre) godeva di un culto molto vasto, diffuso nei primi secoli dell’era volgare, dall’attiva predicazione dei Monaci Martiniani che, nel 631, erano presenti a Casalecchio di Reno ove, tuttora, esiste una Parrocchia a lui dedicata. Nel suo giorno avvenivano i cambi di colonìa “Par San Martéin as’manda via i cuntadéin” (Per San Martino si mandavo via i contadini).
Ancora oggi una ventina di Parrocchie sono a lui dedicate nella Diocesi. A proposito di questo Santo, non ho mai capito perché in certe zone goda fama dei mariti, diciamo così, sfortunati. A Cento nel suo giorno veniva eletto “il becco dell’anno”. La cosa è inspiegabile perché il Santo fu, dapprima, soldato, quindi Catecumeno e vescovo e, non prese mai moglie.
San Sebastiano (20 gennaio) e San Biagio (2 febbraio) erano, con Sant’Antonio (17 gennaio) i “Santi della neve”. Molti proverbi meteorologici si riferiscono a loro.
Tra le donne, Sant’Anna era invocata dalle partorienti, Santa Lucia per la vista e Santa Apollonia (Santa Pulônia) contro il mal di denti. Tra la decina di Caterine del calendario, la più nota era Santa Caterina d’Alessandria (25 novembre). Per il suo giorno chiudevano i caseifici e i contadini, finalmente, si rimettevano le scarpe che avevano tolto per San Giuseppe (19 marzo). Era molto popolare per la suggestione che provocava il racconto del suo martirio. La forza d’animo della bellissima giovane, l’ostinazione dell’Imperatore Massenzio nel volerla sposare, prima, e martirizzare, poi, le punte delle ruote che si piegano contro le tenere carni della giovinetta, facevano grande effetto sull’animo delle semplici genti di campagna (quelle di un tempo).
Alle grandi solennità cristiane ed alle ricorrenze dei santi si accompagnavano specialità culinarie. Tortellini per Natale e Capodanno col cappone, sfrappole per Carnevale, raviole per San Giuseppe, anguilla per la vigilia di Natale, uova e agnello per Pasqua, salame e uova per Pasquetta, l’oca per San Simone, e “fave dei morti” per il 2 di novembre, marroni e vino per San Martino, “Panspziél” (certosino) ancora per Natale, ecc.
Talune manifestazioni religiose sconfinavano, a volte, nella superstizione. Il “Paternostèr dla sémmia” (Padrenostro della scimmia) che recitavano le ragazze per ritrovare un oggetto smarrito, la paletta con le brace e l’ulivo benedetto con la quale l’ “arzdaura” (la padrona di casa) percorreva il perimetro della corte per scongiurare fulmini e grandine erano, senza dubbio, manifestazioni superstiziose.
Si credeva che l’incontrare un gobbo portasse fortuna e una gobba sfortuna. Se però la gobba era accompagnata da tre gobbi, eventualità assai improbabile, portava grande fortuna: “Tri gûb e ‘na gubéina , ‘na furtóna malandréina” (tre gobbi e una gobbina, una fortuna malandrina).
Lasciare l’ombrello aperto in casa portava disgrazia. Incontrare una donna il primo giorno dell’anno, portava disgrazia per tutto l’anno. Portava, invece, fortuna incontrare un uomo. I ragazzi, maschi, ne traevano profitto presentandosi il mattino presto dell’uno gennaio alle case, per “dèr al bôn ân” (dare il buon anno) e ricevere in cambio regali in denaro o in dolci. I cacciatori non potevano sparare ad un rettile perché, se l’avessero fatto, sarebbero scoppiate le canne del fucile (la “stiópa”). Se uno, incontrando un cacciatore, augurava, “Buona caccia”, il cacciatore tornava a casa.
Se il fuoco brontolava, era arrivato un forestiero. La prima notte dell’anno era obbligatorio fare festa ed essere allegri, perché “Quall ch’as fa la préma nôt dl’ân, as fa tótt l’ân” (Quello che si fa la prima notte dell’anno, si fa tutto l’anno).
All’inizio dell’anno e per ventiquattro giorni l’ “Arzdaur” (il reggitore della casa) faceva “al calander” (le calende), il primo giorno dell’anno rappresentava il mese di gennaio, il secondo febbraio e così fino ai dodici compreso. Col giorno tredici cominciava il conto alla rovescia: il tredici era dicembre, il quattordici era novembre, fino al ventiquattro che era gennaio. L’andamento stagionale di ogni mese, sarebbe stato l’opposto del giorno corrispondente, i più avveduti reggitori ponevano all’aperto brattee di cipolla. Da come si comportavano, gonfiandosi e contraendosi, traevano ulteriori indicazioni. Attenzione, però: se il giorno 25, Conversione di San Paolo era cattivo tempo, le calende non valevano: “Se al dé d’San Pèvel al va bûr, dal calander an’m’in cûr” (se il giorno di san Paolo è buio (brutto tempo) delle calende non me ne curo).
Agli ammalati si dava il brodo di pollo con dentro del pane grattugiato dell’infornata di Natale che, previamente benedetto, veniva conservato per tutto l’anno.
Nella case contadine non esistevano orologi. Il ritmo della vita era scandito dall’alternarsi del giorno e della notte. Della luce e del buio e, soprattutto, dal campanile della parrocchia. All’Angelus del mattino i rintocchi svegliavano i componenti della famiglia. Non “al biôich” (bifolco, colui che, della famiglia, aveva la responsabilità della stalla. Il bifolco salariato era chiamato “buvèr” (bovaro) ), che quello era sveglio da qualche tempo e, non per nulla, il Pianeta Venere, era detto “al starlôt di biôich” (la stella dei bifolchi).
Il campanaro, al mattino, fungeva anche da bollettino meteorologico. Se il cielo era sereno dava i soli rintocchi di rito. Se nuvoloso, un rintocco in più, due se pioveva e tre se nevicava. E il contadino si regolava se andare subito al lavoro o poltrire un poco.
All’Angelus del mezzogiorno mangiava e all’Avemaria della sera, quando il lavoro era molto , anche a “Compieta”, rientrava alla casa. [Compieta, nelle liturgia delle ore della fede cattolica è l’ultima preghiera che si recita prima di andare a dormire].
Il classico concerto campanario bolognese era composto da quattro pezzi “la grôsa” (la grossa), “l’amzèna” (la mezzana), “l’amzanèla” (la mezzanella) e “la céina” (la piccola).
Oltre alle ore ed ai momenti liturgici, le campane annunciavano gli eventi lieti e tristi. Quando un parrocchiano entrava in agonia ed il prete si recava alla sua casa a portare il sacramento della Estrema Unzione, il campanaro apriva la finestra del campanile rivolta verso la casa del poveretto e suonava le tristi note del “viatich” (viatico). Quando moriva un parrocchiano o una personalità religiosa, si suonava “la passè” (la passata) con un numero di rintocchi che variava secondo la persona defunta. Nove “botti”distanziati con “la grôsa” (la grossa), più due colpi per una donna, tre per un uomo, trentatré per un Parroco, sessantasei per un Vescovo e novantanove per il Papa. Durante i funerali si suonava “la purtè” (la portata) diversificata secondo la persona (sposata o meno). Per i bambini al di sotto dei sette anni il Cardinale Oppizzoni dispose che si suonasse “il doppio a festa”. La “céina” (la piccola) avvertiva i parrocchiani che una donna stava per partorire. Quando minacciava maltempo, tutti i pezzi suonavano, alternativamente “a squâss” (a scroscio), mentre per gli incendi “la grôsa” (la grossa) chiamava i parrocchiani “a starmîda” (a stormo).
All’alba della vigilia di Natale il concerto intero suonava “al dappi dal manza” (il doppio della mancia) per chiamare i poveri alla distribuzione della “spórta d’Nadèl” (la sporta di Natale), sussidio in danaro e generi alimentari che si dava alla povera gente per permettere a tutti di fare festa.
Inoltre le campane suonavano “al saggn dla Massa” (il segnale della Messa), “la benziän” (le benedizione), “l’angunî” (l’agonia, nei venerdì di Quaresima in preparazione del venerdì santo).
Il giovedì santo si “legavano” le campane che venivano sostituite da un arnese strepitoso detto “la bâtla dla stmèna santa” (la battola della settimana santa) o anche “scarabâtla” (scarabattola). Lo portava in giro il campanaro facendo un rumore indescrivibile. Verso le dieci antimeridiane del sabato santo le campane venivano sciolte e suonavano “al glôria dal sâbet sant” (la gloria del sabato santo). A quell’ora tutti procuravano di avere vicino dell’acqua per potere bagnarsi gli occhi al primo rintocco, e ciò per preservare la vista e la salute.
Molti concerti di campane della nostra provincia scomparvero durante la seconda guerra mondiale perché requisiti e fusi per farne corone di forzamento per i proiettili dell’artiglieria. Ora, molti parroci hanno creduto di fare bene meccanizzando quelli rimasti: hanno ottenuto il buon risultato di rompere diverse campane, altri ancora diffondono, con altoparlanti, nastri incisi con carillon di origine nordica che stonano col nostro ambiente. Forse, i nostri nipoti non conosceranno le campane. A gloria del Signore.
Il culto dei morti era molto sentito nelle nostre campagne. Quando moriva un parente, un vicino, un conoscente, partecipavano tutti al funerale, gli uomini separati dalle donne.
Per concludere questa panoramica sulla religiosità contadina, voglio ricordare, oltre alle processioni per i campi nelle “Rogazioni Minori” a protezione del raccolto, anche la gentile e generalizzata usanza di porre croci di steli di canapa o di canne con un ramoscello d’ulivo, in tutti gli appezzamenti del podere, nel giorno di Santa Croce (3 maggio).
VI SONO VOCABOLI CHE IN ITALIANO HANNO UN SIGNIFICATO ED IN BOLOGNESE NE HANNO UN ALTRO
Vocabolo / significato in italiano / significato in bolognese .
Antiquario / negozio di antichità / persona vestita all’antica
Avviato / partito o detto di negozio / abituato
Baccello / frutto delle leguminose / pasticcio, lavoro fatto male
Bagaglio / bauli e valigie / aggeggio di poco valore
Bagnolo / impacco o vasca per calce / spettacolo scadente, intingolo
Ballatoio / terrazzo o sporto / sala da ballo
Balocco / giocattolo / grumo di farina
Battello / imbarcazione / rovescio di pioggia
Bernardi / cognome / occhiali
Bidone / recipiente o fregatura / donna sformata
Bollata / carta valori o v.v. bollare / posizione, punto (con una sola “l”)
Bollettario / blocco di bollette / squattrinato
Bollo / marca / bollore (dim.: buiót=bollotto!)
Botto / colpo, deflagrazione / rospo
Bricco / cuccuma del caffè / montone
Bussola / arnese per orientarsi / mento sporgente
Cassa / contenitore di legno / sbornia
Castrone / cavallo castrato / rammendo fatto male
Cattura / arresto di delinquente / inganno, insidia, scherzo
Cenacchi / cognome / finto tonto
Chiara / non scura e nome / albume dell’uovo
Ciappino / parte adibita alla presa / piccolo lavoro
Cipollata / zuppa di cipolle / pomiciata
Compagno / amico, collega / uguale, simile
Compero / v. verbo comprare / acquistato in negozio
Cranio / parte dello scheletro / donna brutta
Credenzino / piccola credenza (al femminile) / petto, torace (scherzoso)
Cricca / combriccola poco onesta / sporcizia
Cricco / martinetto / colpo dato con due dita
Crociera / tipo di navigazione / appendiabiti
Cuccio / sinonimo di “cucciolo” / urto, spinta
Culata / botta presa sul sedere / colpo di fortuna
Derma / tessuto connettivo / sagoma o abilità di esecuzione
Fatto / v. verbo “fare” / strano, curioso (un fatto lavoro!)
Filone / d’oro o serie o furbo o altro / spina dorsale (d’la vétta)
Fisso / fermo, saldo / denso o moltitudine di gente
Fondata / deposito torbido di bottiglia / tuffo
Forma / vari significati / formaggio grana (anche grattugiato)
Gaggia / tipo di pianta / mento sporgente
Gatta / femmina del gatto / baccano, clamore, malessere (con un “t” sola)
Lambicco / sinonimo di “alambicco” / congegno mal funzionante
Leggera / cosa non pesante / discolo (con una sola “g”)
Maghetto / piccolo mago (H.Potter) / gruzzolo
Mammone / bimbo attaccato a mamma / pesante raffreddore
Mescola / mescolatura di cose / atteggiarsi al pianto (di bimbo)
Munire / attrezzare, fornire / otturare
Nido / detto di uccelli o altro / oggetto di poco valore
Noce / frutto / botta in testa con le nocche
Oca / animale, donna scema / membro virile
Paga / ricompensa / sconfitta
Pagella / documento con voti / persona simpatica
Pollaio / casetta per polli / confusione di voci, cicaleccio
Polpetta / cibo / persona infida, dispettosa, furba
Rana / animale / miseria
Rimescolo / agitazione interiore / confusione
Rotta / cedimento, sconfitta, tracciato / via aperta nella neve
Rusticano / relativo alla campagna / frutto del mirabolano (prugno selvatico)
Sbarazzino / ragazzo vivace / gioco di carte (asso pigliatutto)
Scagliare / gettare con forza / mancare il bersaglio
Scavarsi / farsi una buca / togliersi dai piedi
Scimmia / animale / sbronza (solo son la “s”)
Sguazzare / muoversi in acqua bassa / godere
Spianare / pareggiare un terreno / usare per la prima volta
Stabilire / prendere accordi, decidere / intonacare
Stellare / inerente alle stelle / spaccare legna
Stimarsi / ritenersi / darsi delle arie
Stoppare / fermare / otturare
Stornello / canzone popolare / giovanotto alto e aitante
Taccone / pezza di stoffa, toppa / macchia appiccicaticcia, coriacea
Tappo / turacciolo, uomo basso / bel vestito (d’origine gergale)
Tiro / v. verbo tirare o colpo, ecc. / bottone e apertura del portone
Tristo / sciagurato, mesto / poco abile
Tuffo / salto, immersione / cattivo odore
Vago / incerto, bello, ecc. / curioso, strano
Zuccata / colpo dato con la testa / fregatura
(Paolo Canè)
SIMILITUDINI USATE IN DIALETTO BOLOGNESE
Bèl ch’mé un ànzel = Bello come un angelo. Si dice anche in italiano “bello come un angelo”
Sudèr cumpàgn una bîstia = sudare come una bestia, anche se in dialetto “bìstia” è il bovino per antonomasia ed era quello lavorava molto, soprattutto nei campi, e perciò sudava!
Infiè (gànfi) cómm un bôt o (una butarâza) = gonfio come un rospo (o una femmina di rospo molto grossa).
Sfighè ch’mé un càn in cîsa = sfortunato come i cani in chiesa, e si sa, i cani, in quella situazione, hanno poca fortuna!
Brótt ch’mé al dièvel (un dèbit, la fàm) = brutto come il diavolo (o come un debito, o la fame). La fame è brutta dappertutto, ma forse le similitudini con il debito e la fame sono più tipicamente dialettali.
Córrer cumpàgn una lìvra = correre come una lepre. La lepre è l’animale veloce per antonomasia.
Antepàtich ch’mé una mérda = antipatico come una merda. Paragone non fine, ma credo si dica anche in italiano.
Testèrd cómm un móll = testardo come un mulo. Il mulo testardo lo è, anche se non è l’unico animale ad esserlo.
Lavurèr cumpàgn a un nàigher = lavorare come negro. Si dice anche in italiano, ma non perché i negri (meglio dire la gente di colore) lavorino più degli altri, piuttosto perché un tempo essi erano schiavi e perciò erano costretti a lavorare.
Spórch cómm un ninén = sporco come un maiale ed è buffo sottolineare come il maiale si chiami “ninén” a Bologna, “busgàtt” a Ferrara e “baghén” a Ravenna. Chissà come lo chiameranno ad Argenta che si trova nel punto dove queste tre province si toccano, forse “maièl”!
Mègher ch’mé un óss = magro come un uscio. Non c’è nulla di più magro di un uscio. Da non confondere con ôss (osso). La differenza per comprendere sta nell’accento sulla o.
Sàn cumpàgn un pàss = sano come un pesce. Sempre che i pesci siano veramente sani.
Móij cómm un pipién = bagnato come un pulcino. “Bagnato come un pulcino” lo si dice anche in italiano. Appena nati sono davvero bagnati fradici.
Càrgh (inaré) cumpàgn a un sumâr = carico come un somaro, si dice anche in italiano, mentre “eccitato (inaré) come un somaro” probabilmente si dice solo in dialetto.
Strazè (f’tè) cumpàgn a un zéngher = stracciato, trasandato (vestito) come uno zingaro.
(Paolo Canè)
SIMILITUDINI USATE IN DIALETTO BOLOGNESE PER INSULTARE
Ignurànt ch’mé un càpp = ignorante come un coppo. Il coppo deve essere ben poco intelligente, se ne sta esposto sul tetto al cocente sole d’estate e alle intemperie d’inverno!
Inamurè cumpàgn a un gât ràss = innamorato come un gatto rosso. Sembra che i gatti rossi s’innamorino più degli altri.
Mérd ch’mé la lòch = sporco come un allocco. È un noto ed antico detto, nel quale mérd (merda) è sinonimo di spórch (sporco). Si pensa che l’allocco (l’alòch) sia un uccello più sporco degli altri, tuttavia la lòch (scritto staccato) è la (sporca) ossia la pula delle biade, dei cereali in genere.
Catìv ch’mé al lóij = cattivo come loglio (zizzania). Anche qui, si può fraintendere che lóii possa essere il mese di luglio, ma in questo caso si tratta del loglio, l’erba cattiva che si trova nel grano, più nota come zizzania.
Magnèr ch’mé un lùder = mangiare come un ingordo. Questo lùder (ingordo) deriva dal latino l’utreum = otre (ed anche il poco usato ludro), cioè riempirsi come un otre.
Lóngh (o lànt) cómm la mèsna (ed sàtta) = lungo (o lento) come la macina di sotto. Lo si dice a chi è lento e comunque lungo a prepararsi, come la macina di sotto dei mulini che era più grossa e lenta dell’altra.
Indrî ch’mé i mlón = indietro come i meloni. Si riferisce alla maturazione dei meloni che, a quanto pare, è lenta. Si dice a chi è ancora indietro, non è ancora pronto.
Smórt cumpàgn a una pêza lavè = smorto (pallido) come una pezza lavata. In italiano si dice qualcosa di simile a “pallido come un cencio”; qui abbiamo “smórt” che è anche italiano (smorto), ma che è la sola parola bolognese per “pallido”. Per quanto riguarda la “pezza lavata” …si suppone sia bianca.
Imbariègh (in bulàtta) ch’mé un pózzel (un zvàtt) = ubriaco (o in bolletta) come una puzzola (o una civetta). In dialetto si allude a due improbabili maschi della puzzola e della civetta che vengono usati unicamente in questa frase. Gli stessi animali sono paragonati a chi è molto ubriaco ed anche a chi è completamente al verde: in bolletta, in questo caso la bolletta del Monte di Pietà e, in precedenza, il bollettino con l’elenco dei falliti (A. Menarini).
Svélt cumpàgn una sanguàttla (un pàss) = svelto come una sanguisuga (o un pesce). Evidentemente la sanguisuga è svelta a succhiare sangue, mentre il pesce, che abbiamo già visto nella similitudine con “sano”, è sicuramente svelto e guizzante.
Màt cumpàgn un s’dâz = matto come un setaccio. Questa è una delle più belle del nostro dialetto, che ci portiamo anche in italiano “matto come un setaccio”. Perché il setaccio? Perché esso fa passare il meglio (la farina) e trattiene il peggio (la crusca). Sarà matto o no?
Segrét ch’mé al tràn = segreto come un tuono. Bella anche questa, benché sia ironica, cosa ci può essere di meno segreto di un tuono, che tutti possono udire? Si dice infatti ad una persona che non sa tenere i segreti.
Sàurd ch’mé un zócch = sordo come una zucca al maschile (zucco). Un altro maschile strano (di zócca = zucca) che è usato solo in questo caso, quando si vuole definire chi è completamente sordo. Da non confondere con zôch che è invece un ciocco (un grosso pezzo di legno), la differenza sta nell’accento posta sulla vocale o.
Pîz che un zôp (ch’an la tróva mài pèra) = peggio che uno zoppo (che non la trova mai pari). È una frase che si dice a chi non è mai contento, a chi trova sempre qualcosa da dire (praticamente a un “sufésstich” un sofisticato o radical chic come si direbbe ora) e precisamente a chi “non la trova mai pari” proprio come (paragone impietoso) uno zoppo.
Bàn ch’mé al pàn = Buono come il pane. Lo si dice di persona buona, non c’è nulla di più buono del pane, ma questo è un bellissimo complimento.
(Paolo Canè)
AGGETTIVI RAFFORZATIVI
In dialetto (anche in italiano, ma qui è del dialetto che parliamo) esistono aggettivi accompagnati da un secondo aggettivo “rafforzativo” e insieme vanno ad accentuare il concetto, a formare una locuzione che è in pratica un superlativo. A volte questo secondo aggettivo si pronuncia con questa vera funzione rafforzativa, altre volte con intenzioni ironiche o per strappare un sorriso.
Amalè mórt = (Ammalato morto). Era un modo un po’ crudele di definire una persona molto ammalata, con poche speranze di sopravvivenza.
Chèld buijànt. (Caldo bollente) è il contrario di “freddo gelato”.
Chèr arabé. (Caro arrabbiato). Si dice di prodotto o servizio molto costosi e probabilmente l’aggettivo “arrabbiato” si riferisce ai tempi in cui la rabbia era una cosa seria.
Dàulz m’lè. (Dolce come il miele). Si dice di frutto o bevanda troppo dolci e alcuni traducono la locuzione nel buffo italo-bolognese “dolce melato”, magari con una smorfia. M’lè deriva da mél = miele, ossia a dire dolce come il miele.
Fràdd z’lè. (Freddo gelato). Di qualcosa che forse dovrebbe essere più caldo e invece non lo è per niente.
Grâs técc. (Grasso paffuto). Difficile capire il della parola técc (che noi traduciamo in italiano con “ticcio”), ma di certo è allegro, al contrario di stlê, (magro da sembrare una stecca di legno), anche perché in passato la magrezza era indice di miseria, al contrario della grassezza.
Imbariègh dûr. (Ubriaco duro). Quando un tempo gli ubriachi erano molti più di oggi, gli aggettivi rafforzativi erano tanti, ma “duro” era il più diffuso
Inamurè spånt. (Ubriaco completamente). In questi casi spånt vale “completamente” o “del tutto” o “fradicio” o “perdutamente”, ecc.
Incazè nàigher. (Incazzato nero). Si dice così anche in italiano, col significato di molto arrabbiato, ma l’aggettivo “nero”, significa forse che la persona così incazzata è come se non ci vedesse.
Lóngh s’tàis. (Lungo disteso). Quando qualcuno cade e rimane a terra disteso.
Màt dûr. (Matto duro). Quando uno è completamente matto.
Mègher stlê. (Magro da sembrare spaccato, una stecca di legno). Infatti stlêr significa spaccare la legna in particolare. Il suo significato esprime anche tristezza, come se la persona non fosse più integra, ma spaccata, secca, senza linfa. Spesso quando si pronuncia questa parole (stlê) si fa anche un’espressione del viso, quasi schifata. Come per dire “poveretto non ce la fa più”.
Mój spåult. (Bagnato fradicio). Soprattutto quando si viene sorpresi da un acquazzone improvviso e pesante.
Pén pèra. (Pieno pari). Pieno fino all’orlo, o pari all’orlo del contenitore. Significa solitamente molto pieno.
Salè murdànt. (Salato mordente). Troppo salato, al punto che il sapore è violento da “mordere” il palato.
Sótt bràssch. (Asciutto bresco). È un’espressione del gioco delle carte, quando di un dato seme si possiede un solo esemplare, questo è “asciutto bresco”. Ma non si conosce bene l’etimologia di questa parola.
Spôrch lérz. (Sporco lercio). Più che sporco, lercio, lo si dice anche in italiano.
Stóff mèrz. (Stanco marcio). Di persona molto stanca. Si dice anche “stóff mórt” (Stanco morto). Non si riesce più neppure a fare un passo.
Paolo Canè
PAROLE DIALETTALI DI USO COMUNE NEL MONDO CONTADINO E CHE ANCORA OGGI, SE SENTITE DA BAMBINO, POSSONO COMMUOVERE
“Nôz” = Nozze, Matrimonio, Pranzo nuziale.
Prima della cerimonia in chiesa, gli invitati si trovavano a casa della sposa, dove bevevano un “Rusôli”, (un Rosolio, liquore dolce) con una fetta di ciambella (“Brazadèla”). Dopo il matrimonio si svolgeva il pranzo nuziale sempre a casa della sposa. Si iniziava con le portate “da brôd” (in brodo) (tortellini, cappone e manzo bolliti, cotechini, ecc.). Si proseguiva poi, con le portate asciutte (lasagne, maccheroni pasticciati, faraone arrosto, galletti alla cacciatora, lombo di maiale, ecc.). Si finiva coi dolci: torta di riso, torta di croccante, zuccherini, zuccheroni, ecc.). Dopo un riposo di un paio d’ore, nel prato o sotto un porticato, gli invitati si recavano a casa dello sposo, dove il pranzo veniva ripetuto.
♣
“Al bûs d la Jâcma” (Letteralmente il buco della Giacoma)
Squarcio che si forma nelle nubi ad Ovest Nord-Ovest e che, secondo la credenza popolare. È sintomo di miglioramento del tempo.
♣
“Panîr” = Cesto.
Un cesto fabbricato a mano dal “Paninèr” (Cestaio), che usava i rametti più sottili del salice, decorticati, in alcuni tipi di cesto, oppure con la scorza, o di altre piante come le “Vitalbe” (Clematis alba e Clematis flammula).
Nel mondo contadino ne esistevano una quantità sorprendente.
“Panîr da û” = Cesto per raccogliere e trasportare uva.
“Panirén da zrîs” = Cestino per raccogliere le ciliegie. Più piccolo del precedente, con manico centrale, veniva appeso ai rami del ciliegio mediante un “unzén” uncino di legno collegato al cestino con una breve corda. Per i bambini che contribuivano alla raccolta delle ciliegie, c’era un apposito “Panirén da zrîs” della grandezza “dal cul ed capèl” (del fondo di un cappello).
“Panirén da frèvel” = Cestino per le fragole, piccolo, basso e svasato con manico centrale ad arco, veniva costruito con vertici di salice più sottili.
“Panirénna da cûsar”, detto anche “Panirénna da i archétt” = Cestino usato dalle donne per tenervi il necessario per il lavoro di cucito. Piccolo molto svasato con manico centrale ad arco, decorato ai fianchi con archetti di salice sottile.
“Panirån da pan” = Cesto grande per il pane, basso allungato, con due manici ai lati più stretti.
“Panîra da bughè” = Cesto per il bucato. Grande, basso allungato con due manici laterali più stretti.
“Panirån d la laggna” = Cestone per la legna. Grande ed alto, rotondo fatto di vertici non decorticati, con manici laterali. Veniva usato per la legna.
“Panirén da fîgh” = Cestino per i fichi. Simile a quello delle ciliegie, ma più piccolo e svasato.
“Panîr da sumnèr” = Cesto di media grandezza, in salice o in “ràza” (rovo), con ordito interno in erba o foderato. Serviva per la semina dei cereali.
“Córgh o Córga” = Cesto grande, cilindrico a maglia larga in salice oppure in “clûr” (nocciolo). Serviva per il trasporto del fieno, della paglia, ecc.
“Gradézza” = Letteralmente graticcio. Di forma ellittica, più arrotondato ad un lato. Piano, in genere fatto con la vitalba. Serviva per stendere la frutta ad essiccare.
“Vèsta” = Deriva dalla parola: vestito. Cesto per contenere i “zuccón” le damigiane. Cesto robusto, grande in proporzione alle damigiane da contenere, in salice non decorticato, con due robusti manici laterali.
♣
“Marûga” = Marruca (Paliurus australis) Della famiglia delle Ramnacee. Veniva coltivato per fare siepi con rami fitti e spinosi. Pianta originaria delle regioni mediterranee dove forma roveti impenetrabili nella macchia. Ha un frutto a forma di disco del quale sono ghiotti alcuni uccelli come i frosoni. Si dice che piaccia molto ai gatti, per questo viene chiamato anche “Spén gât”. E’ detto anche “Spén giudén” = Spino di Giuda o meglio di Cristo. La leggenda vuole che con quei rami dalle spine lunghe e robuste, sia stata intrecciata la corona di Cristo.
♣
“Sanguàttla” = Sanguisuga – Hirudo medicinalis
La comune mignatta delle paludi e delle risaie. “Sanguàttla” era detta anche la ragazza agile e vivace.
♣
“Stariàn” = Stregone. Oltre a vari personaggi più o meno dediti alla cosiddetta “stregoneria” o divinazione tramite le loro fatture, c’erano anche preti, sospesi o meno, “a divinis” che esercitavano la stregoneria. Uno di questo, si sa, abitava fuori porta San Donato in Via della Torretta di fronte al Convento delle Clarisse. Le persone che passavano davanti “A la ca’ dal prît stariàn”, si facevano sempre i segno della croce. La casa venne distrutta nel 1944 da un bombardamento alleato.
♣
“Qual ch’an dîs brîsa al prît al li dîs al ciàrgh” = Quello che non dice il prete, lo dice il chierico.
♣
ALCUNI SUGGERIMENTI DI MIO NONNO
Tótt i càn scôsen la có, tótt i minción vólen dîr la só (tutti i cani scuotono la coda, tutti i minchioni vogliono dire il loro parere).
An’s pól brîsa bàvver e stuflèr (non si può bere e, contemporaneamente, fischiare). (Non si possono fare due cose in una sola volta).
An èser brîsa tânt pàr la quêl (non essere molto disponibile o affidabile).
Il nostro era un dialetto povero. Di gente povera, però era usato quotidianamente per comunicare notizie, emozioni, dichiarazioni d’amore, odio, lite.
Lo si parlava in famiglia, mangiando, dividendo i compiti che ciascuno aveva nella giornata.
Il dialetto ti fasciava, ti avvolgeva, nominava le cose che ben conoscevi, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi animali, le tue piante, con nomi diversi e paralleli a quelli della lingua italiana.
Lo si parlava in negozio, raccontando chi era morto (“A ‘n srà mia véra!”), chi è nato, chi aveva sposato chi (“ Chi el tólt”), durante le rare feste da ballo invitando una ragazza a ballare, al tavolo da gioco, con un pugno da spaccare il tavolo nella bussata e una bestemmia che davvero sembrava spaccarlo in due, quel tavolo.
Lo usavano quelle donne in preghiere locali, lontane dall’improbabile latino ecclesiastico. Ed era segno di distinzione, di appartenenza ad una comunità, ad un campanile.
(Brano tratto da “Tralummescuro” di Francesco Guccini.) Giunti Editore 2019.






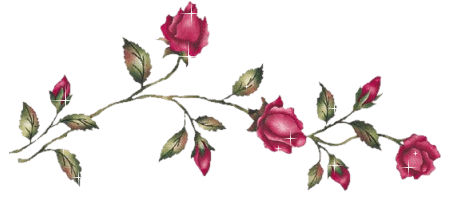


[…] i tovaglioli). E' un blog che spiega l'antico dialetto bolognese. Se volete vedere la fonte: https://speradisole.wordpress.com/lan…o-bolognese-4/ Rispondi […]
"Mi piace""Mi piace"
L’antico dialetto bolognese (COMMENTI)
In questa pagina si conservano i commenti all’antico dialetto bolognese.
Per leggere l’antico dialetto bolognese cliccare l’altra pagina.
Grazie.
21 Risposte
sandrovivan novembre 23, 2010 alle 5:31 pm | Modifica | Replica
Non ho dubbi:il dialetto è una ricchezza culturale da preservare, anche insegnandolo a scuola.
Cordiali saluti.
gibran novembre 24, 2010 alle 9:36 am | Modifica | Replica
Quando era piccola non riuscivo a capire i zii la nonna i cugini,purchè fossi di Anhiari il valtiberino non lo capivo.Sansepolcro
Monterchi,Pistrino erano dialetti incomprensibili per me.Ma il bolognese li batte tutti.Io ho una cognata bolognese,anche se non parla il dialetto se non con la madre mi piace tanto.
Ciao speradisole un abbraccio Lidia.
Amos novembre 25, 2010 alle 9:20 am | Modifica | Replica
Ciao,
complimenti a te e a tutti quelli che si occupano del dialetto bolognese.
Permettimi di esporre il mio parere sulla forma del tuo pezzo che è cosparso di molte inesattezze. Tante sono tollerabili, ma te ne cito un paio non accettabili (secondo me).
“Panza peina l’han sa id cla vuda”
l’han significa l’hanno, ma tu volevi dire l’an dove an significa non.
id non esiste, si dice ed.
Il più spettacoloso degli svarioni, però è:
spéttaquél
una parola non può avere due accenti tonici.
Sarebbe meglio (secondo me) scrivere:
spetâcuel
l’accento tonico è sulla a che è, in questo caso, una vocale lunga (ecco il perché dell’accento circonflesso).
Nel dialetto bolognese, poi, spesso le doppie dell’italiano non ci sono.
In bolognese, ancora, il suono che in italiano si rende con la lettera q, lo si rende con la lettera c (spetâcuel). Tranne all’inizio di parola: quèder (quadro).
Ti saluto cordialmente.
Amos
speradisole novembre 25, 2010 alle 9:50 am | Modifica | Replica
Grazie Amos, come vedi sono una dilettante, voglio conservare le mie antiche radici. Nel senso che tento di trascrivere gli appunti che tratto man mano dalle consversazioni dei miei nonni.
Però è chiaro che, pur sapendolo parlare e capire, scrivere il dialetto bolognese è un’impresa grande.
Non so come ringraziarti, e poichè ne ho ancora da scrivere, ogni tanto, per favore, leggi e se trovi errori, sono ben lieta di correggerli.
Un abbraccio amos e grazie ancora.
P.S. Ti sono grata se vorrai correggere,non solo gli svarioni più ovvi, ma anche le inesattezze. Grazie
ALDO JANI NOE’ novembre 27, 2010 alle 11:07 am | Modifica | Replica
E’ sempre un piacere incontrare chi si impegna a mantenere viva l’attenzione sulla genuina parlata bolognese. Tanto ricca di colore, simpatia ed espressività.
E ogni volta mi accorgo che il cruccio che ci accomuna è l’interrogativo riferito al nostro dialetto: “Si conserverà? Ha un futuro?”.
Dal canto mio, assieme ad altri appassionati della materia siamo ottimisti. Convinzione sostenuta da un divertimento che iniziò nel 2002, quando demmo vita al Corso di Dialetto Bolognese al Teatro Alemanni. Oggi stiamo realizzando l’XI edizione e abbiamo incontrato oltre 1000 persone a cui abbiamo fornito, negli anni, gli strumenti base per un approccio moderno e linguisticamente rigoroso al dialetto bolognese con gli strumenti che esso, che è una lingua a tutti gli effetti, richiede: fonetica, grammatica, sintassi.
C’è chi pensa che sia esagerato. Ma cosa si direbbe di un autore e di un editore che ponesse in circolazione scritti sgrammaticati e incerti nel discorso? A essere buoni: “Lâsa bän pérder!”.
Il contrario, invece, succede al dialetto bolognese. Attorno al quale, troviamo in libreria, accanto a una pregevole grammatica, a un prezioso dizionario e ad alcuni gustosi testi di colore sulla nostra tradizione, tanta “robaccia” scritta come capita o come sentito dire. Con la scusa che il dialetto è quello che si parla.
Questo può essere anche vero. Ma ciò vale anche per l’italiano e, quando sentiamo discorsi imprecisi e storpi nelle concordanze scattano in noi alcune reazioni negative che, per il dialetto, queste, forse si limitano a un senso di simpatica diffidenza del tipo “Mo in dóvv êl nèd lû-qué”. Quando poi le inesattezze vengono convalidate dal passaggio in stampa e mostrate nelle vetrine delle librerie (ancor peggio sugli scafali delle biblioteche) il danno diventa rilevante e “al bulgnaiṡ”, di giorno in giorno si impoverisce, diventa inaffidabile e sicuramente bastardo.
Che fare? Quello che mi viene è un piccolo impegno a migliorare la propria conoscenza del nostro dialetto – anche se si è madrelingua -. Basta leggere – non dico studiare – Dscårret in bulgnaiṡ? Manuale e grammatica del dialetto bolognese di Daniele Vitali, per farsi un’idea precisa della struttura e delle caratteristiche della nostra bella lingua.
Il resto viene con il dialogo, la corrispondenza con altri che hanno la consapevolezza di trovarsi di fronte, non a una moda ma a una lingua che, per chi è originario delle nostre parti, racchiude un po’ della propria storia.
Un invito: diffidare degli improvvisati cultori della materia; leggere il manuale del Vitali; entrare in contatto con “La Bâla dal Bulgnaiṡ”.
Che è un gruppo di persone che senza essere un comitato, un’associazione, un ente, senza dover dare un’adesione formale, amano soffermarsi – quando si incontrano – nella maniera più spontanea possibile e simpaticamente bolognese, su aneddoti e modi di dire della nostra miglior tradizione.
Dove trovarli? Su internet qualche riferimento: http://www.clubdiapason.org – http://www.bulgnais.com
speradisole novembre 27, 2010 alle 4:56 pm | Modifica | Replica
Sono commossa!
Il grande Aldi Jani del tg in dialetto! Grazie infinite.
Temo però di essermi messa in un lavoro più difficile di quanto pensavo.
Infatti io ho una piccola agenda dove ho appuntato le espressioni dialettali dei miei nonni, ma ad alcune non so dare una risposta dialettale esatta.
Per esempio la parola “polsa” (con la o circonflessa che qui non riesco ad inserire econ una zs) cioè “pulce” veniva spesso usata dal nonno per definire un avaro. Diceva che uno è tanto avaro da levare la pelle ad una pulce per venderla. E’ un’espressione assai efficace, ma tradurla in dialetto bolognese è un’impresa.
Altra parola che mi riesce di non capire bene è “aveir al spirit taiarein”. L’ho scritta ma non so che significhi veramente.
Ti ringrazio anche dei consigli che mi dai, delle notizie che il tuo sito fornisce e dei libri che posso trovare in libreria sul dialetto bolognese che mi possono aiutare. Non voglio libri in cui non mi ritrovo, magari scritti con buone intenzioni ma che non esprimono il dialetto bolognese vero.
Anch’io sono un po’ “bastarda” perchè sono nata a Castello di Serravalle e conservo qualche cadenza diversa dal bolognese vero.
Ti faccio un esempio, da me il bidone del rusco si chiamava “al bandon” non “al biden”, con la e che sta tra la o e la e, difficile da riprodurre per iscritto.
Oppure per dire sono stata, sono andata, si dice a “son stà, son andà”, mentre il bolognese vero dice “son stè, son andè”.
In ogni modo con un po’ di buona volontà, voglio tenere queste testimonianze.
E’ come il primo amore al quale si resta sempre uniti con nostalgia.
Grazie anora Aldo Jani, visiterò spesso il tuo sito per trarre ispirazioni.
Ciao, un abbraccio.
ALDO JANI NOE’ dicembre 10, 2010 alle 7:27 pm | Modifica | Replica
Lasän bän pêrder äl comoziän. E’ grazie a chi, come te, spende qualche energia attorno al bulgnaiṡ. Mi pare che il tuo blog coaguli interessanti commenti sull’argomento.
Ho sempre avuto ammirazione per quelli che tenevano un taccuino su cui appuntare… Io ho provato tante volte ma non è mai durato a lungo.
Secondo me la frase del tuo nonno si potrebbe tradurre con “Acsé grécc’ da cavèr la pèl a na póllṡa par vànndrla”.
E “avair al spîrit tajarén”, che non ò mai sentito, forse potrebbe riguardare una persona che si esprime in modo tagliente (?). Sicuramente Amos, che vedo che dialoga con il blog può illuminarti.
Non adombrarti per aver avuto natali ‘ariosi’. Ho sempre detto che son tutti belli i dialetti del mondo. Credo solo che quando uno consegna un testo all’editoria dovrebbe avere il buon senso di farlo solo se in possesso di buona conoscenza della lingua in cui si esprime (Questo vale anche per l’italiano). Adesso, che la strumentalizzazione politica ha trasformato la lingua del popolo in una moda, per sete di fama, appaiono in libreria testi di improvvisati cultori del dialetto. Così pseudo-editori, per ‘fame di pilla’ sdoganano come scrittori del vernacolo, modesti ‘barzellettari’ che tentano di balbettare desuete storielle nel nostro dialetto: in nome della cosiddetta simpatia bolognese.
Complimenti ancora per il tuo blog e appena avrò terminato il Festival della Canzone natalizia bolognese sul Nutizièri ti contatto per una breve intervista a una blog-divulgatrice dal bulgnaiṡ.
Aldo
Fabio aprile 26, 2011 alle 3:48 pm | Modifica | Replica
In casa mia ho spesso udito la variante “avair al spirit ed tajaven”
amos novembre 27, 2010 alle 9:05 pm | Modifica | Replica
Chèra Spîra ed såul,
che bello vedere una giovane con questi begli intenti.
Sta da sentire:
tè la mia email ce l’hai. Perché non metti assieme un po’ di quelle cose che vorresti conservare (non solo le parole, ma anche i discorsi, le cante, le ninnenanne) e le scrivi con i mezzi che hai (senza cercare di tradurre il serravallese in bolognese.)
Mandami un assaggio e chissà che non troviamo la strada di scrivere benino in serravallese (e bene in bolognese).
Mi raccomando però “pian barbîr che l’âcua la scòta!”
Ciao
Amos
speradisole novembre 27, 2010 alle 11:01 pm | Modifica | Replica
Grazie Amos, raccolgo l’invito.
Adagio sì per non scottarsi.
“Ocio al spiguel”
Ciao Amos, a presto.
Luigi Lepri dicembre 5, 2010 alle 10:03 am | Modifica | Replica
Lodevole l’intenzione, ottimi i commenti di Aldo e Amos. Approfittane! Non fare come quei “buontemponi” che per il solo fatto di parlare un dialetto si autonominano professori in materia! Cerca di scriverlo in modod corretto. Qual è il modo corretto? E’ quello che consente a chi legge, se usa un po’ d’attenzione, di emettere una pronuncia foneticamente giusta, o quasi, pur conoscendolo poco o nulla.
Se il dialetto lo si scrive male, non gli si fa un buonservizio, ma, anzi, lo si danneggia pur non avendone certo l’intenzione.
Dunque, modifica la grafia! Non è affatto complicato e Amos può indirizzarti bene!
Ciao – Gigén
speradisole dicembre 5, 2010 alle 5:14 pm | Modifica | Replica
Carissimo Gigèn, amico di Amos. Grazie.
Sfrutterò anche te, visto che “Ed bacajèr bugnèis ad piés”.
Arrivederci per email. A presto Ciao.
Luigi Lepri dicembre 5, 2010 alle 10:05 am | Modifica | Replica
Lodevole l’intenzione, ottimi i commenti di Aldo e Amos. Approfittane! Non fare come quei “buontemponi” che per il solo fatto di parlare un dialetto si autonominano professori in materia! Cerca di scriverlo in modo corretto. Qual è il modo corretto? E’ quello che consente a chi legge, se usa un po’ d’attenzione, di emettere una pronuncia foneticamente giusta, o quasi, pur conoscendolo poco o nulla.
Se il dialetto lo si scrive male, non gli si fa un buon servizio, ma, anzi, lo si danneggia pur non avendone certo l’intenzione.
Dunque, modifica la grafia! Non è affatto complicato e Amos può indirizzarti bene!
Ciao – Gigén
gibran dicembre 5, 2010 alle 10:26 pm | Modifica | Replica
speradisole,che dirti che sei geniale,anche se il bolognese,ci capisco poco.Nel mio pensiero alcune cose le capisco ma non le so tradurre.
Ad ogni modo penso che in tutte le regioni il dialetto non dovrebbe dimenticato,senza che diventi un ossessione nelle scuole.Non credi?
Ad ogni modo complimenti per l’iniziativa.
Un abbraccio Lidia.
speradisole dicembre 6, 2010 alle 12:31 am | Modifica | Replica
Il mio è solo il tentativo di chi cerca di non dimenticare da dove viene.
Come sai sono attaccata molto alla famiglia, e della famiglia voglio conservare tutto quello che posso, compreso la parlata schietta e simpatica dei miei nonni.
E’ difficile però, mi sto accorgendo che si tratta proprio di una lingua diversa con suoni e cadenze che non si possono tradurre sulla tastiera.
Alcuni signori di Bologna, come Amos, Luigi ed Aldo mi stanno aiutando e spero di riuscire a scrivere, almeno le parole ed il loro significato che ho scritto nella mia agenda di famiglia.
Grazie Lidia, amica carissima, sempre attenta. Un grande abbraccio.
speradisole dicembre 19, 2010 alle 11:29 am | Modifica | Replica
(QUEL PARE A RIGUARDAR LA GARISENDA
SOTTO IL CHINATO,QUANDO UN NUVOL VADA
SOVR’ESSA SI’,CHELLA INCONTRO’PENDA
TAL PARVE ANTEO A ME CHE STAVA A BADA
DI VEDERLO CHINARE.
DANTE ALIGHIERI.
Commento di gibran dicembre 18, 2010 @ 6:41 pm |Modifica
Replica
Gibran gennaio 12, 2011 alle 10:08 am | Modifica | Replica
Il dialetto Bolognese è una lingua molto ricca e espressiva,possiede una forte carica pittorica che unita a una pronuncia che”riempie”la bocca la fanno risultare estremamente simpatica e compiaciuta di se.Il dialetto di Bologna è caloroso,colorato e esprime un forte autocompiacimento che rivela una forte considerazione che emerge anche dai sui proverbi.(Par cgnosser un Bulugnèis al vol un an e un meis;e po quand t’l’hè cguuso,t’an cgnoss brisa cum at canoss lo.)
(Per conoscere un un bolognese,ci vuole un anno e un mese;e poi quando l’hai conosciuto,non lo conosci quanto lui conosce te.)
speradisole gennaio 12, 2011 alle 1:44 pm | Modifica | Replica
Grazie Lidia, bellissimo aiuto, lo metterò tra i detti bolognesi che sto scrivendo.
Un grande abbraccio. Ciao
speradisole aprile 27, 2011 alle 11:35 am | Modifica | Replica
@ Fabio. Grazie amico bolognese. Anche in casa mia si ricorda ancora, ed i miei nonni lo dicono, “avair al spirit ed tajaven”, forse è la variante più giusta perchè collega lo “spirito” inteso come alcool, al vino.
Un abbraccio Fabio. Ciao.
speradisole giugno 19, 2011 alle 11:26 pm | Modifica | Replica
Adoro il dialetto Bolognese e l’EmiliaRomagna in toto.
A volte noi Italiani non ci rendiamo conto del patrimonio culturale che ci offre questo piccolo paradiso chiamato Italia. E’ un vero peccato perchè siamo fortunati e non ce ne rendiamo conto, e la roviniamo!!
ciao
Ross
Commento di ross giugno 17, 2011 @ 6:51 pm |Modifica
Replica
P.S. Ho spostato in questa pagina il commento di ross (grazie Ross)
speradisole gennaio 16, 2012 alle 9:46 am | Modifica | Replica
Tiziano on gennaio 16, 2012 alle 8:15 am said: Modifica
Ciao, mi piace chi vuole mantenere memoria in una città che ha la facilità a perderla. Vorrei proporre tre argomenti, a te e a chi legge il tuo blog, tre cose squisitamente bolognesi che sfido qualunque bolognese di oggi a conoscere.
1) Il velino bolognese molto più importante dello Studio per l’economia della città nei secoli passati, prodotto della proto-industria della seta e dimenticato tra ’800 e ’900
2) il cane bolognese, allevato in città ed amato da tutte le corti europee, fortunatamente salvato dall’estinzione rischiata nel dopoguerra.
3) La Santa di Bologna, Caterina dè Vigri, copatrona della città, che per fortuna vede un momento di riscoperta grazie ad alcuni lavori di ricerca e pubblicazione delle opere, è una figura che dovrebbe innanzitutto interessare una donna, perché è stata una delle più grandi donne del primo Umanesimo.
firmato: un amante del passato.
NOTA: HO SPOSTATO IN QUESTA PAGINA IL COMMENTO DI TIZIANO che ringrazio vivamente. Proverò anche a riprendere gli argomenti che mi sono stati suggeriti. Grazie ancora per la sensibilità e per l’amore della mia città.
"Mi piace"Piace a 1 persona
vorrei contattare/scrivere, chi segue “l’antico dialetto bolognese” come posso fare? (non ho trovato alcun indirizzo -mail)
grazie
"Mi piace""Mi piace"
Carissima, chi scrive del dialetto bolognese, sono io, che abito a Bologna. Mi diletto (con fatica perchè non conosco bene le tecniche moderne) a tenere un blog col nome “speradisole”. E sono io che ho la tua mail, perchè hai scritto al mio blog.
Appena posso, ed il tempo me lo concede, ti scriverò, così potrai “contattarmi”.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Mi dispiace che hai dimenticato una parola che esiste solo a Bologna: dammi il TIRO!
in nessuna altra città esiste la scritta sul pulsante “TIRO”
"Mi piace""Mi piace"
E’ vero Federico, questa del “Tiro” non l’ho scritta, grazie per avermela suggerita, l’aggiungo subito all’elenco. Se te ne vengono in mente altre. ti sono grata se me le suggerisci. Grazie e “At salut”
"Mi piace""Mi piace"
il “tiro” esiste anche a venezia…
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Thomas,
non lo sapevo, annoveriamo anche Venezia nel “tiro” della luce o della porta alla bolognese.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
ciao! complimenti per il blog! ti aspetto per una visita sul mio!
http://dialettandocinsieme.blogspot.it/
"Mi piace""Mi piace"
Ciao samifed, complimenti anche a te. Ho contraccambiato con piacere la visita e ti metto tra i blogroll.
Ciaoa Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Involontariamente è stato cancellato un interessante commento a questa mia pagina sul dialetto antico. Chiedo scusa per il disguido, ma il computer l’aveva elaborato come “Spam” forse perchè conteneva parole in dialetto.
Comunque la persona mi chiedeva se potevo trovare la spiegazione del perchè certe parole sono mantenute nel dialetto bolognese e quale fosse la loro origine.
Dico subito che non sono in grado di spiegare l’etimologia delle parole, è al di sopra delle mie capacità, io volevo solo dare risalto ad un dialetto che mi è caro, anche se non ne conosco l’origine.
L’unica cosa che posso dire è perchè si dice da noi “dammi il tiro” anziché “apri il portone”. Nell’ottocento le case dei bolognesi senza luce, avevano all’esterno una campanella e per avvisare il portiere, occorreva “tirare” appunto la cordicella per farla suonare. Di qui la parola “tiro” che ancora oggi è scritta sugli interruttori che vengono posti all’interno delle nostre case, per aprire il portone.
Nella altre città esistevano i battacchi.
"Mi piace""Mi piace"
Non in tutti i palazzi c’era il portiere, c’era invece una cordicella nella tromba delle scale che da ogni piano si poteva tirare per aprire il portone senza dover scendere, difatti era quello fuori che chiedeva il “tiro” per poter entrare.
"Mi piace""Mi piace"
il “tiro” era anche una maniglia, fissata nel pavimento con un treppiede (a casa di mia zia fino al 1984 ce n’era una, già in disuso), che appunto tirava una corda che apriva lo “scrocco”. Ripeto, non è prerogativa della sola Bologna, intendo: il meccanismo e la parola.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Thomas della spiegazione.
Ciò non toglie nulla, credo, a Bologna e al suo dialetto.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
da qualche parte ci starebbe bene anche il “catuvino”
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Marinella, lo metto subito fra le parole che ancora oggi si dicono a Bologna.
Un bell’aiuto, grazie ancora ed un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
da dove deriva il detto “…. del trentadue”? Ad esempio “oggi fa un freddo del trentadue”? Conosco il significato ma non da dove deriva
"Mi piace""Mi piace"
Non sono sicura, ma probabilmente si riferisce all’anno 1932, quando venne una gran nevicata con gelate intense. Purtroppo di questi detti si conservano i suoni e le parole, ma la vera spiegazione per cui sono nati è difficile da ricercare.
Per esempio un “tirasò” per un bolognese significa una persona che non mantiene la parola, o che prende in giro. La parola si rifà addirittura al tempo in cui le mura circondavano la città e le porte venivano chiuse la sera. I frodatori del dazio issavano le merci sui bastioni servendosi di corde munite di uncino. Erano chiamati dal popolino i “tirasò”, a volte succedeva che qualcuno tirava le corde e poi le lasciava andare e quindi sia le merci che le persone ricadevano fuori dalle mura. Caddero le mura, ma la parola restò per indicare chi si prende gioco del prossimo.
Ciao Paolo.
Se ti interessa saperne di più, su Bologna e sul suo dialetto,puoi rivolgerti a.
Associazione No Profit Succede solo a Bologna – Via San Petronio Vecchio 15 – 40125 Bologna – Orario: Da Lun a Ven: 10-14/16-19 – Sab: 10-14 – 051.226934
"Mi piace""Mi piace"
Grazie, gentilissima, effettivamente coincide con quanto avevo sentito dire, ma l’espressione ha assunto un significato talmente generico che mi sembrava strano si riferisse solo alla nevicata del trentadue. Però si sa, la gente tende sempre a generalizzare ed è proprio questo che trasforma una frase in un modo di dire. Credo che il fascino dei dialetti stia soprattutto nel richiamare i fatti più particolari e le usanze antiche (il tuo esempio del tirasò è perfettamente calzante), diventando così una fotografia dei tempi. Grazie ancora e buon natale a tutti 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Dovrebbe invece riferirsi ai moti insurrezionali del 1832, come in altre regioni per il 48.
"Mi piace""Mi piace"
Propendo anch’io per il 1832, anche se non ricordo, una volta avevo trovato l’origine. Ma a Bologna si usa anche “l’è suzes un quarantot”
"Mi piace""Mi piace"
Già, è verissimo, ma cosa è successo nel ’48? (1848)
Con ogni probabilità segna l’inizio del Risorgimento italiano.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Ciao, complimenti per il blog. E’ molto carina come idea. La traduzione di “SEMBRANO” è PERAN?? Mi sai dire che accenti ci vogliono? E anche sulla parola “cranvel” occorre qualche accento??
Grazie mille
"Mi piace""Mi piace"
Sì, in dialetto bolognese SEMBRANO al plurale si dice «Î PÈRAN» La i solitamente viene messa per indicare il plurale del verbo, l’accento circonflesso perché nel pronunciarla la voce viene leggermente calcata ed altrettanto leggermente allungata nel tempo. Se invece usi il singolare SEMBRA, si dice «AL PÈR»
In entrambi i casi l’accento sulle e è grave (il tono è aperto come nel verbo essere).
La parola «CRANVÈL» (Carnevale) anche qui l’accento è grave e la e si pronuncia aperta.
Ma se dimentichi qualche accento non succede niente, un bolognese capisce subito cosa intendi dire.
Grazie a te. Ciao carissima.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie! Spero non dispiaccia se userò le preziose indicazioni dialettali per una canzonetta “didattica”… 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Mi fa molto onore. Simpatica l’idea di una canzonetta didattica.
Ciao e buon lavoro.
"Mi piace""Mi piace"
Bellissimo!!!!
Adoro e amo Bologna e le terre circostanti.
A Persiceto dove vivo continuiamo a parlarlo grazie al Carnevale dove la maggior parte dei persicetani partecipano e lavorano.
Chi è Persicetano inevitabilmente viene risucchiato dall’arte del carnevale e proprio nei cantieri grazie alla varietà di età esiste ancora la voglia di imparare e parlare il dialetto sebben i calare. Anziani che parlano solo dialetto e giovani che devono adattarsi (con gran voglia e felicità). Sapere la nostra lingua antica non è solo una soddisfazione ma è anche mantenere una identità. La zirudela di Re Bertoldo letta in dialetto in Piazza è una tradizione e spero che continui ancora sebbene la gente vede tuto questo come una cosa volgare. Dialetto “Par Tòta la vèta” PS scriverlo purtroppo è impossibile….
"Mi piace""Mi piace"
Bravissimo Massimo “Par tóta la véta” Per sempre. E’ difficile scriverlo, ma anche leggerlo questo dialetto particolare che è il bolognese. Non solo ma è sufficiente passare da una zona ad una appena un po’ più lontana ed ecco che cambiano molte cose. Cambiano le cadenze, le pause, i suoni. Per me una poesia.
Un abbraccio alla nostra amata città ed ai suoi splenditi dintorni. E un abbraccio anche a San Giovanni in Persiceto e a tutti i persicetani.
Grazie. Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Gubbiare= dormire. Taffiare= mangiare
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Massimo, benvenuto dove si parla dialetto.
Gubbiare e Taffiare sono due verbi rimasti nel dire comune dei veri (pochi) bolognesi. Peccato che si senta parlare sempre più raramente.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
cara speradisole io abito in campagna a bologna e tutti i miei parenti parlano il dialetto e anche io le tue poesie sul dialetto sono molto belle e mi piacerebbe che tu le aggiorneresti cosi potrei condividerle. un bacio e un abbracciorosita
"Mi piace""Mi piace"
Inizio ringraziandoti per il bel lavoro che stai facendo e che mo ha dato la possibilità di sorridere leggendo le belle frasi del nostro meraviglioso dialetto, io sono nato a Bologna ed esattamente in via Broccaindosso a pochi passi dal portone dove visse Giosuè Carducci e ricordo (perche lo diceva mio padre) che da piccolo mi portò davanti alla casa di Carducci per farmi vedere il famoso melograno della poesia……. il mio intervento comunque è solo per congratularmi con te per ciò che stai facendo ciao e grazie a nome di tutti i bolognesi come me
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Roberto. Accetto con piacere anche i complimenti.
Sto cercando di mettere insieme i vecchi detti, quelli che erano la “vita” dei bolognesi di anni fa. Purtroppo molte cose si perdono, e non è bello, quello che fa tradizione e che ci distingue andrebbe preservato.
Conosco via Broccaindosso per averla percorsa tante volte, quando andavo a scuola. Mi piace perché è bolognese, storica ed, un tempo, sede dell’ospedale maggiore.
Ogni tanto, quando ne trovo, aggiungo qualche frase o qualche altro detto bolognese nella pagina. Ogni volta che vorrai visitarla sarai il benvenuto.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Ciao, mi ricordo una espressione di mia mamma quando un ravanello era mezzo vuoto dentro. Scusandomi la ortografia diceva al “ravanel l’é catlán”. Non sò se era cosa di mia mamma o una frase tipica del nostro dialetto-
Saluti da un Bolognese da Siviglia
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Maurizio
E’ un modo tipico bolognese di definire un ravanello (o altra radice edule) vuota dentro o stopposa. “Ravanèl catlàn” ravanello vuoto. Non so dirti perché “catlàn”, forse perché, se toccato, risuona vuoto come un campana.
Bella Siviglia!!!
Un abbraccio da Bologna.
"Mi piace""Mi piace"
Non potrebbe derivare dalla Divina Commedia, che i nostri bisnonni leggevano come favola? Inferno – Canto ventitreesimo I frati gaudenti: Catalano e Loderingo – vv. 73-108, (della Milizia della Beata Vergine Maria) bolognesi, nel girone degli ipocriti, rispetto alla loro condotta in vita: all’esterno mostravano una splendida figura, covando nel loro interno il loro cupo pensiero reale.
L’analogia con i ravanelli, forse azzardata, prenderebbe dal nome di Catalano, in dialetto Catlàn, che appunto è un ravanello ancora bello fuori e brutto dentro. Non utilizzabile per essere mangiato.
"Mi piace""Mi piace"
Carissima,
bellissimo il tuo richiamo alla Divina Commedia, sulla parola dialettale “catlàn” (vuoto dentro e bello fuori). Potrebbe essere davvero l’origine della parola bolognese, Catalano (ipocrita) secondo Dante, dà veramente l’idea di che cosa significhi la differenza tra il vero pensiero dell’ipocrita rispetto a quello che dice. Quante volte abbiamo sentite parole false. E’ così suonano male come un ravanello vuoto dentro. Catlàn, appunto.
Spero che Maurizio legga questo tuo commento, perché è veramente originale e tutto sommato fa sentire i nostri anchi avi dei “poeti”.
Ciao, un abbraccio, Spera.
"Mi piace""Mi piace"
Molte grazie Speradisole, mi sono reso conto di haver commesso una inesattezza credo che mia madre dicesse “radizen” o qualcosa di simile per indicare i ravanelli.
Ho vissuto in Calunya 22 anni e que bello sarebbe que avessimo saputo conservare il nostro dialetto anche la metá di loro. Molte grazie ancora per la tua attivitá, te ne sono grato.
Saludos
"Mi piace""Mi piace"
In effetti “ravanèl” è bolognese di Bologna mentre “radiséin” (piccola radice, radichetta) è più della provincia verso il modenese. Ma sia ravanèl che radiséin indicano il ravanello, quello piccolo rosso oppure quello bianco più lungo.
Io ringrazio te, e sono convinta che sentire qualche parola del nostro vecchio dialetto emoziona anche te.
Contraccambio i “saludos” e ti mando un “besos”
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Sono sempre più dell’idea che il dialetto andrebbe conservato vivo, invece i giovani di oggi non solo non lo parlano ma non lo comprendono ! “Spera di sole” era il nome dell’antologia, fra i miei libri di scuola….. grazie per questa stupenda pagina, bella come il nostro dialetto !
"Mi piace""Mi piace"
Il nostro dialetto si sta perdendo e non capisco perchè, visto che in altre parti d’Italia, il Veneto per esempio, non fanno altro che parlare il loro dialetto. Penso che sia una cultura da conservare, se si potesse, ma ormai è raro sentirlo parlare purtroppo. Proviamoci con questi ricordi.
“Spera di sole” infatti è una bellissima favola di Luigi Capuana.
Grazie Adele, accetto con piacere il tuo apprezzamento.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Senza un aiuto delle istituzioni (Comune di Bologna) é impossibile mantenere vivo il nostro dialetto. Siccome risiedo all’estero non so se cé qualche iniziativa in corso.
Un abbraccio
"Mi piace""Mi piace"
Puoi tenerti informato su Bologna quasi in tempo reale. Ti suggerisco questo indirizzo:
• Via San Petronio Vecchio, 15
• 40125 Bologna
Telefono 051 226934
E-mail info@succedesoloabologna.it
Sito Web http://www.succedesoloabologna.it
Oppure accedere alla pagina Facebook : Succede solo a Bologna
Auguri e un abbraccio
"Mi piace""Mi piace"
Beh… quando ormai i 3/4 delle famiglie sono miste bolognesi/meridionali (al 95% lui di giù, lei di qui), un sindaco che fa Merola di cognome, e un’immigrazione selvaggia, unita ad una silenziosa (badanti, amanti, prostitute…)… “Mo csa vut pretander??”
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo,
non pretendiamo nulla, solamente cerchiamo di non perdere le nostre radici, le nostre fonti, le nostre origini, anche se rimaniamo in pochi.
E’ sempre un onore essere e sentirsi “bolognesi”.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Speradisole,
Un abbraccio
"Mi piace""Mi piace"
Ottimo lavoro, complimenti, veramente lodevole !!!
Alcune cosette però…
Bacajèr è un verbo usato quasi sempre in tono dispregiativo nei confronti dell’interlocutore ( parlare ma non sapere bene ciò che si dice e anche dire cose futili )
———————————————————————————————————————————
In aggiunta, se può essere utile :
mò zizla ! , mò filza ! (interiezioni ) = accipicchia !, accidenti !
la parola secchio : sèc ( secchio in alluminio ) , mastela o mastèl ( secchio in legno ), calzaidar ( secchio in rame – paiolo in rame da polenta )
rèc com al count Palavizèn = essere davvero ricchi
ludar = super goloso ( brot ludar t’an y eter ! ) = Sei solo un grande goloso !
Scioglingue ( chiedo scusa per la scrittura, non avendo qui i tasti speciali ) :
Lola l’ela li la lom = Lola ha lei la luce a petrolio ?
T’an vad t’a ti t’ont un tac = Non vedi che ti sei unto un tacco ?
culour papa fràdda = bianco come un cencio
pifàr = ( letterale : piffero ) offesa che significa “allocco, sciocco, grullo, di una persona che si fa prendere in giro.
bujè, bujarii = boiata, cavolata, “cazzata”
pra’l bus d’la Jacma = ( letterale ” per il buco di Giacoma ), significato = per il rotto della cuffia
sgrènfia = sgrinfia ( donna infida )
squènzia = ragazza giovane sbarazzina
tersuà ( antico saluto ) = Salve !
on mainpipéto ( una persona che si vanta e non sa nulla, un nato ieri ) frase : t’an sè gnanc mainpipéto = non sai proprio nulla !
una scèmmia ( una simmia ) trad. una sbornia
pinèin, fangèin ( bimbo appena nato o molto piccolo ) ( ant. bolognese )
nèe l’an dal squasadein = ( nato nell’anno di pioggerella ) trad. = nato sciocco
squàss = diluvio
bajoc ( pl.bajùc ) = soldo, soldi
a piòv che Dio a’ l’ é manda = piovere a catinelle
acua pedar che al counvèint a’ l’ brùsa oppure solamente parte della frase : acua pedar ! = ( acqua padre che il convento brucia )
trad. = sta diluviando !
an savair gnanc papa fràdda = non sapere nulla
sé, la rélla ! = parola intraducibile che significa = figuriamoci ! ma figurati !
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo, ti ringrazio per i complimenti. Li accetto sempre con piacere e ti ringrazio anche dei suggerimenti. Sarà mia cura introdurre anche i tuoi contributi in quello che sto scrivendo ora (in ordine alfabetico), per rendere più facile e accessibile la lettura e la comprensione del dialetto bolognese, in partticolare dell’antico dialetto.
E’ un lavoro molto lungo e ci metterò del tempo, ma poco alla volta arriverò alla fine
Grazie ancora e un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
bellissimo !!! ce ne vorrebbero altri
ci vorrebbe qualcosa che traduce dall italiano al bolognese in automatico anche se immagino sia difficilissimo
"Mi piace""Mi piace"
Purtroppo anche Google traduttore non arriva a tanto, ma leggere, così, per curiosità, ogni tanto, qualche espressione bolognese, può essere interessante per coloro che vivono a Bologna o nella provincia.
Ha un sapore di antico, ma tanto bello.
Ciao carissimo Lorenzo, un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Fantastico! Amo il dialetto.. sono le nostre radici! Ci sono modi di dire che sono molto più efficaci in dialetto che in italiano.Ricordo un detto del mio nonno materno che riusciva a farmi piangere quando ero piccolina: “Stet que stasira c’anden a trab
da Froll?( Stai qui da me questa sera e vieni con me a casa di Frullo a sentire le sue storie?) Ma io piangevo perchè la sera volevo andare a casa mia! Allora per farmi ri-
dere mi raccontava:”Al set che a gli ot ai ven c’al nov dutour c’al dis che agli ong di
pi ien dog? ( Lo sai che alle otto verrà quel nuovo dottore che dice che le unghe dei
piedi sono..dodici?) Così io ridevo. Nonna Elena 17 gennaio 2014
P.S.Scusate gli errori, ma vi sono paciute? Ciao a presto vi seguirò spesso!
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Nonna Elena,
metterò volentieri questa tua simpatica filastrocca nella pagina principale del dialetto, prima dell’elenco alfabetico dei proverbi e dei detti contadini, Ci starà benissimo.
Intanto ti ringrazio di cuore e se hai altre proposte per il dialetto sono ben contenta di accettarle.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Socmel! Questa è una delle pagine più belle di sempre di tutta Internet. GRAZIE!!!!
"Mi piace""Mi piace"
Non ho mai ricevuto un complimento così grande. Grazie a te Emanuele, confesso che mi ha fatto immenso piacere.
Un saluto ed un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Ed è meritatissimo, anzi.
Mi è capitato di leggere in giro degli estratti con alcune di queste parole (mai piu’ di un terzo) ma erano dei vocabolari: lemma e significato.
Questo si legge con estremo gusto: il significato messo in anticipo, con questa brevità, innesca il gioco di “dirlo” prima di leggerlo.
Poi c’e’ tutto il resto, che non avevo fatto in tempo a leggere e saraà una mia lettura oggi in aereo tornando a Bologna! 🙂
Aggiungi, se non l’hai già fatto, quelli indicati nei commenti… Ho visto che ce ne sono altre, o sbaglio?
Grazie ancora e ancora molti complimenti!!
EP
"Mi piace""Mi piace"
Ottima l’idea: tutto serve per contrastare il regresso di un bene culturale come il dialetto. Peccato, però, per la costellazione di errori grammaticali e ortografici. In questo modo, chi volesse imparare, assimila degli errori. Sarebbe come se, insegnando l’italiano, si avvalorasse come giusta la forma “Ho stato a Bologgna, comera bella…”. Disponibile, se credete, ad aggiustare gli errori. Cordialmente – Luigi Lepri
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo, sono onorata di ricevere indicazioni dal Maestro Lepri. Conosco la sua bravura e la sua capcità di scrivere bene (e parlare bene ) il dialetto bolognese, cosa per niente facile.
Sono d’accordo, accetto volentieri, la correzione degli errori. Sono consapevole che ce ne siano tanti, per questo farò avere il mio indirizzo mail.
Grazie infinite e abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Il mio non vuole essee un commento. Non trovo il modo per comunicare con il sito ed allora scrivo qui.
Ho letto la ninna nanna della Campana di San Simone e mi è tornata in mente anche se un poco differente un’altra ninna nanna. Eccola:
LA CAMPANA
D’SAN SIMÄN
LA CAMPENA
ED FRA’ SIMON
Din, dän, din, dän din da le don
La campana d’San Simän la campena ed fra simon
Tot al dé i la sunèvén tott al dè la suneva
Pan e vén i guadagnèvèn pan e vein la guadagneva
Guadagnèvén un pèr capän guadagneva un per d’capon
Da purtèr ai só padrän id
I só padrän in j éren a ca id
J’éren invézi dapp a l’óss iern’a ca ardapp a l’oss
A taièr gli uracc al cócch a tirer gli uracc al cocch
Cócch, cócch, malandrën id
Dà la vólta al to mulën da la mola a buratei
Dà la vólta al to canèl buratein casca in tera
Da la mola a la dunzela
La dunzela stramazò
Trantasi ain amazò
Ai armes al puiglot
C’al canteva dè e not
Lasa pur c’al canta
C’ha j ó trei fióli da maridèr cl’ha trai fiol da marider
Ónna cûs e pó la taja onna fa i capi ed paia
Onna fa i caplën ed paja l’etra fa i scrannein furè
Onna fa i caplën ed spën sblesga ed za e sglesga ed là
Fa la nana al mi fangën. ……………………..
poi non so più continuare.
"Mi piace""Mi piace"
Carisimo Franco, il sito è questo blog, dove ho inserito i miei ricordi del dialetto bolognese.
Ti ringrazio per aver ampliato la “campana di San Simone”.
Io la ricordavo ancora più breve e fra i miei parenti e conoscenti che conoscono e parlano il dialetto bolognese, non ce n’è uno che che uno che ricordi di più.
Perciò ti sono doppiamente grata. Completerò la campana di San Simone, appena il tempo (assai tiranno) me lo consentirà.
Intanto, se hai altri suggerimenti, li accetto volentieri,
Puoi sempre scriverli qui, nel blog, come hai fatto con questo suggerimento.
Un abbraccio e un “At salût”.
"Mi piace""Mi piace"
Scusate l’entrata a gamba tesa, è la prima volta che mi collego.
Stavo appunto cercando qualche sito che si occupasse del dialetto bolognese perchè ho un tarlo che ogni tanto viene a rodermi la memoria.
C’è qualcuno che sa come come si dice in dialetto : “ARCOBALENO”?
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Franco,
non so risponderti. Ricordo però che mi si diceva: “Guèrda c’ha jé l’Arcobaleno in zil”.
Secondo me, non esiste il corrispettivo in dialetto. Ma più di me ne sanno Amos Lelli e Luigi Lepri, che hanno scritto libri sul nostro dialetto.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
arc in zìl
"Mi piace""Mi piace"
Intendi “arcobaleno”?
Ciao Elena ….at salùt e Bon Nadèl.
"Mi piace""Mi piace"
Arc in zil , tratto dal francese epoca napoleonica ( Arc en ciel )
"Mi piace""Mi piace"
Che bella questa raccolta di dialetto bolognese . Interessantissima
Un abbraccio , buona serata
rosy 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Rispondo in ritardi e me ne scuso. Ma il blog non presenta, in prima pagina, i commenti relativi alle “pagine” speciali del blog stesso.
Grazie carissima, so che mi segui ogni tanto e mi onoro di vedere i tuoi “mi piace”.
Un saluto ed un abbraccio. Speradisole
"Mi piace""Mi piace"
E’ un peccato perdere i dialetti e quindi le origini.
"Mi piace""Mi piace"
Sì, per questo cerco di tenere questa raccolta di detti antichi. Sono la storia dei nostri nonni.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Che dire è veramente bello e interessante, ho trovato il sito gironzolando in Zà e in Là su internet.
Non so scrivere in dialetto chiedo perdono.
Scrivo, oltre che per complimentarmi , per sapere se questo modo di dire, che ho sentito in famiglia, sia da considerarsi bolognese … sa vut cal sona una rumanza ? ( vuoi che sappia suonare una romanza?) .
Il detto deriverebbe da un episodio accaduto in un paese sconosciuto dove in occasione di incendi al parroco e al campanaro era affidato il compito di suonare le campane per dare l’allarme.
La scena sarebbe più o meno così
– suonano alla porta ” presto presto signor arciprete suonate le campane che si è incendiato il mulino”
il prete e il campanaro in tutta fretta si vestono ed iniziano a salire le scale del campanile per adempiere al loro dovere. Sfortuna vuole che davanti ,nel salire le scale , vi sia il vecchio parroco che forse per l’angustia del momento e del luogo emette ad ogni scalino una scoreggia , il povero campanaro da sotto dopo qualche scalino non ne può più e si lamenta con il parroco :” insomma signor Arziprit che sotta as respira brisa”
E il parroco di rimando :” Sa vut che un cul al sonna una romanza ?
Ciao e grazie
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Roberta,
sì la scena è tipica del bolognese e della terra della campagna bolognese.
Ti ringrazio di averla raccontata e la metterò sicuramente tra i vari “modi di dire” bolognesi.
Me ne hai fatta ricordare un’altra, che ho sentito spesso, attribuita ad un prete (nel bolognese la gente, almeno una volta, anche se diceva parole un po’ scurrili non lo faceva mai con l’intenzione di offendere, ma per esprimere quella capacità scherzosa e geniale che è tipica della gente di questa terra).
C’era un prete che mangiava abbondantemente ed era anche dotato di una buona carica di umorismo. Veniva spesso invitato a pranzo, ma inevitabilmente, vuoi per la voracità con cui divorava le varie portate, a fine pranzo…scoreggiava (faceva le puzzette come si dice adesso).
Ma lui beatamente esclamava: “Tromba di culo, sanità di corpo” e giù con una bella e grassa risata.
Grazie Roberta, un abbraccio.
P.S. L’allarme dato con le campane era una caratteristica della campagna quando c’era un pericolo, si chiama STARMIDA. Era un suono a battuta frequentissima della “grossa” la campana più pesante. Veniva suonata anche in tempo di guerra, per avvisare la gente dei rastrellamenti delle SS in corso nelle campagne. Così. gli uomini, correvano a nascondersi.
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Speradisole, sono venuta a conoscenza di questo meraviglioso sito solo oggi, perchè essendomi definita con una giovane amica “un caval ed scaja” a causa di una serie di acciacchi che mi stanno arrivando, mi sono accorta che mi ascoltava non sapeva cosa volessi dire. Così dopo aver dato una veloce spiegazione alla mia interlocutrice, ho voluto cercare di approfondire. E qui non solo ho trovato ben due spiegazioni diverse, ma ho conosciuto questo meraviglioso e me lo sto leggendo tutto.
L’argomento non è elegante, ma mio nonno Elia (1888-1972) completava la frase “tromba di culo, sanità di corpo” con “chi non scoreggia è un uomo morto”. lui lo diceva in dialetto, ma io non so scriverlo.
ed in effetti, se ci pensa, quando si va in ospedale, dopo un in intervento chirurgico, il medico chiede “ha canalizzato?”
"Mi piace""Mi piace"
come si fa aperdereil bologneseo qualsiasi altra lingua popare semlice chiaarlo DIALETTO e la cultura chiamarla FOLCLORE- lemiliano-romagnolo è una lingua con le sue varietàlocali (tra cui il bolognese)-e come ogni lingua bisogna trattarla da lingua-è assurdo che non esista un FRASARIO dove vengono indicati saluti, e frasi quotidiane- (come ci sono in lingua veneta, sarda, siciliana, insubre, corsa ecc) è assurdo non presentarl come lingua nel suo insieme e non piangiamo poi perla sua scomparsa, tanto l’uomo sta distruggendo ogni biodiversità.
"Mi piace""Mi piace"
Su Internet esistono vari siti che parlano di dialetto bolognese (o emiliano-romagnolo in senso lato) ma il nostro dialetto è molto difficile, rispetto ad un veneto o ad un napoletano, inoltre è parlato da un classe di persone ben definita, quella detta “del basso ceto”. del contadino, dell’operaio o del facchino o muratore d’un tempo. Non è mai stato la lingua dei padroni, dei grandi ricchi o dei grandi personaggi. E’ una lingua che è rimasta nel basso ceto.
Ed è naturale che sia scomparsa o quasi, Sono in pochi ora a parlarlo, se non quei volonterosi che si attaccano alle tradizioni.
Ciao Mario.
"Mi piace""Mi piace"
Salve,
L’idea dei dialetti che esistono in Italia mi interessa molto. Sono una studentessa e vorrei fare una ricerca colle persone giovani (hanno tra i 18 e i 26 anni) che possono parlare in dialetto, quello di Emilia-Romagna incluso. Sa qualche persone che questo progetto a loro interesserebbe? Non è necessario che parlano la lingua regionale o dialetto fluentemente. I partecipanti verranno intervistati e le risposte saranno audio registrate, il tutto in forma anonima. Durante l’intervista, dopo aver chiesto la provenienza e l’età del partecipante, farò al massimo 12 domande riguardanti l’utilizzo della lingua regionale, al termine delle quali, se sarà possibile, registrerò una breve conversazione nella stessa lingua, a cui dovrò allegare una traduzione in italiano, per la quale richiederò aiuto all’intervistato. La partecipazione è volontaria e non è obbligatorio rispondere a tutte le domande. Per ulteriori chiarimenti, puoi inviare un e-mail a me ceceliab@uoregon.edu.
"Mi piace""Mi piace"
Carissima,
ti aiuterei volentieri, ma dei tanti giovani che ci sono nella mia famiglia nessuno parla il dialetto bolognese. Lo parliamo solo noi che siamo già in età piuttosto adulta. Non è che non lo vogliano parlare è che la scuola li ha educati diversamente, e anche se un po’ mi dispiace, è meglio che sappiano parlare l’italiano correttamente.
Ti auguro di trovare molto giovani, ma nella nostra regione è difficile. Non è come il Veneto dove tutti parlano il dialetto anche i bambini.
Se desideri puoi provare in questo sito https://nutizieribulgnais.wordpress.com/ loro si occupano da sempre del dialetto bolognese e ci sono molte persone interessate.
Auguri e buon lavoro.
"Mi piace""Mi piace"
ciao mi sovviene una parola petroniana (la conosci già sicuramente) comunque la dico ugualmente la coperta imbottita si chiamava la querta zibè (credo si scriva cosi ma non ne sono sicuro) ciao e alla prossima bella parola petroniana
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Roberto
grazie della parola petroniana ma sinceramente non la conosco la coperta imbottita con l’aggettivo “zibé”. Forse occorre trovare un vocabolario dialetto bolognese-italiano, molto fine e completo.
Da noi si diceva “cuérta inbutê”.
Il dialetto bolognese ha poche parole che iniziano con la Q e non ha la “m” davanti alle conconanti come “b” e “p” bensì la n. Non saprei dirti altro perché pur consultando i vocabolari online del dialetto bolognese, queste parole non ci sono.
Grazie in ogni modo e se ti ricordi qualche altra parola, sarà lieta di dialogare con te.
Un saluto carissimo.
"Mi piace""Mi piace"
http://ilbolognese.blogspot.it/2007_07_09_archive.html
In questo sito si cita la Cuérta zibè (coperta imbottita) oggi “cuérta imbuté”.
……………. “Un “dinosauro”, qualcosa di estinto, come “dinosauri” sono moltissimi termini dei nostri nonni che possiamo trovare nei testi, in qualche antica commedia, ma che oggi suonerebbero come una fastidiosa ostentazione. Tipico esempio è quell’articolo di certa Liliana Nobili Sangiorgi apparso sul foglietto “Al pànt d’la Biànnda” di cui ho già parlato in altra sede. Cito a caso: ……………….. ”
Ciao
Roberta Francia
"Mi piace""Mi piace"
per la coperta imbottita, dalle parti di San Giovanni/Sant’Agata si diceva “Querta zibeda”
Credo derivi dal fatto che era imbottita e cucita
"Mi piace""Mi piace"
Sono d’accordo con Franco
zibato ……. impone di stringere o d* ingrossare la persona, d’ imbottire o di nascondere il petto. …… avea seco di prezioso e particolarmente d’un giubbone zibato, pieno di gran quantità d’oro” …. …Bologna il 3 ott. del 1584
Piccolo giubbone imbottito portato, a scopo protettivo, dagli uomini d’arme sotto la corazza.
ciao Roberta F
"Mi piace""Mi piace"
Grazie a Roberta e grazie a Franco per il contributo.
Mi sento molto nostalgica a parlare del nostro dialetto.
Davvero unico e speciale.
Un abbraccio ad entrambi e ancora grazie.
"Mi piace""Mi piace"
Vorrei una spiegazione su questo modo di dire … ho capito il detto chi va a nozze cerca di avere un bambino, una famiglia, ma non capisco il nesso con il resto della nota .
Era usanza … Tutti gli invitati non portavano i regali alle nozze o solo ” i santoli” del battesimo ?
Per la candelora …. da Wikipedia
La festa è anche detta della Purificazione di Maria, perché, secondo l’usanza ebraica, una donna era considerata impura del sangue mestruale per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù.
” Quando una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà immonda per sette giorni; sarà immonda come nel tempo delle sue regole. L’ottavo giorno si circonciderà il bambino. Poi essa resterà ancora trentatré giorni a purificarsi dal suo sangue; non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione » (Levitico 12,2-4)
La mia mamma ( di nome Maria, fra l’altro nata il 2 febbraio), non è stata ammessa in chiesa fino al 40° giorno della mia nascita …. nonostante fossi femmina.. Verso e direi contro le donne la chiesa cattolica ha sempre, perlomeno in passato, applicato la legge del “melius abundare quam deficere” .
Un abbraccio a tutti
Roberta Francia
Chi va a nôz, va a bambôz = Chi va a nozze va a (lett. bamboccio) cioè a bimbo piccolo neonato.
Era usanza che gli invitati al pranzo di nozze venissero invitati anche al battesimo, anzi, mentre a nozze non si portavano regali, al battesimo si dovevano portare.
Alla cerimonia non partecipava la madre alla quale era interdetto l’ingresso in chiesa sino alla ricomparsa del flusso mensile, previa, tuttavia di un’assoluzione del peccato originale che, in tempi maschilisti, pare toccasse solo la donna. La cerimonia si svolgeva quasi di nascosto, con l’ingresso, in chiesa, della donna (neomamma) che doveva portare in mano una candela accesa benedetta il giorno della candelora il 2 febbraio. L’ingresso non poteva avvenire dalla porta principale, ma da un porta secondaria laterale.
"Mi piace""Mi piace"
Cara Roberta,
il nesso del detto sta tutto nel fatto che, secondo la Chiesa cattolica (di sempre) andare a nozze cioè sposarsi e quindi dormire nello stesso letto, doveva portare inevitabilmente a gravidanza. Non c’era verso l’atto sessuale era finalizzato alla procreazione. Da qui le sfilze di figli e via discorrendo.
Pertanto i doni venivano riservati per il battesimo che inevitabilmente era la cerimonia successiva per i due novelli sposi.
Ma la mamma era esclusa dalla cerimonia battesimale, non era stata accolta in Chiesa con la candela benedetta e non le erano ricomparse le mestruazioni, perché il neonato veniva battezzato dopo pochi giorni dalla nascita. La Chiesa sosteneva che, se fosse morto prima di essere battezzato, non sarebbe andato in Paradiso, ma nel Limbo (Cosa di cui nessuno parla più fortunatamente).
La donna è considerata impura anche nella Bibbia, come si legge nel libro del Deuteronomio. Per esempio l’uomo non poteva avere rapporti sessuali con lei se era mestruata. La donna per la religione (qualsiasi religione, anche la cattolica) è sempre stata quella che doveva procreare e basta.
Fino a pochi decenni fa, la Chiesa cattolica si interrogava se la donna avesse l’anima oppure no, visto che la Bibbia, la fa “nascere” da una costola di Adamo e quindi su di essa Dio non ha soffiato il suo spirito. Direi che era (o lo è ancora) considerata una creatura di seconda mano.
Non so se sono stata chiara. Spero di sì.
Grazie per la tua curiosità.
Come vedi vado piano nel copiare i detti bolognesi, ma con un po’ di pazienza arriverò alla “zeta.”
Un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Ciao,
io vorrei chiederti una cosa…dovremmo fare uno striscione da portare allo stadio il prossimo anno, vorremo scrivere ”Sempre con te …. sempre più innamorato” , mi potresti dire come si scrive esattamente in Dialetto?? (Sampèr còn tè….. sampèr piò innamurè )??!
"Mi piace""Mi piace"
Caro Fabio,
ti mando l’indirizzo di Luigi Lepri, una persona che non solo parla e scrive divinamente il nostro dialetto, ma è anche molto disponibile ad aiutare le persone che lo vogliono scrivere correttamente.
A me ha corretto tutti gli errori che avevo fatto.
Semmai digli che ti sei rivolto al mio blog “speradisole” che lui conosce e che ti ho suggerito di scrivergli.
Ciao e buona fortuna per lo stadio del prossimo anno, Immagino sia per il “Bologna”.
luigilepri.bo@gmail.com
"Mi piace""Mi piace"
ciao e complimenti per questo meraviglioso blog!
i miei parlano dialetto, io lo capisco benissimo ma non lo parlo, le mie figlie nemmeno lo capiscono 😦 e la cosa mi rattrista sinceramente…e mi rattrista ancor di più sapendo che buona parte è colpa mia che non ho saputo tener viva la ns Bologna, i ns detti, le usanze se non in cucina…vedrò di metterci UNA PEZZA!!!
Volevo dirti che mio nonno, che abitava agli Alemanni, tutte le domeniche si vestiva a festa e poi diceva a tutti (in dialetto) che “andava a Bologna”, per dire che andava in piazza a parlare con gli amici
Mia nonna, quando voleva sottolineare che eravamo troppo magre, ci diceva (sempre in dialetto) “mangia, che sei come un sospiro di Santa Brigida” … e questo l’ho sentito dire anche da tante altre persone. Che si riferisse a quei biscottini che fanno per le fiere?
L’ultimo, è il BRISA! Una parola che sia i miei nonni che i miei genitori dicevano sempre per interromperci, per non farci fare qualcosa, per vietare..
Ciao e grazie ancora!!!
Spero che un giorno possa nascere anche il MUSEO DEL DIALETTO BOLOGNESE!
Viviana
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Viviana,
ormai il bolognese come dialetto è solo “uno stato d’animo”, un passato che non ritorna e mi dispiace moltissimo.
Tuttavia, mi fa rabbia che il dialetto veneto, per esempio, sia parlato dappertutto e nessuno si vergogni. Per non parlare del romanesco o napoletano. Qui, da noi, invece, pare che parlare dialetto sia qualificare le persone come popolane, incivili, incolte e così via.
Ci sono persone che tentano di continuare una tradizione, ma ormai sono solo una nicchia.
Sono spariti i “Burattini” dove Fagiolino e Sganapino parlavano un dialetto sciolto e piacevole. Sono spariti i cantastorie, come Marino Piazza, di Bazzano, sempre presente in tutte le fiere. Anche queste erano occasioni per continuare una tradizione.
Ma proviamoci noi, con i mezzi che abbiamo.
Intanto ti saluto e ti abbraccio.
Grazie per i complimenti. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Hola Speradisole.
Assolutamente d’accordo e che pena.
Il nostro dialetto, che abbiamo ascoltato da bambini nei cortili non deve sparire. Guarda con che impeto si chiede rispetto per il Catalano, il Gallego, Il Basco che hanno saputo risorgere con una decisa politica di difesa delle diversitá linguistiche.
Perché no una ora di Bolognese nelle scuole. A che cosa serve la Regione se non si occupa anche di questa questione culturale. O abbiamo paura delle differenze? L’unitá d’Italia non é messa in discussione dalla difesa dei nostri dialetti.
Maurizio (da Sevilla)
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Maurizio,
prima di tutto un saluto alla Spagna ed un ringraziamento a te.
Hai ragione.
Alcune regioni riescono a salvaguardare il loro patrimonio culturale, tra cui la “parlata dialettale”, ma non la nostra Regione.
Io ne provo dispiacere e a volte quando dico qualche parole in dialetto, nessuno mi capisce, anzi mi guardano strano come se fossi un’incivile arrivata da chissà quale parte del paese.
Ma non si fa niente, anzi, parlare il dialetto a Bologna, fa sembrare una persona incolta, poco gradevole e poco educata.
Ciao, un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
….. parlare il dialetto a Bologna, fa sembrare una persona incolta, poco gradevole e poco educata.
E’ così! Ma forse perché il nostro dialetto è molto “colorito” . Ad esempio a Pieve di Cento e non so se anche in altri comuni, per dire :” Neppure per tutto l’oro del mondo” , si dice :” gnanc sa mur al ninen” ( Neppure se muore il maiale).
Volgare, ma molto efficace poiché in pochissime parole si capisce la negazione assoluta commisurata alla misura del danno. Se fosse morto il maiale, in una famiglia contadina, voleva dire fare la fame per un anno.
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Roberta,
ti ringrazio moltissimo di questa bellissima “perla” del nostro dialetto.
Quando la gente aveva a che fare con un piccolo tesoro come un maiale, lo preservava da tutto. Il che rende tantissimo l’idea della cosa preziosa.
Grazie, un abbraccio Speradisole
"Mi piace""Mi piace"
Speradisole il sito e’ molto bello, complimenti.
Vorrei chiederti una spiegazione, ascolto molto volentieri le canzoni di Andrea Mingardi
(sono quasi tutte in dialetto bolognese) in particolare nella canzone “Ubaldo” il testo parla di una persona molto tirchia, ed ad un certo punto dice “At voi dar na copa Baldo, na mdaia al valor tirè d’la GRICISIE oppure glicisie” sapresti dirmi il significato di questa frase. Ti ringrazio in anticipo.
"Mi piace""Mi piace"
La parola “GRICÎṡIA” nel dialetto bolognese significa tirchieria, avarizia estrema, ( nel vero senso del denaro). Non è grettezza mentale, ma proprio avarizia. Quando uno è avaro in dialetto bolognese si dice “l è un grécc”.
La frase di Mingardi rivolta a Ubaldo = «Ti voglio dare una coppa Baldo (diminutivo non sempre dialettale di Ubaldo), una medaglia al valore, (perché) (“ti re) tu sei il re della tirchieria».
Ciao Roberto
Grazie ed un saluto. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Ho provato a cercarlo in internet ma niente non trovavo nulla, ti ringrazio molto per il tempo che mi hai dedicato. Nessuno ha mai scritto il testo di quella canzone e non riuscivo a capire il senso di quella frase, ora ho capito.
"Mi piace""Mi piace"
Non essere avaro……….. An tirèr brîsa indrî al cûl .. chi conosce da dove proviene?
"Mi piace""Mi piace"
Cara Roberta,
la frase sicuramente è bolognese.
Essere diposti a “giocarci” il sedere (Non tirare indietro il sedere) vuol dire proprio che si è generosi al massimo.
E la parola “culo” è molto familiare ai bolognesi burloni.
Per esempio:
Avàir ón fôra dal cûl significa “disprezzare una persona”.
At’tîra al cûl? significa “sei di cattivo umore?”
Avàir al fûg in t’al cûl significa “avere fretta”
Bûs dal cûl ajùtum è un’invocazione scherzosa.
Sto mettendo insieme qualcuna di queste espressioni tipiche bolognesi sulla parola “cûl”, poi le scriverò nella parte della raccolta dei modi di dire bolognesi.
Grazie Roberta, per il contributo.
Un abbraccio e buon ferragosto.
"Mi piace""Mi piace"
l’estate è finita o quasi quando si riprende ?
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Roberta,
sto usando un Pc in prestito, perché il mio, purtroppo è defunto.
Questo non sarebbe male, ma scrive, per me, talmente in piccolo, faccio un sacco di errori di scrittura e ci metto un tempo infinito per correggerli, inoltre, non mi consente di gestire i giusti accenti che riguardano il dialetto bolognese.
Riprenderò appena possibile.
Grazie dell’interessamento,
Un abbraccio Spera
"Mi piace""Mi piace"
Anch’io ho avuto per un periodo un net book che scriveva piccolissimo, ora l’ho regalato a dei bambini Bielorussi di buona vista. Se è com’era il mio, i caratteri non si ingrandiscono neppure premendo CTRL + fino all’ingrandimento gradito, comunque prova.
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Roberta,
solo per un saluto e un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
E’ tempo di mariconda, ciribolla, ciribusla, mnistrina, bagia. Quanti nomi per lo stesso cibo ! Chi di voi la conosce o la prepara ?
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
T Bulgneis i’en tot cunteint i an paghè un franc e i nan vest gnint ( in occasione del
primo volo di aereo ai prati di Caprara ai primi del novecento: non so alzò!!.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Giovanni, appena avrò il nuovo pc che mi consentirà anche di porre gli accenti giusti, metterò questa tua gradita “citazione” nella raccolta dei modi di dire bolognese.
Ciao e un salupo carissimo.
"Mi piace""Mi piace"
Ho settantanove anni e, anche se non parlo il dialetto da circa cinquanta, il bolognese rimane la mia lingua madre.
Ho dato un’occhiata e ho visto che ci sono alcune imperfezioni o errori.
Uno per esempio: schiaffo, non si dice sberla (che è della lingua italiana), ma “smataflòn” o “smataflàn” a seconda dell’area della parlata, metropolitana o provinciale; mentre scapaccione è … “scupazòn” … o “scupazàn”.
Se volessi contattarmi per un eventuale confronto o collaborazione (“a gratis” … in bolognese), in questo periodo e fino a primavera non uscirò dal Bel Paese. G.
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Giorgio,
Ti ringrazio molto della tua disponibilità.
Certamente è vero, la parola schiaffo, in bolognese si traduce meglio con smataflàn, ma forse sbérla indica lo schiaffo in faccia, più che uno scapaccione.
Comunque ti ringrazio e tengo la tua mail. Appena avrò un pc decente ti scriverò.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
¡¡¡Èser pèra con tótt!!!
Innanzitutto non capisco il motivo per il quale è stato cancellato il mio commento!
Avevo fatto un rilievo, dando la (mia) versione bolognese della parola schiaffo = smataflon; non mi pare che ci fosse niente d’insultante.
Avevo anche dato la mia disponibilità ad una collaborazione gratuita, dal momento che il dialetto bolognese è la mia lingua madre.
La frase bolognese “eser pera con tott”, più che nel senso qui indicato, veniva usata in senso ironico, a proposito di una ragazza piatta (pari sul davanti), con pochissimo seno; con un altro significato, veniva usata per dire di una persona che non deve rendere conto a nessuno.
Cordialmente saluto // Giorgio
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Giorgio,
non cancello mai i commenti, specie quelli che riguardano il dialetto bolognese.
Il fatto che non riuscivi a leggere il tuo commento era dato dal fatto che, stando poco al pc, non mi ero accorta che era in attesa di approvazione.
Il detto “Eser pèra con tott” l’ho preso dagli scritti di Gino Calari. Lo scrittore si limita a dare il significatro di “non avere debiti”,
Quello di paragonare una ragazza con poco seno a questo modo di dire, lo conosco anch’io, ma non ho voluto aggiungere nulla a quello che lo scrittore ha preferito mettere come definizione. Per rispetto allo scrittore stesso.
Per quanto riguarda il modo di scrivere in bolognese, sono in contatto con Luigi Lepri, che ha la gentilezza anche di correggere i miei strafalcioni. Sono stata alla presentazione del suo ultimo libro “Rime e zirudèl in dialetto bolognese” presso la libreria Coop Zanichelli, nel mese scorso di ottobre scorso. In quella occasione ho avuto modo di conoscere anche Amos Lelli, un altro appassionato del dialetto bolognese.
Ciao Giorgio, un saluto carissimo.
"Mi piace""Mi piace"
Picaja significava “Asola”; della camicia, della giacca … e di ogni altro indumento.
"Mi piace""Mi piace"
Carisimo, lo sai bene, paese che vai, dialetto diverso trovi.
"Mi piace""Mi piace"
Non ne sono sicuro, ma penso che Luigi Lepri sia un po’ più giovane di me e che per lui il dialetto sia la seconda lingua, mentre per me è la lingua madre.
Inoltre … non è detto che Luigi Lepri sia la Bibbia dell’idioma petroniano, anche se … ci ha saputo fare … nei palazzi del potere; e mi fermo qui.
Ricambio il saluto affettuoso // Giorgio
P.S. Recentemente mi è stato regalato un vocabolario Bolognese-Italiano, di Claudio Ermanno Ferrari, Terza Edizione, pubblicato in Bologna, presso gli editori Mattiuzzi e De’ Gregori, nel 1853. Ho notato varie differenze, soprattutto nella pronuncia, con il dialetto da me conosciuto; ma, si racconta, che in quei tempi la pronuncia variasse addirittura da Porta a Porta. Inoltre mancano del tutto le parole e le frasi “volgari”; bisogna ricordare che allora, a Bologna, comandava ancora il Papa.
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Giorgio,
Ti ringrazio molto della tua disponibilità.
Certamente è vero, la parola schiaffo, in bolognese si traduce meglio con smataflàn, ma forse sbérla indica lo schiaffo in faccia, più che uno scapaccione.
Comunque ti ringrazio e tengo la tua mail. Appena avrò un pc decente ti scriverò.
Un abbraccio.
No!
Anche se la parola sberla era ugualmente usata (molto meno) per dire schiaffo(ne), “smataflan” non ha niente a che fare con scapaccione, che corrispondeva a “scupazon”.
Un altro saluto affettuoso // Giorgio
"Mi piace""Mi piace"
Scioglilingua
T’è tott unt un tac.
Hai un tacco tutto unto.
Un tac(a)t un tac? Mé c’at taca un tac a té che t’tac i tac? Tac’t’al té al tu(to) tac.
Mi attacchi un tacco? Io che ti attacchi un tacco a te che attacchi i tacchi? Attaccatelo tu il tuo tacco.
Giorgio
"Mi piace""Mi piace"
«Mó sé, figurati» ribatte la Fonsa «a fare tutta quella strada, a t sûda la längua in båcca» (Ma sì, ti suda la lingua in bocca).
«A t sûda la längua in båcca» viene anche usato per prendere in giro chi, per spavalderia, sostiene di avere caldo, mentre trema dal freddo.
– Non conoscevo il primo significato, mentre ricordo molto bene l’uso frequente che si faceva del secondo.
Nella stessa situazione e con significato simile, ma come ammonimento, si diceva anche … “…a té at pôza la salut” . “A te puzza la salute” … ovvero … hai voglia di ammalarti.
"Mi piace""Mi piace"
squàss = diluvio? … No!
Squass significa … acquazzone.
"Mi piace""Mi piace"
bujè, bujarii = boiata, cavolata, “cazzata” …
“Anche volgarità”
"Mi piace""Mi piace"
Grande e grazie Speradisole ! Mi sono imbattuto casualmente in questo lavoro , che mi ha procurato una forte emozione perche’ mi ha riportato alla mia infanzia ,ai miei nonni , ai mie genitori. Ho 65 anni e da 50 vivo a Torino , ma il bolognese l’ho ancora fortemente radicato dentro. Vorrei proporre alcuni detti che sovente mi ritornanano alla mente e che non ho visto elencati…… ( scusa la scrittura ) :
1) n’et d’ osta ? ( ce n’hai del buon senso ?) – ti propi senz’osta ( non hai proprio accortezza )
2) ai ho prile’ ad galoon e ai ho tire dret ( mi sono girato nel letto e ho continuato a dormire) dove letto e dormire in dialetto sono sottointesi
3) Al pol piser in tal let e dir c’la sude ( Puo’ fare la pipi nel letto e dire che ha sudato )
cioe’ puo’ permettersi di dire cio’ che gli pare senza essere contradetto
4) Par tireram so ai vol la zidrela (Per alzarmi ci andrebbe la carrucola)
sottinteso per la stanchezza
5) Cum ela , cum n’ ela , al padron la rason , al cuntaden la parson
( com’e’ , come non è al padrone la ragione , al contadino la prigione )
Una filastrocca : Zirudela in vatta i cop
la mustreva il cul a tot
par la sfessa d’la stanela
viva viva zirudela
Ciao Mario
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Mario,
benvenuto in questo piccolo club.
L’antico dialetto bolognese è un po’ un’emozione. Si sente che il tempo è passato, ma non è passata la passione, per chi è nato in queste terre e per chi, come prima parola oltre mamma e papà’ ha detto come me: “Mama, dam dal pan”. Forse il suo fascino sta proprio nel fatto che questa emozione si è persa col tempo e quando la si sente dire, si riaccendono i ricordi
Grazie Mario per il tuo contributo. Quando avrò finito i “detti bolognesi”, metterò in evidenza tutti i contributi, che i lettori di questo blog, stanno inserendo.
Tutto serve per arricchire il dialetto bolognese.
In particolare ti ringrazio per la Zirudela. Anch’io la conosco e sarà trascritta nella prima parte di questi detti antichi bolognesi.
Per ora un grande abbraccio ed un saluto di benvenuto. Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Per Mario
Mia madre, quando ero piccola, “Al pol piser in tal let e dir c’la sude”
me lo diceva a proposito dello studio : ” tu devi studiare per fare domani un lavoro migliore del mio poiché non sei della classe sociale di quelli che i polan piser….. “.
ciao
grazie
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
La …”rélla” …
Da Alberto Menarini:
rélla (s.f. ant.) = Membro virile.
Il lemma sopravvive, non più riconosciuto nel suo antico significato, in esclamazioni quali … “Sé, la rélla di fré!” … Col cavolo! Nemmeno per sogno e simili. // G.M.
"Mi piace""Mi piace"
Per Roberta
e’ vero viene ( veniva? ) usato anche in quel senso .
e riporto anche un’altra zirudela ( ninna-nanna )
che mi e’ tornata alla mente .
Trota trota cavalota Trotta trotta cavallotta
un panir pen ed ricota un paniere pieno di ricotta
un bel piat ed tajadel un bel piatto di tagliatelle
par rimpir al tou budel per riempire le tue budelle
se te’ po’ d’la murtadela se hai poi della mortadella
la giurne’ la sra’ pio’ bela la giornata sara’ piu’ bella
coi fasu d’entr’ al parol coi fagioli dentro il paiolo
fa la nana ragazol fai la nanna ragazzino
in t’la pgnata un bon cutghen nella pentola un buon cotechino
a buir pianen pianen a bollire piano piano
fa la nan al mi puten fai la nanna mio bambino
alla prossima Ciao a tutti Mario
"Mi piace""Mi piace"
grazie ne sapevo solo qualche frammento
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Divertente ed emozionante per chi conosce bene il dialetto come me…….
Ormai non so piu’ con chi parlarlo, per fortuna abito in un paesino vicino Budrio, cosi posso parlare in dialetto con un po’ di persone. A mio figlio l’ho insegnato, ma temo che parli meglio l’inglese. Ma un inglese come potra’ mai dire in inglese una parola che valga un bel: SOCMEL!!??
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Valerio, sono contenta che la mia scelta di trascrivere le “emozioni” del dialetto bolognese antico, ti siano piaciute.
Poco alla volta finirò anche i vari proverbi del “contadino bolognese”. Confesso che scrivere in dialetto è impegnativo quanto leggerlo.
A presto e un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Caro Valerio senz’altro i nostri figli conoscono meglio l’inglese e come sono puntuali nel correggere con sufficienza la nostra (la mia) pronuncia di parole inglesi : ” ma mamma … ” .
Sul dialetto bolognese però non sono all’altezza e anch’io , purtroppo e spesso, dimentico come si dicono in dialetto parole poco usuali.
Per questo sono grata a Spera perché ci aiuta a far sopravvivere questo nostro “tesoro”
Ciao
Roberta
PS pensa che da noi come esclamazione di stupore si usa “sculason” abbreviazione di .. ma che ti (mi ?) venga lo scolo. (gonorrea)
"Mi piace""Mi piace"
E’ tempo di mariconda, ciribolla, ciribusla, mnistrina, bagia. Quanti nomi per lo stesso cibo ! Chi di voi la conosce o la prepara o conosce una versione in italiano ?
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Cara Roberta,
c’ho provato a chiederlo anche ai miei parenti più anziani, ma nessuno di loro mi ha saputo rispondere.
Alcuni mi hanno detto forse è il pancotto, la minestra povera dei poveri, ma non so se la risposta è giusta.
Un abbraccio. Spera
"Mi piace""Mi piace"
La mariconda originale è lombarda ed è una specie di minestra: gnocchetti molto soffici e delicati a base di pane, latte, uova, parmigiano e cotti in brodo. Nelle campagne del bolognese però si usava il termine mariconda anche per indicare la ciribolla: una specie di polenta cotta in brodo di fagioli con aggiunta di pezzetti cotechino
"Mi piace""Mi piace"
Ricordo che da piccola, la polenta col brodo di fagioli e cotechino (quando c’era), si faceva, ma non mi piaceva tanto, non so come si chiamasse. La parola Ciribolla non la conosco.
Preferivo la polenta con la panna fresca, quella che si formava quando si bolliva il buon latte di campagna. Facevo una specie di budino tenero che per me era buonissimo. La chiamavo “biuda”, forse non è una parola bolognese di città, ma della campagna dove abitavo, per la precisone Castello di Serravalle.
Grazie Elena, un abbraccio. Buona Natale.
E viva Bologna.
"Mi piace""Mi piace"
Si è una minestra dei poveri, ma non è pancotto. Molto diffusa nella pianura bolognese e nell’alto ferrarese era fatta durante l’inverno quando si uccideva (“si investiva”, ho provato a scriverlo in dialetto, ma non ci sono riuscita ) il maiale (al ninen).
Composta principalmente da brodo fatto con ossa spolpate e di scarto, fagioli, polenta gialla. La mia nonna, nata all’inizio del novecento, la preparava e la serviva in piatti fondi grossi ( che chiamava ceramica del leone) tiepida o arrosto o, golosissima, fritta.
ciao
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Sculasòn!!?? Pieve di cento oppure Cento di Ferrara
"Mi piace""Mi piace"
A Pieve di Cento!
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Gabriele.
At salùt
"Mi piace""Mi piace"
d’importazione
"Mi piace""Mi piace"
“tra’ l’arzdoura e al mare’ al lit ien com i prasu…i sar sorval sota’ i linzu” tra marito e moglie le liti si risolvono sotto le lenzuola (detto della civilta contadina del fine 1800)
le discussioni erano molto frequenti e venivano fuori in tante situazioni in tanti momenti diversi della giornata , proprio come il prezzemolo che spuntava in ogni angolo della casa o della corte.
"Mi piace""Mi piace"
Maurizio,
grazie. E’ un saggio detto popolare bolognese antico. Sotto le lenzuola si risolvono tanti problemi.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Sono nato a Bogotá, in Colombia, da genitori italiani e quando ho finito la scuola (italiana) sono andato a Bologna a studiare astronomia (che poi non ho finito… sigh!). sono stato la per 4 anni, ma non ho imparato una virgola del dialetto… scemo me! Solo una cosa ricordo, ma non ricordo dove l’ho vista scritta: A vliv pianterla ad fer dal casén!
Bella Bologna, bei ricordi!
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Pierpaolo,
Tu hai un alibi enorme, sei nato a Bogotà, e anche se i tuoi genitori sono italiani, fai parte di quel paese. La tua lingua è quella. Ma ti assicuro che tanti bolognesi, nati qui, e da genitori bolognesi, difficilmente parlano il dialetto. Soprattutto perché viene considerata la lingua dei contadini, o se vogliamo della gente di “campagna”. E poi perché la scuola ha fatto (credo giustamente) la sua parte. Per me, che ho sentito i miei nonni ed i miei genitori parlare in un bel dialetto bolognese, resta solo la nostalgia. In ogni modo ci sono associazioni, volontari, gruppi di attori che recitano in teatro, bellissime commedie in bolognese.
Se vuoi restare un po’ a contato con la nostra città, ti suggerisco questo sito.
http://www.succedesoloabologna.it
Un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Anch’io ti consiglio lo stesso sito, inoltre vi sono delle foto di Bologna splendide
"Mi piace""Mi piace"
Il 90% delle espressioni si usano anche in Romagna.
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Lorenzo,
condividiamo quasi tutto con i romagnoli, come buoni fratelli.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
non trovo in nessun vocabolario la parola “scavazz” che, mi risulta, sia la parte terminale della schiena di una donna che ha un gran bel cu….. è anche cantata da Dino Sarti nella canzone “Venusta” mi puoi confermare ?? grazie
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Ivano,
ho ascoltato la canzone. Non ho trovato nel libro che ho di Gino Calari, fra “le parole di tutti i giorni”, la parola “scavazz”. Probabilmente lo “scavezzo” come lo definisce Sarti nella canzone, é l’incavo che si forma in una donna quando ha la vita sottile, infatti la canzone dice “50 di scavezzo e 104 di torace” e descrive una donna formosa, ma con le curve al posto giusto.
Forse deriva dalla parola “Scavzadura” (rottura degli steli della canapa) che si eseguiva a mano o con macchine nella raccolta della canapa. Penso perciò che lo “scavezzo” sia la rottura di una linea dritta.
Forse queste cose le sapevi già, ma non ho trovato altro modo di spiegare lo “scavezzo” di Dino Sarti, nella bella canzone “Venusta”, un nome antico delle nostre bellissime nonne.
Ciao, un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Provo io a cercare l’origine del significato , ma non sono sicura che la mia interpretazione sia corretta.
Scavazz potrebbe derivare da Scavazzare, v.t. ‘capitozzare’. Scavazzato–> scavezzare –>tagliare –> potare a capitozza cioè fare una potatura degli alberi nel punto in cui il tronco si dirama, allo scopo di stimolare l’emissione di nuove fronde. Albero o pianta della canapa tagliato ad una certa altezza dal suolo.
Il significato si capisce meglio riguardo “lo scavezzo di una donna”, ovvero il passaggio fra il rachide e il glutei, se pensiamo alla parola “scavezzacollo” :
[Sca-vez-za-còl-lo] sm.
Discesa ripidissima, precipizio , estens. Ruzzolone precipitoso, capitombolo.
A scavezzacollo, a precipizio, a rompicollo: correre, buttarsi, scendere, venire giù a s.
ciao
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
scusa spera non avevo letto il tuo commento con il quale concordo
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Roberta,
abbiamo avuto la stessa impressione. E’ difficile, infatti, tradurre con una parola sola, un modo di dire bolognese, perciò si ricorre ad esempi. Queste parole intraducibili fanno parte di una vecchia cultura, perduta da tempo, che comunque spesso fa riferimento al mondo dei campi. L’unico mondo (forse) in cui si muovevano e vivevano i nostri antenati.
Ciao, un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Ciao a tutti, ciao Spera.
l’altro giorno parlando con un giovane amico ho pronunciato in dialetto : ” se è così chiediamo di dividere le manelle”. Siccome non aveva idea di che cosa stessi parlando ho spiegato l’origine del detto e ho pensato di scriverlo sperando vi piaccia.
… Durante la lavorazione della canapa, ad un certo punto della stagione lavorativa, la pianta veniva immersa in fasci nel macero e prelevata dopo circa 15 giorni dall’acqua putrida dopo che la fibra era macerata. Lavoro molto faticoso accompagnato da un odore nauseabondo che impregnava vestiti e capelli, ma anche giornata di festa dice la mia mamma e forse, aggiungo io, anche per merito del principio attivo della cannabis sativa. I giovani del paese, soprattutto i braccianti senza terra, in quella occasione davano una mano ai contadini in cambio di un mannello di canapa.
Finito il lavoro, i giovani aiutanti si portavano a casa un po’ di canapa, i manelli appunto, da filare durante l’inverno, con la quale tessere la preziosa tela e fare lenzuola, asciugamani, camicie da notte e altre cose secondo le esigenze della famiglia e per la “dote” dei figli.
Questo piccolo fascio, molto importante per le famiglie del primo novecento, era distribuito a seconda del lavoro svolto, oggi diremmo secondo il merito. Da qui il detto dividiamo le manelle (in dialetto prende il femminile), ovvero ognuno si prende quello che è suo o è di suo merito.
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Roberta,
ciò che abbiamo imparato da piccoli non si dimentica mai e ogni tanto riaffiora senza che ce ne accorgiamo.
Anch’io ricordo molto bene “le manelle”. Ho vissuto la mia infanzia sulle colline bolognesi e lì non c’erano i maceri per la canapa, però le manelle le ricordo perché quando si mieteva il grano a mano, con la falce, si facevano mazzetti, appunto, chiamate manelle, che poi si radunavano per formare i covoni.
Ricordo anche le manelle delle spigolatrici, di quelle donne che, non possedendo campo, andavano in quelli mietuti da poco e raccoglievano ciò che rimaneva di non raccolto. Camminavano gobbe a testa bassa per cercare qualche spiga che si era staccata e la mattevano in una sacca tenuta legata al grembo, oppure se trovavano ancora la spiga con il gambo attaccato, formavano le manelle. Il tutto veniva trebbiato alla fine della trebbiatura dei covoni degli agricoltori, e il poco del raccolto, veniva diviso, appunto, secondo il numero di manelle raccolte.
Grazie Roberta, per questi ricordi.
Un abbraccio. Spera.
"Mi piace""Mi piace"
Mi fa molto piacere aver trovato questo sito. Io sono romana romana, ma mio padre era della provincia di Ferrara. Nonostante dall’età di vent’anni fosse venuto a vivere a Roma, parlava spesso in dialetto, anche con il nostro pappagallo (che aveva imparato molte parole in dialetto), e comunque sempre con accento emiliano.
E visto che siamo in ottobre, il periodo delle castagne, ricordo che papà quando parlava delle castagne lesse, le chiamava “balusc”. Mi confermi che ricordo bene? Papà era del 1902 ed io sono del 1936!. Ciao Speradisole e grazie per avermi permesso questo “amarcord”. Ornella Malaguti
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Ornella,
mi ha fatto un piacere immenso leggere queste tue parole. Le radici non si dimenticano mai e sono contenta che tu “romana romana” abbia un po’ di sangue emiliano.
Sì tuo papà aveva ragione e la parola “balusc” (che i perfezionisti del dialetto bolognese scrivono balûṡ, ma l’effetto sonoro è molto simile), sono proprio le castagne bollite.
Da quella parola deriva “baluser” che significa balbettare, come in certo qual modo balbettano le castagne quando bollono.
Ciao Ornella, un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Cara Ornella, cara Spera anche i miei nonni erano del 1903 ed erano ferraresi del nord; Poggio Renatico. La nonna mi preparava i balùs proprio in questo periodo, bolliti erano ottimi. Sono tanti anni che non li mangio e mi avete proprio fatto venir voglia di cercarli.
A Bologna “Ander a Balùs” vuol dire andare bene, in un bel posto, con una bella compagnia.
Ciao e a … balùs
Roberta
"Mi piace"Piace a 1 persona
Carissima,
è proprio così, perché le castagne erano la fortuna delle persone di montagna, quelle solitamente più povere e, per loro, la stagione delle castagne era come la mietitura o la canapa, della pianura.
Un abbraccio. Spera.
"Mi piace""Mi piace"
SPERADISOLE, SEMPLICEMENTE FANTASTICA !!! QUESTO DIALETTO MI FA RICORDARE COME MI PARLAVA LA NONNA CHE MI HA ALLEVATO ………… E UNA LACRIMA SOLCA IL MIO VISO. SCUSA MA SONO EMOZIONI TROPPO FORTI.
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo Mauro,
grazie. Sei molto gentile. Anch’io provo un po’ di nostalgia per il nostro dialetto perduto. Ma non riesco bene a capire come mai, invece, in tante Regioni, il dialetto non sia mai scomparso.
Forse il nostro è troppo difficile, o parlato solo da gente povera, come i contadini di una volta.
In ogni modo teniamoci i nostri ricordi e ogni volta che possiamo, lasciamoli ai nostri figli e nipoti.
Un grande abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Un modo di dire dei cinni era anche a balusc Visigoti, perchè?
"Mi piace""Mi piace"
Ciao carissimo,
probabilmente il richiamo ai Visigoti non è altro che l’indicazione di gente “barbara” e senza educazione. Il richiamo ai balusc, forse, è dovuto al fatto che le castagne bollite erano il pasto più povero per la povera gente.
Quindi i “cinni” sostanzialmente sarebbebro dei maleducati e poveri in canna.
Un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Buongiorno,
Scrivo da Argentina, sono contento di trovare un luogo che parla di dialetto Bolonese.
Ho una domanda, mia Nonna era bolognese e quando era arrabbiato con il Nonno ha detto una frase come “va fer dal pep,,,”
Anche lei non mi ha mai voluto dire che significava, immagino che non è molto bello … Conoscete il significato,
Grazie mille !!!
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Fernando.
Innanzitutto buon anno e un saluto dall’Italia, da Bologna in particolare.
Tua nonna era una vera bolognese, il detto che lei pronunciava quando si voleva mandare qualcuno a vaff…, in bolognese era proprio come diceva tua nonna.
Ma la nonna era ancora più fine, come lo sono i veri bolognesi, e la sua espressione ancora più chiara.
Infatti:
Pép (plurare) pépa (singolare) significa pipa. [Se l’accento sulla e è pèpa significa papa]. Importantissimo è quindi l’accento sulla e, inoltre la vocale e della pépa è brevissima, quasi sfuggente nella pronuncia.
Con un po’ di fantasia cerca di immaginare com’è fatta una pipa e come la si fuma. Ti basta applicare tutto questo alla sfera sessuale maschile e la risposta è chiarissima.
Un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Speradisole! Felice Anno Nuovo! Ohh, ora ho capito, molti anni ho voluto conoscere il significato di quella frase, molti ringraziamenti !! Saluti ! Fernando
"Mi piace""Mi piace"
La pippa in italiano si fa con le mani, non con la bocca… perdona la precisazione spinta.
"Mi piace""Mi piace"
.. anche perché l’equivalente più esplicito è “pugnat”
"Mi piace""Mi piace"
Già.
molto più esplicito e molto più frequente nel dialetto.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
per altre prestazioni “orali” veggasi l’arcaico “caramlan” piuttosto che il moderno “pumpein”.. e non vado oltre.
"Mi piace""Mi piace"
Non so nulla di caramlån (caramellone) anche se rende di più l’idea.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie della precisazione.
Ci voleva.
"Mi piace""Mi piace"
La befana durante la guerra
Ariva la vciatta ch’la ven da lasò
Mo quand as è vic an s in pol piò
El gamb i en sutili e sanza virtò
E anc el calzatt in stan brisa sò
"Mi piace""Mi piace"
Che regalo Roberta!
Grazie, ormai ho esaurito quello che avevo raccolto nel tempo e quello che sapevo in dialetto bolognese e quindi questi tuoi “rinforzi” mi fanno un immenso piacere.
Trasporto questa poesiola nella pagina vera e propria così si arricchisce.
Grazie Roberta, con tutto il cuore.
Un abbraccio Spera.
P.S. Ho cercato di mettere gli accenti giusti, come mi ha insegnato Luigi Lepri, ma non so se ho fatto bene del tutto.
"Mi piace""Mi piace"
Avrai senz’altro fatto meglio di me , io non li so mettere per nulla.
"Mi piace""Mi piace"
Cara Spera,
Citando Luigi Lepri mi hai fatto venire la curiosità di trovare la fonte bibliografica della filastrocca sulla befana (copiata nel mio quaderno delle curiosità del dialetto bolognese) e finalmente te lo posso scrivere …………… L’avevo copiata, tanti anni fa, dal libro di Luigi Lepri Fantèsma di ritorno. Seconda passeggiata semiseria nel dialetto bolognese,a pagina 23.
Gigen Livra edizioni Pendragon 2006. In copertina un bellissimo disegno di Nasica.
ciao
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Roberta,
è bello e giusto citare le fonti, per dar merito a chi ha scritto le cose.
I vari detti bolognesi che ho riportato sono tutti stati corretti da Luigi Lepri.
Persona gentilissima, si accorse che scrivevo delle irregolarità soprattutto negli accenti da mettere e mi scrisse offrendosi di correggere il tutto.
Fu impresa non da poco e lo ringrazio moltissimo.
A me comunque interessa accumulare questi detti antichi, che si sono persi, e riportarli alla luce, almeno per coloro che hanno voglia di rileggerli.
Per questo, se fra i tuoi appunti trovi qualcosa di interessante, e me lo fai sapere, riporterò nella pagina giusta ciò che trovi, anche se non conosciamo bene la fonte.
Un grande abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
In tempo di pioggia a casa della nonna.
Piove ? A smommia ( che voleva dire un leggerissima pioggia, quasi una nebbia che bagna). Non ho mai trovato una traduzione in italiano che rendesse l’idea.
Roberta
"Mi piace""Mi piace"
Cara Roberta,
anch’io ho sentito dire “A smommia” quando la nebbia è fitta da bagnare, ma non piove, nel senso che non si notano le gocce. Ho chiesto ai miei nonni e parenti, ma neppure loro mi sanno dire da dove deriva questa parola e perché.
L’unica cosa che mi viene in mente è la parola “smojja”, che è il ranno, o liscivia, che si forma versando l’acqua caldissima sulla cenere ben setacciata, che serviva per fare il bucato. Non credo che abbia a che fare la la smommia, quella pioggerella che non è tale e neppure con la nebbia che sembra pioggerella, per i bolognesi. Sembra quasi una leccata di cane, lasciata dalla sua saliva.
Un abbraccio. Spera.
"Mi piace""Mi piace"
A tavola con un mio cugino inappetente (ndr beato lui !).
Oggi ha mangiato ? Ma più che altro l’ha smummiee (non so dove mettere gli accenti).
Che voleva dire che per mangiare un boccone ci metteva molto tempo e manteneva il cibo in bocca a lungo.
"Mi piace""Mi piace"
Carissima,
si forse è come hai detto tu: “smummiêr” masticare a lungo un boccone prima di ingoiarlo, e probabilmente deriva dalla parola “ruminare”, proprio delle mucche quando con pazienza rimasticano a lungo il fieno.
Grazie Roberta. Un abbraccio. Spera.
"Mi piace""Mi piace"
Elena Biagetti ha commentato, ma il commento nonostante la mia approvazione non è apparso nella pagina. lo trascrivo per ringraziare Elena, sicuramente di Bologna)
Carissima Speradisole, sono venuta a conoscenza di questo meraviglioso sito solo oggi, perchè essendomi definita con una giovane amica “un caval ed scaja” a causa di una serie di acciacchi che mi stanno arrivando, mi sono accorta che mi ascoltava non sapeva cosa volessi dire. Così dopo aver dato una veloce spiegazione alla mia interlocutrice, ho voluto cercare di approfondire. E qui non solo ho trovato ben due spiegazioni diverse, ma ho conosciuto questo meraviglioso e me lo sto leggendo tutto.
L’argomento non è elegante, ma mio nonno Elia (1888-1972) completava la frase “tromba di culo, sanità di corpo” con “chi non scoreggia è un uomo morto”. lui lo diceva in dialetto, ma io non so scriverlo.
ed in effetti, se ci pensa, quando si va in ospedale, dopo un in intervento chirurgico, il medico chiede “ha canalizzato?”
Carissima Elena,
Anche a me, rileggere ogni tanto queste espressioni dialettali, fa piacere, perché così penso di poter amare ancora di più chi mi fu vicino da piccola.
Grazie per il tuo pensiero e per il fatto che tu trovi questo sito “meraviglioso”.
Ti auguro di stare bene e di non avere tutti i problemi che ha al “caval d’Scaja” e di condividere con la tua giovane amica, le giocose espressioni del nostro magnifico ed unico dialetto bolognese.
Quando i medici chiedono, dopo un intervento chirurgico se “ha canalizzato”, se fosse bolognese dovrebbero semplicemente chiedergli se ha scoreggiato. Molto più semplice e comprensibile. Senza scandali per nessuno, perché la sanità di corpo è alla base di tutto per la vita.
Un abbraccio grande. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
ciao
io ricordo un indovinello che recitava mia nonna Pia
durmeccual al durmeva
pindeccual al pindeva
cureccual al cureva
s’a gnira pindeccual, durmeccual al mureva.
la soluzione: una lepre che dormiva sotto ad un pero, un cane che correva e una pera che cadendo ha salvato la vita alla lepre.
e i bimbi una volta si incantavano così
"Mi piace""Mi piace"
Bellissima Lia,
grazie, anziché tenerla tra i commenti la metterò nella pagina principale. Se ne conosci altre,fammelo sapere, così si arricchisce il nostro dialetto.
Ti ringrazio ancora, un abbraccio. Speradisole
"Mi piace""Mi piace"
Bellissima filastrocca Lia
Grazie
"Mi piace""Mi piace"
un’altra filastrocca… educativa!
“la breva spuslina la fa al let a la matina
la dona acsè acsè al le fa in tal mezdè,
la porca vacaza al le fa quand la s’agiaca..”
Poi le ragazzine dovevano rifare i letti anche per i fratelli!!!
Un gran lavoro perchè i tamarazzi non erano a molle ma con le penne o la lana e si agnoccavano!
"Mi piace""Mi piace"
Carissima, grazie infinite.
Come avrai notato, ho messo la filastrocca nella pagina principale. Ho cercato di mettere gli accenti giusti, per quanto sono riuscita ad imparare da Luigi Lepri, e inoltre di dare la cadenza giusta per l’antico dialetto bolognese, con suoni leggermente diversi da zona a zona e ovviamente da provincia a provincia.
Spero anche di aver reso l’idea giusta della filastrocca.
Un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
ciao, permettimi un commento …. Io questa filastrocca te l’ho riportata come la pronunciano nella zona di Budrio/Molinella dove, diversamente da altre zone, oltre a “matina” e “spuslina”, dicono per esempio “caldarina” (piccolo paiolo) “fangina”, (bambina) “furzina”, (forchetta) ftina, (abito da donna) curtlina (coltello da salume) ecc…. e sono ben convinti di non sbagliare!!
Per me non c’è problema.. va bene anche come hai messo tu!!!
Con tutta la mia simpatia, un carissimo saluto
Lia
"Mi piace""Mi piace"
Carissima Lia,
grazie per la precisazione. E’ verissimo quello che dici, ogni paese ha la sua inflessione sulle parole dialettali. Anche nel paese dove io sono nata ci sono espressioni diverse, per indicare lo stesso nome, rispetto al dialetto bolognese. Ti faccio un esempio, il raccoglitore del “rusco” al mio paese viene chiamato “bandòn” a Bologna “bidon”, addiritura fra due case distanti tra di loro pochissimi chilometri, la parola fragola viene detta “frol” oppure “freval” o “frevel”.
Tuttavia il titolo del post è “L’antico dialetto bolognese” e fra le varie inflessioni ho scelto il bolognese vero e proprio, almeno quello che si avvicina di più, da qui la necessità di cambiare qualche inflessione, senza perdere il senso della parola.
Grazie, sei molto gentile, e se hai altre cose da proporre, le trascrivo volentieri, precisando che si tratta del dialetto con le inflessioni budriesi o di Molinella.
Un abbraccio. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
E’ capitato anche a me (intorno al 1978) di osservare qualche differenza dialettale fra chi abitava a S: giovanni in Persiceto o Sala Bolognese o Crevalcore…Ad es. la frase “c’era un uomo” che – scrivo alla buona – io tradurrei “A’ier’un omen (a’iera ‘n omen”) diventava “A gh’ira ‘n om”, “A gh’iera n’oman”. Oppure “E’ qui che viene” diventava “L’é ché cal vin”, “L’é che cal vein”,…
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Antonio,
è proprio così, a volte la differenza di pronuncia, ma anche di tono, è diversa anche se la distanza tra i paesi (se non le case) è poca.
L’esempio dei verbi che hai fatto è chiarissimo.
Ma direi che tutto questo è una nostra ricchezza. Un po’ come fare il ripieno dei tortellini, ogni valle, ogni paese ha la sua ricetta (e forse anche ogni famiglia), Unica cosa, mi dispiace che scompaia, e mi dipiace anche che chi parla in dialetto venga considerato un poveraccio.
Una volta ho sentito un medico importante di un importante ospedale, rivolgersi in uno schietto dialetto bolognese ad un paziente, mi sono sentita rincuorata.
Il dialetto è una musica.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
GRAZIE Lia veramente bella e soprattutto istruttiva rispetto i compiti richiesti alle nostre nonne
"Mi piace""Mi piace"
E’ così Roberta.
tanti di noi conservano queste “chicche” antiche della propria famiglia. I “pajazz” i pagliacci di foglie di granoturco li ricordo anch’io. Facevano un chiasso enorme, quando ci si muoveva.
Grazie Roberta. Un abbraccio Spera.
"Mi piace""Mi piace"
Mio nonno diceva che rena in bisaca voleva dire avere della sabbia in tasca. Per Pasqua ti salutavano augurandoti Ovduri, uova dure. E quando si arrabbiava mi ammoniva con at caz na pavena che tin da’ un etra al mur. Brot papazoc d’un pataloc.
ciao at salut ,bona.
Andrea
"Mi piace""Mi piace"
Ciao Andrea,
e’ un piacere sentirti parlare di tuo nonno. Gli fai onore. Rèna in bolognese significa semplicemente “Rana”. L’anfibio che veniva chiamato anche Ranôc oppure Ranôcia. Mentre il rospo veniva detto “Bôt”. Il significato di “Réna in tasca” era quello di essere in bolletta. Pare per via del colore verde della rana, come dire essere al verde, oppure per il suono che facevano due baiocchi in tasca, che sembrava appunto il gracchiare della rana, a significare che la persona aveva solo due baiocchi.
A Bologna abbiamo piazza Galvani dove c’è una statua dedicata allo scienziato che è scolpito nell’atto di fare i suoi esperimenti neuro-elettrici sulla rana. Si dice che un ubriacone passando vicino alla statua brontolasse: “Anch’a mé a i ó ‘na rèna, mó inciòn m’ha fât un monumàint”.
Non conosco la parola “pavena”, ma da quello che viene detto da tuo nonno sembra proprio un bello schiaffone.
Ciao, e bona lé.
Auguri. Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Anche a me par di ricordare che (negli anni 50 / 60 del secolo scorso) mio padre bolognese usasse pavèna col significato di “botta, sberla”. Così pure ricordo espressioni del tipo (scrivo alla buona) “a’t’dag ‘na sbérla, ch’al mur a’t’in dà un’ètra”.
"Mi piace""Mi piace"
Bellissima questa espressione: “Ti do uno schiaffo (e si intende così forte) che il muro te ne dà un’altro. La finezza particolare del nostro dialetto è davvero unica.
"Mi piace""Mi piace"
per rena si intende intende anche la terra finemente sminuzzata. ovvero finemente lavorata (vista da un agricoltore) o terreno sciolto poco consistente, non adatto a per solide fondazioni (vista da un muratore.
Quindi aver la Rena in tasca significa avere in tasca solo della terra sminuzzata ovvero solo della polvere ( meno di così …)
Oppure significa anche aver lavorato tutto il giorno ed aver guadagnato solo la terra e la polvere che ti si è infilata nei vestiti e nelle tasche ( e siamo sempre sempre senza soldi…).
Saluti
Franco Casoni
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Franco,
credo che ogni spiegazione data alla partola rèna (in provinciia si dice rèina), abbia il senso di “poca cosa”, solo terra o sabbia.
Grazie.
"Mi piace""Mi piace"
Io avevo capito dal mo babbo che voleva dire nulla in tasca. Una famiglia o una persona che aveva ” dla rena” era estremamente povera/o . Avere della sabbia invece che soldi in tasca ?
Non capisco invece Ovduri , forse disponibilità di uova fresche e quindi buone da mangiare?
La pavena, o delle volte un smataflon … è una affermazione che conoscevo. Mi sembra di ricordare che pavena fosse considerata una botta più forte dello smataflon.
Ciao Andrea, ciao Spera.
"Mi piace""Mi piace"
Carissima,
anche per me “<vair dla rèna", significa essere in bolletta o al verde. L'ho riportato anche nella parte riguardante i detti bolognesi, quelli un po' spiegati. Intendera la rèna come sabbia è possibile, ma non riguarda, penso, i soldi.
Ovduri invece, era un famoso sberleffo di "Sganapino" quando salutava e faceva gli "auguri". Al posto della parola auguri usava dire "ov-duri" che significa uova sode. Era un gioco di parole.
Non ho mai sentito la parola pavèna, e non saprei dire che cosa sognifica. Pavàuna, invece era la gallina faraona.
Smataflon si dice ancora adesso in un italiano dialettale:smataflone, che sta per forte schiaffo.
Grazie e auguri. Spera.
"Mi piace""Mi piace"
se di zùvan ain rèsta puc di vic’ inciòn.
adlà da vic’ an si va brisa.
Non riesco a scriverlo come da dizionario, ma lo diceva la mia nonna.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Bruno
non importa se non si riesce a scrivere bene con il dialetto bolognese. Le nostre tastiere sono impreparate di fronte alle sottigliezze del nostro dialetto, tuttavia si capisce bene.
Quello che tua nonna diceva era la rassegnazione e la saggezza dei nostri vecchi:
“Se di giovani ne restano pochi, di vecchi nessuno. Al di là dei vecchi non si va”.
Grazie ancora Bruno. Come vedi pian piano si può sempre aggiungere qualcosa di bello.
Un abbraccio , Speradisole.
"Mi piace""Mi piace"
Complimenti vivissimi per il suo lavoro,
la invitiamo a visitare il nostro sito e lasciare un parere sulla “guida allo slang bolognese” che portiamo avanti da diversi mesi:
https://bolognabloguniversity.it/category/slang-bolognese
Saluti,
Bologna Blog University
il Blog degli studenti UniBO
"Mi piace""Mi piace"
Grazie, li accetto volentieri i complimenti.
Ma anch’io voglio complimentarmi con voi. Deduco che siate dei giovani che hanno interesse per il nostro dialetto. Cosa rarissima e impresa non facile, perchè il nostro dialetto è talmente particolare che a volte basta una “s” non letta con la giusta impostazione per cambiare il senso della parola. Come ad edempio “cuséin” = cuscino e “cuṡein” = cugino. Tuttavia pronunciare quella ṡ col puntino sopra, un po’ arrugginita e un po’ simile alla zeta, ma ancora esse, è molto difficile. Direi che bisogna proprio esserci nati col questo dialetto.
Il lavoro che state facendo è molto bello, anche lungo e particolare perché spiegare il senso e il significato delle parole bolognesi richiede una pazienza ed una capacità infinita.
Per ora ho visitato alcune lettere, nell’alfabeto che avete proposto, molto originale, ma leggerò con piacere anche le altre.
Complimenti vivissimi e, mi raccomando, fate “I ucc’ ed tuchén” (gli occhi di tacchino) con le ragazze, vi porteranno fortuna.
Un saluto affettuoso (av salut) da chi di anni ne ha molti di più.
"Mi piace""Mi piace"
ti premetto che i bolognesi ho imparato, col tempo e umanamente, a non sopportarli, e quello che mi infastidisce ancor più è che al cinema quando si rappresentano i romagnoli, gli si metta in bocca l’accento bolognese
"Mi piace""Mi piace"
Hai ragione,
per chi non riesce a distinguere è quasi logico che il bolognese venga sopravvalutato, ma i bolognesi, e anche i romagnoli, sanno distinguere bene.
Io, ad esempio, sono nata in un paese dell’appennino che confina col modenese e tante parole, “bolognesi”, sono pronunciate diversamente.
Qui ho voluto riportare quel tipo di dialetto bolognese antico dell’ottocento e inizio novecento che era anche un modo di distinguere il cittadino dal provinciale, ed era la catena di supporto di una trasmisione radiofonica della domenica pomeriggio “Il Pavaglione” nonchè la pronucia dei burattini Fagiolino, Sganapino e il Dottor Balanzone.
I romagnoli hanno una bella pronuncia, si distinguono subito dalla “e” stretta. Prova a dire “Robérto” (romagnolo) oppure “Robèrto” bolognese. E’ divertente.
Il cinema è generico per forza, ad esempio, in tutti i film del dopoguerra e anche oltre, quando una prostituta parlava, la pronuncia era “bolognese”, da questa pessima abitudine dei registi, si è poi sparsa la voce che le donne di queste parti, emiliane tutte, fossero donne cosiddette “facili”.
Fare di tutta l’erba un fascio è sempre un errore. Distinguiamoci per quel che siamo e ci “sopporteremo” meglio.
Grazie e un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
aiuto! Mia nonna, tanti tanti anni fa diceva “lulè viene da Monzuno” Cosa significa?
Grazie
"Mi piace""Mi piace"
Carissima “Lu lé” staccato, significa “Lui” italianizzato in “lui lì” = “Quello lì” viene da Monzuno. Forse il paese di nascita della persona che veniva indicata.
Siccome il paese bellissimo di Monzuno è un po’ in alto è come dire che era un campagnolo che scendeva in città. Magari con le scarpe grosse, ma col cervello fino.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Anche a me pare di ricordare una frase simile (dovuta probabilmente a un atteggiamento di pretesa superiorità del cittadino rispetto al montanaro).
Gli infausti eventi meteorologici di questi giorni mi fanno ricordare una frase somigliante:”È venuto giù con la piena” (Tento di tradurre nell’originale:”L’é vgnó zà con la péņna”).
"Mi piace""Mi piace"
Bravissimo. Ricordi bene.
Ciao
"Mi piace""Mi piace"
Cara Speradisole, ricordo che, alcuni anni fa, ebbi un piacevole scambio di notizie con una vostra, gentilissima, collaboratrice alla quale passai alcuni termini bolognesi e, in particolare, un racconto su BIAVATI, intrattenitore di capannelli e bolognese genuino. Mi fa piacere vedere che BIAVATI è ancora presente. Mi complimento per la cura che ponete nel vostro sito (peccato che abbiate dato spazio alla politica), ma mi permetto di fare un’osservazione della quale vi pregherei di tener conto. Ho trovato questa frase: ” A Bologna, cosa facciamo? Andiamo o stiamo?. “c s à fègna? andègna o stègna “. La parte in “dialetto” è sicuramente sbagliata. Noi a Bologna diciamo: “csa faggna ? andaggna o staggna ? “. In provincia, troviamo: “andèggna o stèggna ? “, ma fègna e stègna non esistono. Vi saluto cordialmente.
Amos Lelli
"Mi piace""Mi piace"
Signor Lelli,
In questi giorni non sono stata a casa e non ho potuto rispondere subito al suo commento.
Prima di tutto la ringrazio della sua attenzione e ricordo perfettamente quanto mi disse a proposito dell’inserto su Biavati.
Quella fu opera sua e la ringrazio ancora.
E poi le sono grata per le correzioni ed i suggerimenti. Provvederò immediatamente, a proposito di così “si dice ancora a Bologna” a correggere gli errori e a mettere ciò che viene detto nell’antico bolognese, quello vero. Quello di provincia è il mio di nascita, per cui ci saranno sicuramente altri errori, sia di calligrafia (difficile scrivere in dialetto bolognese) sia di suoni, alcuni del quali sono quasi impossibile da rendere per iscritto. Si pensi per esempio alla “s” bolognese di “cusen” (cugino) e alla “s” quasi normale di cusen (cuscino).
Ho avuto anche molti suggerimenti e molte correzioni da parte di Luigi Lepri, anzi posso dire che tutta la prima parte riguardante i detti bolognesi sono stati corretti da lui.
Io ne ho aggiunti pochi altri, anche perché le mie fonti, (persone anziane che trovo girando un po’ ed espressioni che colgo al volo), si stanno esaurendo di parecchio. Fu appunto Luigi Lepri che si offrì di correggere la maggior parte del detti bolognesi e mi insegnò a distinguere le lettere caratteristiche del bolognese “ż, ṡ,ṅna”.
La ringrazio tanto e se trova altri errori le sono molto grata.
Il blog ha un taglio un po’ particolare. Si parla di politica, perché nella mia famiglia, sin da piccola ne ho sentito parlare e perché è un argomento talmente sempre attuale che è difficile lasciar perdere. In pratica le novità sono costanti.
Un grande ringraziamento ed un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Cara speradisole, la tua risposta mi è piaciuta molto e ti ringrazio. Luigi Lepri, il mio amico più caro, mi aveva raccontato la sua “colaborazione”.
A proposito di cuscino e cugino, non è difficile renderli per iscritto, basti pensare che cugino si scrive cuṡén (con la s sonora), mentre cuscino si scrive cusén (con la s sorda).
Quando parlo di dialetto (e in dialetto) preferisco non citare la politica, in modo da non essere criticato per le mie idee politiche (o per la mia indifferenza), ma solo per il mio dialetto.
Se posso esserti utile, dimmelo senz’altro perché, parlare con te, mi piace proprio.
Ciao
Amos Lelli
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Amos,
per l’amicizia e per l’aiuto che potrai darmi.
Magari, se senti qualche altro detto intereressante lo aggiungo all’elenco e così aggiorniamo sempre il “Nostro dialetto”.
A proposito di politica, in bolognese ho scritto solo una balzelletta con il famoso “Pierino”. Era un modo di spiegare che cosa poteva essere la politica. Tuttavia anche il nostro Biavati una sottile “vena poltica” nonostante i tempi, era in grado di sfoggiarla.
Grazie e un abbraccio.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
OK, a presto, ciao
Amos
"Mi piace""Mi piace"
Grazie.
"Mi piace""Mi piace"
I miei complimenti per questa raccolta. Sono sardo, tengo moltissimo alla mia lingua ed è un piacere vedere la stessa passione in altre regioni. Le lingue ed i dialetti regionali dovrebbero essere considerati una ricchezza e non una povertà culturale. Dobbiamo andare fieri, conservarli ed insegnarli. Peraltro queste frasi in bolognese suonano benissimo. Ottimo lavoro.
"Mi piace""Mi piace"
Carisimo
grazie del complimento.
Io sono bolognese da sempre e nella mia famiglia, si parla ancora il dialetto, quando si trovano tra loro i più anziani.
Ma il nostro dialetto è quasi incomprensibile, e chi tenta di parlarlo, ma non è emiliano-romagnolo, tantomeno bolognese, si capisce benissimo che è “forestiero”.
Come se io volessi parlare sardo per farmi capire da te.
E’ vero i dialetti sono una ricchezza e ciò che appassiona e meraviglia è che quasi ogni paese, ogni campanile diciamo noi, ha un dialetto simile, ma non uguale.
In ogni modo teniamoci i ricordi è un po’ come far rivivere in queste parole i nostri nonni e bisnonni.
Grazie ancora e un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Buongiorno,
avrei bisogno di un’informazione importante. Leggendo un libro, mi sono imbattuta in un termine dialettale, che dovrebbe essere di origine bolognese, o comunque tipico dell’Emilia-Romagna. Riporto qui l’intera proposizione così forse potrete essere facilitati «è STREGNA nel manifestare i suoi sentimenti». Dal contesto deduco che possa significare ‘frigida, fredda’ o per lo meno ‘restia nel dimostrare l’affetto’. Qualcuno mi saprebbe dire se mi sto sbagliando? O comunque qual è il reale significato?
Vi ringrazio tantissimo.
Chiara
"Mi piace""Mi piace"
Sì, ha ragione.
Ma può significare anche proprio “stretta” “chiusa”, di “carattere ombroso”. E anche diffidente. Sostanzialemnte una donna difficile da capire.
Riflette un po’ il carattere chiuso e restio di alcune nostre nonne.
Comunque è una mia interpretazione. Potrebbe rivolgersi al dizionario bolognese scritto da Luigi Lepri, per maggior precisione.
Grazie, un saluto
"Mi piace""Mi piace"
Grazie infinite per le precisazioni e per il consiglio. Cercherò di consultarlo subito (ovviamente se esiste una versione online).
Colgo l’occasione per fare anche io i complimenti per questa interessante e importante iniziativa di raccogliere le “parole del cuore”: i dialetti raccontano la vita in modo originale ed efficace. Anche io come Alex (commento precedentemente al mio) sono sarda, e capisco perfettamente la valenza che i dialetti hanno nelle comunità.
Un saluto. Chiara
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Chiara.
Un saluto ed un abbraccio da Bologna.
"Mi piace""Mi piace"
Sto scrivendo un libro giallo ambientato sul confine tra Emilia e Veneto. Potete confermarmi questa espressione “Tótt i quaión!” con significato di “adesso capisco!” o qualcosa del genere e chiaro riferimento triviale? Grazie per l’aiuto. Purtroppo, innamorato della cadenza dialettale e della musicalità della vostra lingua sono troppo lontano per tentare di imparare qualcosa e soprattutto di tentare la parlata. Ma apprezzo moltissimo chi si occupa della conservazione dei dialetti. Un grazie anticipato Federico Maderno
"Mi piace""Mi piace"
Carissimo
Tótt i quaión! Frase che hai scritto anche con gli accenti giusti, è una frase “volgare”, ma per gli abitanti dell’appennino emiliano veneto, o emiliano toscano, non è poi molto pesante. Significa “Tutti i coglioni”. Cioè tutti coloro che, o sono creduloni, o si lasciano prendere in giro, insomma quelli un po’ “ritardati”.
Di un giocatore di calcio che non riesce a fare gol quando è da solo davanti alla porta dell’avversario, che è anche senza portiere, si dice che è un coglione.
Ciao e auguri per la tua opera.
"Mi piace""Mi piace"
Grazie per “l’assistenza”. In realtà, ho già scritto un romanzo ambientato a Bologna, con alcune particolarità interessanti relative al Cimitero della Certosa che sono state una piccola scoperta anche per qualche studioso locale. Spero un giorno di poter vedere tutto di persona. Per ora, ho approfittato della gentilezza di alcuni bolognesi dei quali sono diventato amico. Se ti fa piacere, ti invio volentieri una copia omaggio del libro (mi basta un indirizzo di posta ordinaria). Puoi leggere qualcosa qui: https://granfoffo.wordpress.com/2019/07/25/de-profundis-clamabo/ e per inviarmi il recapito: federicomaderno@gmail.com
Grazie ancora.
"Mi piace""Mi piace"
Ne sono onorata. Grazie.
Ti mando l’indirizzo della posta ordinaria tramite la mail che leggo nel tuo commento.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Non ho ricevuto niente tramite la mail…
"Mi piace""Mi piace"
Fatto.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
esiste un detto bolognese “sembra che dorma ma sonnecchia” ?
grazie
"Mi piace""Mi piace"
Purtoppo una definizione corretta di questo tipo di atteggiamento, non lo conosco in dialetto bolognese.
Mio nonno però mi diceva che, quando una persona non si sentiva bene, non riusciva tenere gli occhi aperti, forse anche per stanchezza, ma non dormiva, appunto sonnecchiava, diceva che aveva “la lornia”.
Ma temo che non sia la parola giusta.
Grazie Giacomo.
P.S. Penso che tu possa rivolgerti a Luigi Lepri, un grande intenditore di dialetto bolognese, non solo antico. E’ noto anche per aver pubblicato un dizionario sul dialetto bolognese. A me ha corretto tutta la “scrittura” del mio Antico dialetto bolognese. E’ molto disponibile.
Ciao.
"Mi piace""Mi piace"
una domanda, come si dice ” pomeriggio” in dialetto bolognese? grazie anticipatamente e cordiali saluti
"Mi piace""Mi piace"
Tieni presente che io sono di Castello di Serravalle ed ho una cadenza un po’ diversa dal vero Bolognese antico.
Comunque da noi ci dice: “dopmezdé”, oppure “dapmezdé” a seconda della vicinanza col modenese.
Saluti cari anche a te.
"Mi piace""Mi piace"
Salve, in alcuni film, come *hanno rubato un tram” ambientato a Bologna, sento l’espressione “marino” (se ho capito bene), cosa significa? Grazie
"Mi piace""Mi piace"
Mi dispiace Annamaria, ma non onosco l’espressione “marino” come un detto bolognese. L’ho chesto anche ai miei parenti bolognesi, ma nessuno conosce “marino” come parola particolare del bolognese. Penso di farti cosa gradita inviandoti l’indirizzo dove puoi trovare i libri di Luigi Lepri. Te lo consiglio fortemente se ami il dialetto di casa nostra, antico o attuale che sia. Un abbraccio .
Federica Rapini
Edizioni Pendragon
via Borgonuovo 21/a
40125 Bologna Bo – Italy
tel. 0039 051 267869
cell. +39 335 8499879
http://www.pendragon.it
"Mi piace""Mi piace"
Correzione: la guazza è la rugiada, la brina si chiama “galaverna” almeno dalle mie parti (Borgo Panigale) ma così diceva anche mio padre che era nato fuori di S. Vitale.
"Mi piace""Mi piace"
La brina (bréina) è una gelata modesta che si forma sull’erba in alcune giornate fredde quando in terra c’è umidità sufficiente. La galaverna (galavérna) si forma sui rami degli alberi che vengono letteralmente ricoperti di uno strato di ghiaccio trasparente. Sono due fenomeni “di freddo” diversi. La guazza c’è quando l’erba non reca alcun segno di gelo.
Grazie e ciao.
"Mi piace""Mi piace"
A Bologna non ci sono le albicocche, ci sono al mugnèg (non so come si scrive)
"Mi piace""Mi piace"
Si mugnégh, sono le albicocche. Ma il dialetto bolognese è molto bizzarro e basta cambiare casolare perché alcune cose cambino di nome. Per esempio le fragole, in bolognese si dice “frèvel”, in periferia verso il modenese “frèval” , in periferia verso Tolé – Vergato si dice “froll”. Come vedi a ognuno la sua lingua particolare. Nell’articolo che ho inserito ho messo -L’antico dialetto bolognese – che nel tempo si sarà modificato.
"Mi piace""Mi piace"
Ohi! Noto la mancanza di alcuni termini fondamentali!!
Il famosissimo “osvëi”, l'”osviglio”!
E che dire del sandrone?
Poi, la broda, nel senso di benzina!
E come non citare la “bronza”?
E il cioccapiatti!
Ma anche “ciocco” o “busso” come incidente, o anche “cioccato” nel senso di rotto!
E sgurare, per pulire!
Poi va aggiunto il “cartone” nelle parole dal significato diverso (cazzotto)
viva Bulaggna!
"Mi piace""Mi piace"
Mille grazie, provvederò ad aggiungerli.
Te ne sono grata, ma le mie fonti stanno sparendo un po’ tutte, per “vecchiaia”.
Un abbraccio
"Mi piace""Mi piace"
Io mi ricordo una pronuncia più o meno “usvéi” (singolare e plurale) Antonio Villani
"Mi piace""Mi piace"
E si “gli attrezzi” di lavoro, generalmente plurale, ma valido anche per un solo attrezzo.
Fino ad alcuni anni (parecchi forse) fa si sentiva al mercatino parlare di “tamarazzi”. E una volta ho sentito anche dire che le mucche “mutolano”, o che ho tenuto in mano il “tiino”, ma il manico bruciava. Alcune battute me le ero appuntate, ma tante le ho perse.
Ciao un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"
Già, anch’io mi ricordo “tamaràz” (e, per una ‘quasi-rima’, mi viene in mente pure “butaràza”, che usava sessant’anni fa una nativa dei Forcelli a S. Giovanni in Persiceto, per indicare un rospo o qualcosa di simile).
"Mi piace""Mi piace"
E’ verissimo. Grazie, un grosso rospo o rospa era la butaràza. A proposito di utensili o attrezzi, nella parte del dialetto bolognese antico, dove ho raccolto i vari detti in capitoletti, cercando di spiegarli, a proposito della Morte”, che non veniva mai pronunciata, si usavano similitudini. Una di questa è “Quando uno moriva dicevano: «L à pighè i uṡvei” oppure «L à pighè i tvajû» (Ha piegato i tovaglioli).
Ce ne sono parecchi di questi brevi capitoli.
Un abbraccio.
"Mi piace""Mi piace"